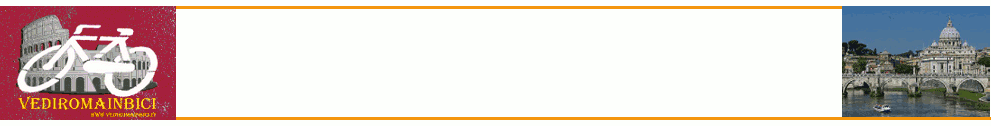Foto e Schede 2015
Le catacombe sono luoghi di grande fascino nell’immaginario collettivo, sono viste come luoghi di mistero per gli anni delle persecuzioni dei cristiani, per il mistero stesso dell’oltretomba. Un esempio di tale fascino romantico si trova in musica nei “Quadri di un’esposizione” di Modest Musorgskij, nel film “Mission Impossible III” del 2006 nel quale i protagonisti giungono in Vaticano attraverso le grotte.
COSA SONO LE CATACOMBE
Le catacombe (dal greco “presso le grotte”) sono cimiteri sotterranei tipici delle prime comunità cristiane (ma ve ne sono anche ebraici), erano costituite da una serie di gallerie su più livelli nelle quali si aprono camere sepolcrali. Le salme erano deposte in loculi scavati in file verticali sia nelle pareti delle gallerie sia nelle piccole camere sepolcrali dette cubicoli, come la cripta dei Papi nelle catacombe di Callisto a Roma.
Il nome deriva da un comple sso cimiteriale presso l’attuale basilica di San Sebastiano sull’Appia Antica, veneratissimo nei primi tempi del cristianesimo per esservi stati sepolti i corpi di Pietro e Paolo per un breve periodo. Nelle vicinanze si trovava il cimitero ufficiale della Chiesa romana da papa Zefirino in poi, le catacombe di Callisto, con le tombe dei papi del III e IV secolo.
Erano luoghi di sepoltura e di preghiera, non erano luoghi di rifugio dei cristiani.
Oltre che a Roma vi sono catacombe a Napoli, Siracusa, Malta e in Africa settentrionale, dove il terreno di tufo si prestava ad essere scavato. I loculi erano chiusi con lastre di marmo o mattoni e potevano contenere anche due/tre corpi. Alcune erano sormontate da una nicchia detta arcosolio. Le decorazioni sono riferite al Vecchio e al Nuovo Testamento, vi sono pitture di miti pagani ai quali era stato dato un nuovo valore simbolico (ad es. Orfeo, Amore e Psiche). Resti di mosaici si sono conservati nelle catacombe di Ermete e di Priscilla, in quelle napoletane. La scultura è presente sui sarcofagi. Non mancano vetri, avori, lucerne e ampolle. A papa Damaso (366-84 portoghese, sepolto in San Lorenzo in Damaso, palazzo della Cancelleria) si deve la ricerca delle catacombe e la loro monumentalizzazione.
Tra il VII e il IX secolo furono sempre più frequenti le traslazioni dei corpi dei martiri e dei santi dalle catacombe alle chiese presenti nel centro della città, per questo motivo le catacombe furono abbandonate. Iniziò il loro culto con san Filippo Neri nel Cinquecento, mentre lo studio scientifico e la loro protezione si ebbe nell’Ottocento con Marchi e De Rossi. Con l’unità d’Italia tale processo si è intensificato.
Le più famose e visitate catacombe di Roma sono quelle di San Callisto e San Sebastiano entrambe sull’Appia Antica, le catacombe di Domitilla lunga la via Ardeatina (via delle Sette Chiese 282) e le catacombe di Priscilla sulla Salaria. Anche le catacombe di Sant’Agnese sono aperte al pubblico (via Nomentana 349).
CATACOMBE DI SAN VALENTINO
(viale Maresciallo Pilsudski)
La basilica fu voluta da papa Giulio I nel V secolo e poi ampliata nell’VIII. Accanto alla basilica esisteva un monastero nel quale si rifugiavano pescatori del fiume e vignaioli della zona quando la città era minacciata da scorrerie. Al di sotto dei ruderi è l’ingresso alla catacomba. Intorno al sepolcro del vescovo di Terni venne elevata la basilica. Dalla zona provengono sarcofagi e iscrizioni che vanno dal 318 al 523, anche un frammento lapideo di un carme in onore di san Valentino. La galleria più antica venne allargata per farne una cappella e ornata di pitture del secolo VII di cui restano oltre all’immagine della Madonna con il Bambino anche tracce di una Crocifissione. Dal Cinquecento alcune gallerie furono adattate a grotte e utilizzate per il deposito di botti di vino. Secondo una delle tante leggende urbane una galleria di queste catacombe raggiunge quelle delle catacombe di Priscilla sulla via Salaria.
San Valentino (Terni 176 – Roma 273) era un vescovo romano martire sotto l’imperatore Claudio il Gotico. E’ venerato come santo dalla chiesa cattolica, ortodossa e anglicana; è il patrono degli innamorati e protettore degli epilettici. Le più antiche notizie su Valentino ci giungono dal Martyrologium Hieronymianum (documento del V-VI secolo) e nella Passio Sancti Valentini dell’VIII secolo che parla del martirio per decapitazione dopo tortura e della sua sepoltura a Terni. Non si è certi se si tratti della stessa persona, cioè del presbitero Valentino martire a Roma prima del 270 anno della morte di Claudio il gotico e sepolto in queste catacombe. Alcuni storici ritengono che quest’altro Valentino non sia mai esistito. La tradizione vuole che mentre Valentino era in prigione si innamorò, ricambiato, della figlia cieca del carceriere, allora Valentinò – dopo averla convertita al cristianesimo e averla battezzata gli ridiede miracolosamente la vista. Prima di avviarsi al patibolo avrebbe firmato un messaggio d’addio con le parole “vostro Valentino”.
CATACOMBE DI MASSIMO O SANTA FELICITA
Via Simeto 2
(in fondo alla via, sulla sinistra,
quasi a piazza Benedetto Marcello)
Derivano il nome dal proprietario del terreno di nome Massimo. Il cimitero era costituito da una vasta rete di gallerie e di due basiliche poste su due piani e collegate con una scala, secondo la tradizione la tomba di Felicita era collocata nella basilica superiore. Le costruzioni moderne hanno chiuso parte delle gallerie. Si conserva la basilica minore decorata con un dipinto riferibile al VII secolo in cui è raffigurato il Redentore nell’atto di benedire Santa Felicita[1]. Nei sotterranei un tratto dell’acquedotto Vergine[2] che probabilmente alimentava una vasca con funzione di battistero.
Via Simeto termina in largo Benedetto Marcello, qui era il cinema Holiday, purtroppo, dopo sette anni di abbandono, nell’agosto 2014 è diventato un supermercato. Procedendo per via Salaria in direzione Nord, superato il grande incrocio con viale Regina Margherita/viale Liegi, si procede ancora su via Salaria, all’angolo con via Yser si trova la banca Mediolanum (vedi sotto cimitero di Trasone), si procede ancora per via Salaria, al prossimo incrocio a sinistra in viale di villa Grazioli, tra questa e via Bruxelles, si trova quello che rimane di villa Grazioli, la sua storia è legata al maresciallo Badoglio. Il conquistatore di Addis Abeba la ottenne come premio e la preferì ad un palazzo del centro storico. La villa è stata realizzata su progetto dell’arch. Busiri Vici. Una parte è stata lottizzata, un’altra è occupata dall’ambasciata del Canada, un’altra ancora è diventata villa pubblica.
CIMITERO DI TRASONE
Via Salaria 223
(botola davanti all’ingresso di Banca Mediolanum,
angolo via Yser)
Si sviluppa sulla sinistra della Salaria con una rete di gallerie profonda cinque piani così da essere considerato il cimitero più profondo di Roma. E’ ricordato dalle fonti anche come ad San Saturninum e per la sepoltura di molti martiri, tali tracce non sono state trovate.
CIMITERO DEI GIORDANI
Via Anapo 2/4
Percorrendo la Salaria, costeggiando villa Ada,
si passa il primo ingresso
(quello con casetta rossa, quasi di fronte a via di villa Ada,
la seconda traversa di via Salaria (ovviamente a destra) è via Anapo,
la porta della catacomba è
all’inizio della strada, sulla destra.
Venne messo in luce una prima volta nel 1578 e successivamente nel 1921, il nome sembra essere in relazione con il fiume Giordano. Qui si veneravano tre dei sette figli di Santa Felicita, i martiri Marziale, Vitale e Alessandro. Ma di nessuno di loro è stato rintracciato il sepolcro. Le catacombe si sviluppano su due piani di gallerie strutturate a grandi nicchioni ad arco digradanti fino al pavimento. Le pitture risalgono al III e IV secolo con scene riferibili al Vecchio e al Nuovo Testamento. Secondo i testi ospitavano i corpi dei martiri e santi coniugi: Crisanto e Daria[3]. Oggi i loro corpi si trovano nella cripta del duomo di Reggio Emilia.
CATACOMBE DI PRISCILLA
Via Salaria 430
prima dell’incrocio con via di Priscilla.
Tra le più antiche e vaste di Roma, il nome deriva da una matrona di una potente famiglia patrizia imparentata con Manio Acilio Glabrione console nel 91 accusato e forse condannato per la sua fede cristiana. Le catacombe di Priscilla si dispongono su due piani, al primo si è riconosciuto il nucleo più antico, formato da tre ambienti, appartenente dal II secolo, originariamente dotati di ingressi indipendenti. L’ambiente più importante, detto cappella greca, per la presenza di scritte in rosso a caratteri greci. Qui pitture e stucchi del Vecchio Testamento: l’arca di Noè, il Sacrificio di Abramo, il Miracolo della fonte, i tre fanciulli di Babilonia, Daniele tra i leoni.
Sono visitabili, hanno un regolare orario di ingresso.
CIMITERO DI PANFILO
Via Paisiello dopo il civico 24 b
presso chiesa santa Teresina
è la prosecuzione di via Pinciana verso via Rossini
Si trova lungo il tracciato della Salaria Vetus. Dalle fonti sappiamo che qui si veneravano, oltre a Panfilo, i martiri Candido e Quirino. Il cimitero è stato identificato nel 1920 quando è stato costruito il quartiere. Il cimitero era formato da un’area cimiteriale sopraterra, di cui restano solo frammenti epigrafici, e il cimitero ipogeo costituito da gallerie scavate nel tufo, a tratti sostruite in muratura, che si articolano su tre livelli.
IPOGEO DEI PUPAZZI
Via Paisiello 53
Praticamente, alla fine della strada, quasi a via Rossini.
Vi si accede da una botola situata nella moderna carreggiata stradale.
I primi esploratori pensavano che si trattasse di una parte del cimitero di Panfilo. Invece si tratta di un’area sepolcrale a carattere privato, quindi appartenuta a una o più famiglie. Presenta una galleria principale sulla quale si aprono diversi cubicoli. Nel cubicolo A vi sono decorazioni pittoriche sia geometriche sia a soggetti di caratter biblico eseguiti con la tecnica dell’affresco.
CIMITERO DI ERMETE
Via Bertoloni 3
In prosecuzione di via Paisiello, all’inizio della strada,
di fronte alla residenza dell’ambasciatore americano.
Le gallerie si estendono fino a piazza Pitagora. Si articolano su due livelli, il loro accesso era dalla Salaria Vetus, si sviluppò a partire dal III secolo, continuando a sfruttare spazi funerari precedentemente occupati dai pagani. Gli itinerari di epoca medioevale parlano di diversi luoghi di culto dedicati ai martiri di cui si è persa la traccia. La pratica delle traslazioni dei corpi dei martiri dal IX secolo non comportò l’abbandono del sito che continuò ad essere frequentato almeno fino al XIII secolo.
COEMETERIUM MAIUS e Minus
Via Asmara 6
Vicinissimo a via Nomentana villa Leopardi
Nell’area di una villa suburbana, nel 1961, venne scoperta questa catacomba del III secolo su due livelli. Il Martirologio Geronimiano ricorda in questo cimitero la deposizione di Vittore, Felice, Alessandro, Papia, Mauro tutti soldati convertiti al cristianesimo secondo la Passo Marcelli del V secolo, ed Emerenziana[4], ricordata anche dalla Passio Agnetis del V secolo come sorella di latte di Agnese.
Nelle vicinanze si trova piazza Sant’Emerenziana con la chiesa parrocchiale omonima.
Caratterizzato da cubicoli monumentalizzati, ornati da modanature, nicchie e mensole intagliate nel tufo. La regione detta “delle cattedre”, posta a sud ovest dell’originario nucleo, prende il nome dalla presenza di banconi e cattedre scavate nel tufo. Questo è legato all’uso del “refrigerio”, che prevedeva la consumazione del cibo con il defunto, frutto di una comunità ancora imbevuta di credenze pagane. La tradizione poneva in questa catacomba la “cathedra Petri”, dalla quale San Pietro impartiva il battesimo.
Il Ceometeterium Minus si trova la civico 222 sempre di via Asmara. Scoperto nel
Seicento e chiamato fino a tempi recenti di “Vigna Roselli”. In epoca moderna i due cimiteri sono stati uniti da un corridoio sotterraneo. Di questo cimitero si conoscono solo alcune gallerie, le altre sono impraticabili a causa dei fondamenti dei palazzi.
Le catacombe si trovano nel perimetro di villa Leopardi. Villa signorile ottocentesca dei conti Leopardi Dittajuti, si estende su una superficie di 19.500 mq, luogo di villeggiatura della nobile famiglia romana imparentata con il grande poeta Giacomo Leopardi di Recanati. Attualmente l’edificio padronale in stile neo-medioevale, è in abbandono. Il parco fiancheggiato da moderni muretti ha completamente perduto l’aspetto originario che si è progettato di recuperare. In due edifici minori hanno sede la biblioteca comunale con ingresso da via Makallè e il Centro Anziani del II municipio. Nel 1975 il complesso è stato espropriato dal comune e destinato a parco pubblico. L’edificio principale è stato adibito, fino al 2000 a sede di uffici di circoscrizione che gli ha fatto perdere le caratteristiche residenziali per cui era nato.
CATACOMBA DI SANT’IPPOLITO
Via dei Canneti
Vi si accede da una traversa di viale Ippocrate, via Ercole Pasquali.
Alla fine della strada si trova un sentiero,
un cancello non permette di proseguire, l’ingresso
della catacomba è oltre sulla destra.
Si sviluppa su cinque livelli riutilizzando in parte cunicoli idrici, è quasi del tutto inaccessibile. I due livelli inferiori sono invasi dall’acqua, è visitabile solo un corridoio centrale, che è stato sconvolto dalla costruzione di un santuario nel luogo in cui è stato seppellito il santo/martire. Ippolito è stato identificato con l’antipapa avversario di Callisto, esiliato e ucciso in Sardegna intorno al 235. Il santuario si deve a papa Damaso.
Nella catacomba venne scoperta la statua di Sant’Ippolito a grandezza naturale e in ottimo stato di conservazione. La scoperta avvenne nel 1533, oggi è conservata all’ingresso della Biblioteca Vaticana.
Nella vicina viale delle Province si trova la chiesa parrocchiale di Sant’Ippolito.
CATACOMBA DI NOVAZIANO
Viale Regina Elena 303
La catacomba si articola su due livelli, di cui quello superiore fu distrutto nel 1926 per la realizzazione di viale Regina Elena. Venne costruita nel III secolo partendo da un’area sepolcrale pagana. Qui fu deposto il martire Novaziano identificato in base all’iscrizione dipinta. Novaziano era stato fondatore di una chiesa indipendente e di un movimento contrario ai “lapsi”, i cristiani che durante la persecuzione di Decio (248-251) avevano rinnegato la fede. Lo scioglimento della comunità e la confisca dei beni dei novazianisti, da parte dei papi Innocenzo I e Celestino I, fu probabilmente la causa del brusco abbandono del cimitero agli inizi del V secolo.
CATACOMBA DI SAN LORENZO O DI CIRIACA
Piazzale del Verano
L’ingresso è dall’abside della chiesa o dal chiostro.
La catacomba risale al III secolo e venne realizzata nel colle Verano, è stata in parte distrutta dal moderno cimitero che ne ha compromesso la comprensione e ridotto le parti percorribili ora accessibili dal chiostro della basilica di San Lorenzo e dalla chiesa stessa.
Il cimitero, detto in agro Verano, dal VI secolo prese questi due nomi perché vi venne sepolto Lorenzo, venerato il 10 agosto, diacono di papa Sisto II, fu sottoposto al supplizio della graticola roventata all’epoca della persecuzione di Valeriano (258) e sepolto nel terreno della vedova Ciriaca.
Il culto di Lorenzo ebbe un notevole sviluppo nel V secolo tanto che tre pontefici (Zosimo, Sisto III e Ialaro) si fecero seppellire presso la sua tomba. Visto il grande afflusso di pellegrini, vicino ad esso furono costruiti ospizi per i poveri, chiese, battisteri, terme e una biblioteca.
Nella catacomba, articolata su cinque livelli, è presente un cubicolo con pavimento di marmo, trasformato successivamete in ambiente a L con pareti in muratura che presenta un pilastro centrale come sostengo del soffitto in tufo e nicchie su un lato. Qui venne ricavata una tomba di piccole dimensioni. Su di essa venne ricavato un pozzo per permettere la visione della tomba dall’alto. La tomba di Lorenzo venne monumentalizzata da Costantino, con una parte in porfido, una grata in argento e altro.
CATACOMBE DI PRETESTATO
Via Appia Pignatelli 1
Si trova nella zona dell’Appia Antica. Ebbe un momento di celebrità quando nel 1830 vi si scopersero pitture del II secolo fra cui uno dei primissimi Battesimi di Cristo. Vi furono sepolti San Gennaro (non quello di Napoli), San Felicissimo e Sant’Agapito, tutti martiri.
CATACOMBE DEI SANTI PIETRO E MARCELLINO
Via Casilina 643 presso l’omonima parrocchia
Siamo sulla via Casilina dopo Tor Pignattara, nel punto in cui si trova il Mausoleo di Elena. Fu giudicata addirittura la più ricca di Roma per le sue pitture. Nel marzo del 2014 sono terminati importanti lavori di restauro, da allora sono aperte ogni sabato e domenica. Le catacombe sono le terze di Roma per estensione, sono stati restaurati i due terzi dei cubicoli e tutti gli affreschi. Una rappresentazione del V secolo del Cristo con gli apostoli Pietro e Paolo insieme a tutti i martiri sepolti nelle catacombe da Pietro e Marcellino a Tiburzio e Gorgonio. Splendida la figura di Orfeo dipinta nella lunetta di un arcosolio dove il mito pagano è riletto in chiave cristiana. Nella chiesetta dentro il mausoleo la soprintendenza ha creato un piccolo museo con oltre 200 testimonianze archeologiche come la stele delle tombe degli equites singulares, le guardie a cavallo dell’imperatore, che nella battaglia di ponte Milvio si schierò con Massenzio e ebbero la damnatio memorie.
ULTIMO AGGIORNAMENTO 12.4.14Mausoleo di Elena e catacombe dei Santi Marcellino e Pietro. Riaprono domani dopo i restauri. Saranno aperte ogni sabato e domenica, le catacombe sono le terze di Roma per estensione, sono stati restaurati i due terzi dei cubicoli e tutti gli affreschi. Una rappresentazione del V secolo del Cristo con gli apostoli Pietro e Paolo insieme a tutti i martiri sepolti nelle catacombe da Pietro e Marcellino a Tiburzio e Gorgonio. Splendida la figura di Orfeo di pinte nella lunetta di un arcosolio dove il mito pagano è riletto in chiave cristiana. Nella chiesetta dentro il mausoleo la soprintendenza ha creato un piccolo museo con oltre 200 testimonianze archeologiche come la stele delle tombe degli equites singulares, le guardie a cavallo dell’imperatore, che nella battaglia di ponte Milvio si schierò con Massenzio e ebbero la damnatio memorie.
CATACOMBE DI SAN NICOMEDE
Via dei Villini 32
Piccola, a due piani, uno dei quali scavato nell’arenaria, è considerata tra le più antiche di Roma. Il cimitero originariamente era un ipogeo privato che riutilizzava precedenti cunicoli idrici di una grande villa romana. La vasta necropoli è andata distrutta con la costruzione dei villini all’inizio del Novecento. Nicomede era un prete dell’epoca di Domiziano, martirizzato dopo il 96, il suo discepolo Giusto ne raccolse le spoglie e le dopose in questo luogo. Sopra il sepolcro, riccamente decorato con marmi, venne costruito un oratorio nel VII secolo in cui furono traslate le spoglie di Nicomede prima di essere portate in Santa Prassede da papa Pasqule I.
CIMITERO DI GENEROSA
Via delle Catacombe di Generosa (Magliana Vecchia)
Si trova dove erano i boschi dei Fratelli Arvali. In una piccola basilica eretta da papa Damaso e nell’adiacente cappella dei Martiri si trovano le sepolture dei Santi martiri Simplicio, Beatrice e Faustina, alle pareti si intravedono resti di pitture.
IPOGEO DI VIA LIVENZA
Via Livenza (presso piazza Fiume)
Sorge all’interno del grande Sepolcreto Salario, scavato alla fine dell’Ottocento. Nel 1923 scavi per la costruzione di una palazzina portarono alla scoperta del sito, ma portarono alla distruzione di gran parte dell’antica costruzione. E’ datato concordemente alla seconda metà del IV secolo, ma nessun elemento ne spiega la reale funzione. L’ipogeo era a pianta allungata, composto di un’aula principale absidata e alcuni ambienti secondari. All’ipogeo si accede grazie ad una scala antica. Nella parte settentrionale si aprono tre archi, qui si trova una vasca rettangolare separata da una transenna marmorea che veniva riempita d’acqua da un tubo che fuoriusciva dal muro. Al di sopra è presente una decorazione a mosaico di cui restano alcuni frammenti. Vi si può vedere San Pietro che come Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia per battezzare il centurione convertito. Nella parete di fondo è un affresco imitante l’opus sectile e nel catino absidale è dipinto un kantharos su cui posano colombe. Accanto è la figura di Diana cacciatrice che si accinge a saettare due cervi e ancora una ninfa che accarezza un capriolo. La coesistenza tra soggetti pagani e cristiani e la presenza della vasca fece pensare che l’ipogeo fosse una sorta di santuario sincretistico di culti tanto pagani che cristiani, utilizzato da un gruppo iniziatico a noi sconosciuto. Altri pensano si tratti solo di una fontana monumentale. Altri ancora avanzano l’ipotesi di un luogo di culto dedicato alla dea tracia Cotys, o di un antico battistero. Un bollo di mattone data il tutto al IV secolo.
CATACOMBE DI COMMODILLA
Via Giovannipoli (Garbatella)
Luogo di sepoltura dei martiri Felice e Adautto, fratelli di papa Damaso. Da una cronaca del tempo sembra che questo Adautto sia un ignoto che si è voluto unire al sacrificio di Felice avendolo incontrato casualmente mentre era diretto al martirio (Adautto = aggiunto). Il nome delle catacombe derivano da quello della proprietaria. Comprendono una basilichetta ipogea del IV sec. con scene bibliche, un Cristo orientale e le effigi di San Felice e Sant’Adautto. Nelle catacombe è presente una celebre iscrizione incisa nella cornice di un affresco nella cripta dei santi Felice e Adautto. Il graffito occupa un posto importante nella storia della lingua italiana dal momento che rappresenta la testimonianza di una lingua intermedia tra il latino e il volgare. Il testo è il seguente: “Non dicere ille secrita a bbocce”, cioè “Non pronunciare i segreti a voce (alta)”. Si tratta di orazioni segrete che dovevano essere pronunciate a voce bassa.
Il luogo è stato adottato dagli alunni della Scuola Media Statale Giuseppe Moscati di via Macinghi Strozzi (da Scuola adotta un monumento 2005/07, ed. Palombi).
CATACOMBE DEI SANTI PROCESSO E MARTINIANO
Via Aurelia Antica 3
Secondo la leggenda Processo e Martiniano sarebbero stati i carcerieri di San Pietro, martirizzati dopo la crocifissione di San Pietro e decapitati sull’Aurelia. Furono sepolti da una matrona di nome Lucina. L’ubicazione del cimitero è controversa, dovrebbe essere all’interno di villa Pamphili dove si trovano diversi ipogei e dove è stata trovata una iscrizione che allude alla festa di Processo e Martiniano.
CATACOMBE DI CALEDOPIO
Via del Casale di San Pio V 15
Le fonti tramandano che Calepodio era un prete gettato nel Tevere sotto Alessandro Severo e sepolto da papa Callisto nel cimitero dell’Aurelia. In seguito qui verrà sepolto il papa stesso e, nel IV secolo papa Giulio I che vi fece erigere una basilica. Il corpo di papa Callisto venne portato nella basilica di Santa Maria in Trastevere. Restano l’abside dell’antica chiesa sorta sopra la catacomba e tracce di un lecernaio.
CATACOMBA DI PONZIANO
Via Alessandro Poerio 57 a Monteverde Vecchio
Si trova all’interno dell’Istituto per la Dottrina Cristiana. Nel cimitero erano sepolti diversi martiri tra cui i nobili persiani Addon e Sennen, uccisi durante la persecuzione di Decio a metà del III secolo. Il culto dei due martiri fu molto popolare fino all’VIII secolo. Alle catacombe originarie del III secolo se ne aggiunsero altre nel periodo di Diocleziano. Allora vennero eretti due oratori, uno in onore di Santa Candida, l’altro intitolato ai due Santi, quest’ultimo doveva contenere il sepolcro dei due martiri. Nella parte centrale si trovano pitture in stile bizantino del VI secolo, nella cripta il sarcofago in mattoni di Adfon e Sennen. Il sotterraneo racchiude anche un battistero.
CATACOMBE DI SANT’AGNESE
Via Nomentana 349 (sotto la basilica stessa)
Il martirio della santa avvenne perché rifiutò di sposare il figlio del prefetto. Dopo essere stata esposta in un luogo infame, gettata su una catasta ardente senza essere toccata dalle fiamme, la martire fu uccisa con un colpo di spada e il corpo venne deposto in questo luogo dai parenti dove avevano un terreno di loro proprietà. Il luogo del supplizio fu nell’attuale piazza Navona.
L’area cimiteriale è anteriore alla deposizione della santa. Nel IV secolo venne costruita sopra la tomba della santa una basilica con il tetto sporgente dal terreno che poi venne restaurata e ampliata più volte.
Il cimitero si articola su tre piani in quattro regioni: l’area primitiva, a sinistra della basilica, è anteriore al III secolo, vi sono due gruppi di gallerie che risalgono al quarto secolo, uno di questi mette in comunicazione Sant’Agnese con Santa Costanza. Il complesso è privo di pitture.
CATACOMBE DI SANT’ERMETE O SANTA BASSILLA
Via Bertoloni 13
Bassilla era una martire romano o la proprietaria del luogo. Qui venne costruita una grande basilica semipogea dedicata a Sant’Ermete, martire greco del III secolo. Si tratta dell’edificio sotterraneo più grande di Roma, fu voluto da papa Damaso e restaurato da Adriano I nell’ottavo secolo. E’ scavato nel tufo. Quando il corpo del santo venne portato nella chiesa di San Marco, il luogo venne sostituito da un oratorio in superficie. Nell’abside dell’oratorio si trova un affresco del nono/decimo secolo raffigurante Il Salvatore, la Vergine col Bambino in trono affiancati dagli arcangeli Gabriele e Raffaele e dai Santi Ermete, Benedetto e dall’Evangelista Giovanni. La tomba del santo doveva essere dinanzi all’abside sotterranea mentre la cripta doveva contenere la tomba di qualche altro martire, forze della stessa Bassilla.
Le catacombe si sviluppano su due piani che conservano affreschi e iscrizioni. Dall’ingresso della basilica si diramano delle gallerie, una delle quali conduce a un arcosolio con una insoltia pittura raffigurante i Due martiri locali nell’atto di condurre il defunto al tribunale di Cristo.
CATACOMBA DI VIA DINO COMPAGNI
Via Latina 258
Si tratta della catacomba più importante del periodo tardo antico. Venne scoperta nel 1955 a seguito dei lavori di costruzione del palazzo sovrastante (via Latina 258) che causarono lo sfondamento di molti soffitti antichi , mentre accanto ai piloni antichi si trovano quelli moderni. Si trova a 16 metri sotto il livello stradale, la galleria principale è lunga 50 metri. L’indagine archeologica venne condotta dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra per cui la scritta sul tombino. In essa si alternano pitture con episodi biblici (L’arrivo in Egitto della famiglia di Giacobbe, Mosè che batte la rupe, Il sacrificio di Isacco, Il passaggio del mar Rosso) ad altri pagani (La morte di Cleopatra). In una bella sala rotonda vi sono colonne, capitelli dipinti, mensole, decorazioni floreali e vegetali e scene di vita pastorale. In un cubicolo Sansone in lotta con i leoni e Adamo ed Eva con il serpente. In una sala quadrangolare vi è il mito di Eracle, nella volta puttini ed eroti alati. Nell’ultimo cubicolo sono riproposte scene del Vecchio e Nuovo Testamento come: La Resurrezione di Lazzaro, Il passaggio del Mar Rosso e Noè nell’Arca. Era una catacomba privata realizzata nei primi decenni del IV secolo, in quell’età di passaggio quando il Cristianesimo fu accettato. Ampia la descrizione che ne fa Argan nella sua storia dell’arte.
SEPOLCRO DI SAN PAOLO
Via Ostiense 186
Il corpo di San Paolo fu sepolto nella proprietà della matrona Lucina. Intorno al 258 le sue spoglie con quelle di San Pietro furono portate sulla via Appia, per ritornare nel luogo originario con papa Dionisio, quando i cimiteri vengono restituiti alla Chiesa sotto Gallieno.
La tomba di Paolo si trovava in un cimitero, forse tra colombari, su una strada che si staccava dalla via Ostiense, più a valle rispetto al sepolcro storico. Nel secolo I il papa Anacleto costruisce un piccolo oratorio che con Costantino diventa la basilica. La costruzione della basilica, in tempi successivi, danneggia il cimitero di Lucina.
SEPOLCRO DI SAN PIETRO
All’interno della Basilica di San Pietro in Vaticano
Le spoglie di San Pietro furono sepolte frettolosamente, perché non fossero profanate, ai margini della via Cornelia. La tomba doveva essere una piccola stanza in parte sottoterra, papa Anacleto nel 76-78 ha fatto erigere una memoria, ossia un piccolo oratorio al di sopra di essa. All’imperatore Costantino si deve la primitiva basilica.
La necropoli sotterranea precostantiniana è formata da una serie di mausolei in muratura disposti lungo una piccola strada e riccamente decorati da affreschi, stucchi e da numerosi sarcofagi del II, III e IV secolo.
I mausolei più notevoli sono quelli della famiglia dei Caetennii della famiglia dei Giulii con una decorazione musiva parzialmente integra raffigurante il Buon Pastore e il Pescatore, simboleggiante San Pietro
Il sarcofago dell’Apostolo Pietro si trova l’altare papale, nella camera della confessione il cui pavimento ricoperto di bronzo dorato rappresenta l’immagine della croce, della tiara, delle chiavi e della colomba.
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
- AA.VV. Guida d’Italia, Roma, ed. Tci, 1993.
- AA.VV. Roma, libri per viaggiare, ed. Gallimard – Tci, 1994.
- AA.VV. I rioni e i quartieri di Roma, ed. Newton & Compton, 1989.
- AA.VV. Le strade di Roma, ed. Newton & Compton, 1990.
- Claudio Rendina (a cura di), Enciclopedia di Roma, ed. Newton & Compton, 2005.
- Mariano Armellini, Le chiese di Roma, ed. Pasquino, 1982.
- Carlo Zaccagnini, Le ville di Roma, ed. Newton Compton, 1991.
- G.C. Argan, Storia dell'arte italiana, ed. Sansoni, 1975.
- AA.VV. Storia dell'Arte, Istituto Geografico De Agostini,1975.
- www.comune.roma.it (sito del comune utile per gli aspetti politici, le novità)
- www.archeoroma.beniculturali.it (sito della sovrint. fondamentale per l'aspetto archeologico)
- www.romasotterranea.it
- www.sotterraneidiroma.it
- it.wikipedia.org
- santimarcellinoepietro.it
- comitatocatacombedigenerosa.it
Tucci Piero
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
inbiciperoma.blogspot.com
349.455.15.21
31.10.15
[1] Santa Felicita. Romana, martire con i suoi sette figli. La memoria liturgica della santa è il 23 novembre, per i figli il 10 luglio. La Passio di Felicita, composta tra il IV e il V secolo narra di una ricca vedova romana condannata a morte dopo i sette figli nel periodo dell’impero di Antonino Pio (138-161).
[2] Acquedotto Vergine. E’ l’acquedotto costruito da Agrippa per le terme nel Campo Marzio nel 19 a.C. Le sorgenti sono all’ottavo miglio della via Collatina, la leggenda vuole che una fanciulla indicasse le fonti ad un reparto dell’esercito romano che si trovava assetato nella campagna. L’acquedotto, in parte su arcate, raggiungeva la città alle pendici del Pincio da qui si dirigeva al Campo Marzio, ne resta un tratto in via del Nazareno. Percorso di Km 20, portata di l 1.202 al secondo.
[3] Beati Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini. Prima coppia di sposi elevata alla gloria degli altari, beati non malgrado il matrimonio ma proprio in virtù di esso. Il papa Giovanni Paolo II li ha beatificati il 21 ottobre 2001. Sono stati genitori di quattro figli, lui avvocato generale dello Stato, lei scrittrice di libri educativi.
[4] Sant’Emerenziana. Le poche notizie sulla sua vita vengono dalla Passio Agnetis, venne lapidata al funerale della sorella di latte, è invocata per il mal di ventre e dolori intestinali. Nell’XI secolo il suo corpo fu trasportato in Sant’Agnese fuori le mura, successivamente sotto l’altare maggiore.
CIAMPINO
POSIZIONE GEOGRAFICA
L’aeroporto di Ciampino si trova a Sud Est di Roma tra la via Appia Nuova e la via dei Laghi, subito dopo il Raccordo Anulare, per i ¾ ricade nel comune di Roma, il rimanente nel comune di Ciampino. L’entrata è dall’Appia e dotata di svincoli dal 1990 (mondiali di calcio).
STORIA
La storia dell’aeroporto inizia nel 1914 quando un Regio Decreto dichiarò di pubblica utilità le opere per la sitemanzione dei servizi aeronautici della provincia di Roma. Allora nella zona c’era solo un casale, risalente al Seicento dello studioso Giovanni Giustino Ciampini, che lo utilizzava come residenza estiva. La città di Ciampino è nata quindi insieme all’aeroporto. Un tecnico militare, il generale del Genio Maurizio Mario Moris, si battè per realizzare in questo luogo il grande aeroscalo per ospitare i dirigibili. Cominciò così la storia dell’aeroporto intitolato a Giovan Battista Pastine, comandante di dirigibile, caduto in una azione di guerra nel 1916.
L’aeroporto iniziò a funzionare dal 28 ottobre 1916 come scalo e cantiere per i dirigibili. Era collegato alla città dalla tramvia che correva sull’Appia e da Roma conduceva ad Albano e Velletri (tramvia aperta nel 1912, ultima corsa 3 gennaio 1965). L’aeroporto si trova nelle vicinanze della piccola stazione di Ciampino. Dal 1917 sorge la città giardino di Ciampino.
Da qui si alzò il dirigibile Norge per la memorabile trasvolata del Polo Nord era il 10 aprile 1926 al comando di Umberto Nobile. Nel 1928 vengono radiati i dirigibili dalla Regia Aeronautica militare (nel 1924 viene creato il corpo dell’aeronautica militare).
Negli anni Trenta l’aeroporto divenne militare ma aperto ai voli civili.
Qui dall’8 al 13 ottobre 1930 il maggiore Marinello Nelli si alzò in volo sull’elicottero progettato dall’ing. Corradino D’Ascanio uno dei primi al mondo.
Nel 1950, in occasione del Giubileo, furono unificate la pista sud e quella nord. Il 3 gennaio del 1954 Mike Bongiorno aprì i collegamenti esterni della Rai da questo aeroporto.
Questo fu l’unico aeroporto per i voli civili fino alla nascita di Fiumicino nel 1961, rimase il preferito per l’arrivo di capi di stato e autorità viste le misure di sicurezza che garantiva.
Dal 2001 con l’avvento delle linee aeree low cost il traffico aereo è quintuplicato senza la necessaria valutazione di impatto ambientale.
Nel 2014 il 31° stormo dell’aeronautica militare lo ha ceduto all’Enac.
L’AEROPORTO OGGI
Oggi è un aeroporto civile gestito dalla società Aeroporti di Roma (AdR) come l’aeroporto di Fiumicino. Assorbe la maggior parte del traffico delle compagnie low cost, nel 2014 i passeggeri sono stati 5.018.000, con un amuento del 5,66% rispetto all’anno precedente. In base ad un accordo con il comune di Ciampino e con il X Municipio (oggi VII) del comune di Roma, non possono partire e arrivare più di 100 aerei al giorno per motivi di inquinamento acustico (aprile 2008).
Nella parte del comune di Ciampino ha sede il 31° Stormo dell’Aeronautica Militare e il 2° reparto del Genio. Vi è, inoltre, una base della flotta dei velivoli antincendio CL-415 della Protezione Civile Nazionale.
L’aeroporto dà lavoro a oltre 4.000 persone e crea un contibuto di 15/20.000 posti di lavoro. In conseguenza di ciò il comune di Ciampino è il primo dei Castelli Romani per la presenza di turisti negli alberghi, appartamenti e B&B. Nel 2000 è stato inaugurato l’ostello della gioventù che può ospitare fino a 84 persone, dispone di mensa e sala conferenze.
La prima città italiana raggiunta, per numero di passeggeri nel 2013, è Bergamo Orio al Serio (a Km 53 da Milano) con 119.275; la prima città europea è Londra con 396.703.
CIAMPINO CITTA’
La città di Ciampino è un comune della provincia di Roma di 38.425 ab. (dati del 2015), fino al 1974 era parte del comune di Marino. Si trova a 124 metri slm. Ha una superficie di soli 13,38 Kmq.
Risale al 29 ottobre 1910 la fondazione di una Società Anonima Cooperativa Colli Parioli che acquista terreni dei Colonna per dar vita ad una città giardino, viene stilato il piano regolatore che risale al 1917. Nel 1931 Ciampino aveva 2.584 abitanti. Pier Paolo Pasolini ha insegnato nella scuola media parificata di Ciampino. Dal 1999 si è dotata di una Galleria Comunale d’Arte Contemporanea.
AGGIORNAMENTI
20.11.15Fiumicino e Ciampino. Record di passeggeri. Dati di gennaio – settembre 2015. Se Fiumicino registra un incremento del 5,8%, il vero boom è di Ciampino con il 20% e 4.446.367 passeggeri.
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
Le pagine di Cronaca di Roma dei quotidiani la Repubblica, Corriere della Sera e Il Messaggero del 28.10.15
It.wikipedia.org alla pagina Aeroporto di Ciampino.
Adr.it/Ciampino.
Piero Tucci
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
29.11.15
Ci troviamo nel territorio del V Municipio del Comune di Roma, nel quartiere Prenestino-Labicano, tra la via Prenestina e la via Casilina. Le attuali vie Prenestina e Casilina ricalcano il percorso delle antiche vie romane. Via Prenestina è così chiamata perché conduceva a Preneste, oggi Palestrina, nel primo tratto veniva chiamata anche Gabina perché portava alla città di Gabii. Via Casilina era chiamata anche Labicana perché conduceva a Labicum, attuale Valmontone, talvolta fu chiamata Latina perché una sua diramazione saliva ai Colli Albani dove vivevano i Latini. Il nome Casilina deriva da Casilinum, oggi Capua, dove conduceva la strada e in quel luogo si congiungeva alla via Appia.
Due sono i tipi di rinvenimenti archeologici dell’area: monumenti funerari e ville. Nel 1870, quando Roma divenne capitale d’Italia, l’area era interamente a vocazione agricola con casali e alcune ville nobili lungo le strade consolari, resta il ricordo di questi insediamenti nei nomi delle strade (ad es. via di Villa Serventi). Tra le due strade principali correva il vicolo del Pigneto che si staccava dalla via Prenestina, poco dopo porta Maggiore e giungeva fino al fosso della Marranella. L’area era utilizzata per il pascolo, il terreno era fertile ma paludoso e ricoperto di fitti canneti, in leggera pendenza verso la marrana dell’Acqua Bullicante.
Si trattava di un corso d’acqua di notevoli dimensioni proveniente dalle stesse sorgenti che alimentavano gli acquedotti romani e da sorgenti del suburbio. Il fosso era un ramo dell’Acqua Mariana che si distaccava da questo da Porta Furba che a sua volta scendeva da Squarciarelli. Scorreva per via di Tor Pignattara, via della Marranella dove creava un terreno umido detto Marrano o palude, proseguiva per l’attuale via dell’Acqua Bullicante dove erano delle sorgenti in cui l’acqua aveva la caratteristica di ribollire per la presenza di idrogeno solforato. Giunto a largo Preneste si interrava, divenendo falda acquifera per riaffiorare a Casal Bertone e proseguire verso Nord fino all’Aniene all’altezza di via di Pietralata. Il fosso venne chiuso in condotta sotterranea nel 1934[1].
Questa zona agricola e a pascolo era compresa tra due proprietà più grandi delle altre, la vigna Serventi, tra vicolo del Pigneto e la via Casilina e la Tenuta di Tavoletti, tra vicolo del Pigneto e la via Prenestina (il casale era vicino all’attuale chiesa di San Luca ed era visibile fino agli anni Cinquanta).
Pochi anni prima di Roma capitale, nel 1856 era sorta la prima stazione di Roma, subito fuori porta Maggiore, solo una banchina con un capannone tipo industriale e binario unico. Si trattava della linea ferroviaria per Frascati. Nel 1872 sorge il mulino che poi diventerà Pantanella. Nel 1880 il deposito della Nettezza Urbana oggi Centro di Accoglienza Caritas. Nel 1890 sorge lo Stabilimento omnibus e tramways tra la linea ferroviaria e vicolo del Pigneto, oggi quell’area è deposito di tram Atac. Ai primi del Novecento si deve la nascita della Officine Meccaniche Roma per carri merci ferroviari e carrozze tramviarie (1903, tra Prenestina e ferrovia per Sulmona), l’Istituto Farmaceutico Cesare Serono (1904, a ponte Casilino), lo Scalo Merci San Lorenzo (1906), la fabbrica di Mattoni Carlo Gubellini (1907, tra la Prenestina e la via del Pigneto) Nel 1913 sorge la chiesa di Sant’Elena. Nel 1923 nasce la Cisa Viscosa, poi Snia Viscosa, seconda fabbrica romana per grandezza e numero di addetti. Nel 1925 erano già urbanizzate la zona intorno a vicolo del Pigneto (un caotico assembramento di baracche e casupole), quella intorno a piazza Tolomeo (villette costruite dalla Cooperativa Termini, 250 alloggi circa), Torpignattara (sulla Casilina) e – lungo la Prenestina - tra le vie Fanfulla da Lodi e Alberto da Giussano. Tra il 1930 e il 1938 era sorta la borgata Gordiani, lungo l’arteria omonima, elimitata a partire dal 1960. I bombardamenti del 1943 hanno causato morte e distruzione tra i villini della Città Giardino e la chiesa di Sant’Elena. Attivissima la Resistenza soprattutto a Torpignattara, venivano sabotate le linee elettriche e telefoniche, sparsi i chiodi a quattro punte, venivano fatte scritte inneggianti agli alleati e diffusi volanti e giornali antifascisti. Fra i gruppi armati che si opponevano agli occupanti tedeschi erano molto attivi i GAP che avevano i loro capi in questa zona in Nino Franchellucci e Luigi Forcella. Tra le azioni più importanti il 20 gennaio 1944 Rosario Bentivegna pronunciò un comizio in piazza scortato da 30 uomini armati. Il 2 marzo del 1944, nella sua casa di via Fortebraccio, l’operario edile Angelo Calafati, padre di sei figli venne catturato dai fascisti della banda Koch, portato a via Tasso, morirà alle Fosse Ardeatine. Ospitava nella sua casa quattro soldati alleati fuggiti dai tedeschi, due russi, un inglese e un francese. Il 4 marzo viene ucciso nella sua abitazione il commissario di zona, tale Stampacchia, che si era distinto per una incessante azione repressiva verso gli antifascisti. Il commissario era già sfuggito ad un agguato in largo Alessi. Il 24 aprile del 1944 avvenne l’azione partigiana più clamorosa alla stazione Tiburtina, fu fatto deragliare un treno che trasportava trecento detenuti ai campi di concentramento, il treno fu assaltato e i prigionieri aiutati a fuggire. Il 4 giugno del 1944 ultimi scontri tra partigiani e tedeschi in fuga sulla Casilina all’altezza di Villa Certosa. Alle ore 9 il quartiere era liberato.
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta sono sorte abitazioni a carattere intensivo che hanno saturato tutti gli spazi liberi. In questi anni le “Consulte popolari” hanno guidato la lotta per la casa per la borgata Gordiani (anche via Terracina e Formia, 500 famiglie nel 1968), il borghetto Prenestino (660 famiglie nel 1968), al Torrione (240 famiglie sempre nel 1968) e a via Norma (altre 155). Dagli anni Settanta la zona del Pigneto ha visto l’arrivo di molti studenti universitari per la vicinanza alla Città Universitaria. In conseguenza di ciò sono sorti molti locali serali e notturni frequentati da giovani e giovanissimi. Qui sono venuti ad abitare molte persone del mondo dello spettacolo, tra queste Vladimir Luxuria[2]. Negli anni Ottanta è stato realizzato il Piano di Zona 23, su progetto dell’architetto Ludovico Quaroni, un quartiere che offre una alta qualità di vita ai propri abitanti. Dagli anni Ottanta anche questa zona di Roma, come tutta la città è in decremento demografico. Negli ultimi venti anni molti extracomunitari sono andati ad abitare nel primo tratto di via del Pigneto e strade limitrofe, altri a Torpignattara dove c’è la scuola elementare Carlo Pisacane frequentata totalmente da cinesi (su 176 alunni, 40 hanno la cittadinanza italiana). Molti gli immigrati del Sud dell’Asia, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka.
Nel 2013 vi sono state numerose e clamorose proteste degli abitanti del Pigneto che lamentavano il degrado della via nel tratto pedonale e della zona, nelle ore notturne si segnalava il problema dello spaccio della droga. Il 14 ottobre 2013 il sindaco Ignazio Marino si è recato al Pigneto per incontrare la popolazione per i problemi di ordine pubblico della zona[3]. Il 29 giugno 2015 sono state inaugurate quattro stazioni della metro C, a metà 2016 arriverà a San Giovanni.
ITINERARIO
Il nome Pigneto indica già la sua origine, una pineta in posizione sopraelevata rispetto alle due vie consolari piantata dalla famiglia Caballini presso la settecentesca villa Serventi.
Via del Pigneto inizia dal primo tratto della via Prenestina, proprio dove è piazza Caballini (sulla nostra testa il mulinello degli svincoli della Tangenziale) con il deposito di tram Atac ed una grande edicola sacra posta proprio al bivio. Il primo tratto di via del Pigneto è stretto e caratterizzato dalla rampa in discesa della Tangenziale. Si avanza in un paesaggio di periferia industriale, sulla sinistra si trova il deposito Algida oggi occupato dalla ditta Sprint Spedizioni (civico 5 b), si noti il tetto ricoperto di tegole tipico degli edifici industriali dei primi del Novecento. Si arriva in PIAZZA del PIGNETO. Alle spalle della piazza (no lato Serono, ovviamente) si trova via Sondrio, al civico 21 abitava Lucio Battisti quando la sua famiglia si trasferì a Roma da Poggio Bustone, il padre lavorava alla stazione Tuscolana, il ragazzo frequentava l’istituto Galileo Galilei in via Conte Verde.
La piazza di forma rettangolare, è caratterizzata dall’ISTITUTO FARMACOLOGICO SERONO, che si sviluppa su uno dei lati lunghi. Sul lato corto si trova il ponte Casilino, di fronte inizia via L’Aquila, in leggera discesa che porta alla via Prenestina. Al centro uno squallido giardinetto intitolato a Tiziano Terzani[4]. Nell’Istituto Farmacologico Serono c’è la storia del quartiere, dai documenti d’archivio sappiamo che nel 1904 Giorgio Passarge, farmacista in piazza di Spagna, chiese il permesso al Comune di poter costruire un laboratorio in un terreno di sua proprietà al Pigneto. Nel 1925 venne ampliato e assunse l’aspetto attuale. Il complesso oltre ai laboratori aveva abitazioni per il personale. Dismesse in questa sede le attività industriali, la proprietà ottenne il cambio di destinazione d’uso. Una parte dell’edificio è sede centrale dell’Istituto, una parte è occupata da mini appartamenti, un’altra è stata consegnata al comune (oneri concessori) nella quale vi ha trasferito la biblioteca del municipio. Dal 2010 parte del complesso è adibito ad albergo, di proprietà di una società catalana, dal nome: EUROSTARS ROMA AETERNA. E’ un quattro stelle che dispone di 144 stanze, dispone di 7 saloni per congressi ed eventi, il più grande di mq 244 può ospitare 260 persone (Palatina)[5].
In via del Pigneto 22 si trova la BIBLIOTECA GOFFREDO MAMELI del Comune di Roma, è intitolata all’eroe del Risorgimento nazionale morto in difesa della Repubblica romana, dispone di 30.000 volumi, 5.000 cd e 50 periodici. Si estende su una superficie di 550 mq più 280 di giardino. E’ stata inaugurata il 19 ottobre 2011[6].
In via L’Aquila si trova il NUOVO CINEMA AQUILA. Risale agli anni Trenta, è in stile razionalista e ristrutturato pochi anni fa rispettando lo stile di costruzione. La tettoia originale era in muratura mentre quella attuale è in ferro e vetro, si tratta di una pregevole opera di restauro. La struttura è stata sequestrata alla mafia (banda della Magliana?) nel 1998 e nel novembre 2004 la Giunta comunale ha stanziato 2 milioni di euro per trasformarlo in cinema con tre sale, libreria specializzata, sede espositiva e caffè. E’ stato reinaugurato il 21 aprile 2008, a pochi giorni dalle elezioni comunali che portarono Alemanno ad essere sindaco di Roma.
Si prosegue per via del Pigneto, in questo tratto si trovano i banchi del mercato rionale e fino a via Grosseto – via Ascoli Piceno è pedonale. La quarta domenica del mese in questo tratto di strada pedonale si tiene un mercatino di antiquariato, modernariato, vintage, collezionismo, libri, francobolli, gioielli e bigiotteria d’epoca. Molti locali per i giovani che amano tirar tardi la sera. Il quartiere, di origine popolare, ha visto la stessa mutazione di San Lorenzo, della Garbatella e Casal Bertone. Al civico 57-61 si trova una costruzione del 1924 con una decorazione decisamente particolare, la più caratteristica della strada. Sul palazzetto di tre piani, in cortina, articolato in rifiniture bianche, sono inseriti ben tredici bucrani, posti tra il primo e il secondo piano. Si tratta di un elemento insolito per un palazzo moderno, si riferisce alla decorazione di monumenti classici (vedi la tomba di Cecilia Metella), vuole ricordare la professione di macellaio del proprietario.
Più avanti, sul palazzo d’angolo con via Ascoli Piceno è posta un’edicola sacra a forma di tempietto con due colonnine ioniche, all’interno mattonelle di ceramica dipinta rappresentano la Sacra Famiglia, sul timpano il monogramma mariano. In via Ascoli Piceno 18 una lapide ricorda Antonio Atzori, partigiano, deportato e morto in campo di concentramento.
Voltiamo a destra per via Campobasso, dove si incontrano altre deliziose palazzine, dopo pochi metri la strada viene divisa da un palazzo con cantonale stondato su cui è inserito un grazioso balconcino balaustrato, sulla destra continua via Campobasso, sulla sinistra inizia via Avellino che porta in via Casilina dove è la chiesa di Sant’Elena.
Tornati in via del Pigneto si raggiunge e si supera con un PONTE PEDONALE LA LINEA FERROVIARIA che collega la linea per Firenze con quella per Napoli. Di fronte si trova la stazione della metro C Pigneto che ha riqualificato quel tratto di strada. Il pre-esercizio della metro C è iniziato il 15 dicembre 2013, il tratto Pantano – Centocelle ha aperto nel novembre 2014, l’ulteriore tratto fino a Lodi ha aperto nel giugno 2015, arriverà a San Giovanni nel 2016. Sulla destra vediamo l’austero edificio dell’Istituto Professionale di Stato “Virginia Woolf” seguito dalla SCUOLA ELEMENTARE ENRICO TOTI. Nel novembre del 2012 sono finiti i lavori di bonifica dall’amianto che hanno comportato l’abbattimento del padiglione adibito a biblioteca. Si prende circonvallazione Casilina verso Nord si piega nella prima a destra: via Braccio da Montone, in questa strada al civico 21 uno dei villini più belli del Pigneto, è in stile liberty, presenta un portico sovrastato da finestra entrambi stondati e da un corpo di fabbrica nel quale prevale di giallo con decorazioni azzurre e bianche. Nella vicina via Fortebraccio, al civico 25, una lapide ricorda il partigiano Angelo Galafati che nella sua abitazione nascondeva 4 soldati russi, un francese e un belga. Arrestato su delazione dalla banda Koch, venne ucciso alle Fosse Ardeatine.Si prosegue fino a via Fanfulla da Lodi[7].
Qui si trova il celebre BAR NECCI, diventato famoso in seguito al film di Pasolini “Accattone” del 1961. Vedi il paragrafo finale dedicato al cinema. Oggi è uno dei luoghi più frequentati della movida giovanile. La zona venne ripetutamente colpita dai bombardamenti dell’ultima guerra, i segni di tale distruzione rimasero per decenni dopo la guerra. Nei registri dei Vigili del Fuoco presenti nel museo di via Galvani vi è traccia delle operazioni di soccorso alla popolazione vittima di crolli, persone travolte o imprigionate dalle macerie. Vengono menzionate via Ettore Fieramosca, via Erasmo Gattamelata, via Alberto da Giussano.
Via Fanfulla da Lodi termina in via del Pigneto proprio nel tratto in cui la via si sdoppia, presenta al centro alti pini e variazioni planoaltimetriche per poi ricongiungersi.
Giunti all’incrocio con via Adriano Balbi la si imbocca, è questa una delle strade più caratteristiche della
CITTA’ GIARDINO
il cui centro e immagine è piazza Copernico.
Questa parte del quartiere venne costruita dalla Cooperativa Termini, una cooperativa di ferrovieri, fondata nel 1919 che acquistò il terreno della villa appartenuta ai conti Serventi per costruirvi piccoli villini, circondati da giardini o orti, ad uno o due livelli, per 250 alloggi che vennero realizzati entro il 1925. Si tratta di villini bifamiliari in semplice stile geometrico, a uno o due livelli, circondati da giardinetti privati secondo il modello delle città giardino inglesi. Attualmente sulla mappa di Google non ne arrivo a contare 100. La cooperativa ristrutturò una costruzione rurale (la torretta di piazza Copernico) destinata ad ospitare la sede della cooperativa stessa, mentre il casino nobile andò distrutto. I ferrovieri si stabilirono in questa zona data la vicinanza con lo scalo merci San Lorenzo nato nel 1906, e la stazione Prenestina.Il 23 novembre 1920 fu lo stesso re Vittorio Emanuele III ad assistere alla posa della prima pietra della Città Giardino.
Via Adriano Balbi presenta una serie di villini, tutti curati e circondati dal verde con alti alberi. Al civico 15 si trova il villino delle Piccole Suore del Sacro Cuore di Gesù che ha il corpo centrale leggermente arretrato rispetto alle due ali laterali.
All’angolo con via Cristoforo Buondelmonti ne troviamo uno con decorazioni bianche che risaltano sull’intonaco rosso mattone.
Raggiungiamo piazza Tolomeo, la circondano graziose villette con tetti di tegole o con terrazzi, con semplici finestre o graziosi balconcini in ferro battuto.
Se da questa piazza si percorre via Vincenzo Coronelli, al civico 24 si trova il MUSEO STORICO DIDATTICO DI GIOCHI E GIOCATTOLI DEL NOVECENTO. Si tratta di un museo etnografico privato di Lisa e Franco Palmieri che hanno ereditato la collezione di Fritz Billig Hoenigsberg, viennese emigrato in America per le persecuzioni razziali del nazismo. Iniziando dalla conservazione dei suoi giocattoli ne continuò a collezionare per tutta la vita acquistandoli da tutti e cinque i continenti. La collezione oggi comprende 2.700 giocattoli industriali costruiti tra il 1920 e il 1990. Nel museo anche un teatro da 60 posti, una biblioteca, locandine e manifesti pubblicitari. E’ aperto su prenotazione[8].
Da piazza Tolomeo imbocchiamo via di Villa Serventi che ha sullo sfondo la via Casilina e gli archi dell’Acquedotto Felice.
VIA DI VILLA SERVENTI
Al civico 2 si trova la cosiddetta “casa dei Cesaroni”, mentre nella finzione è in via Filippo Tolli 2 alla Garbatella, gli interni sono girati a Cinecittà. La casetta risale al 1929. “I Cesaroni” sono una serie televisiva italiana prodotta dal 2006 al novembre 2014 dalla Publispei di Carlo Andrea Bixio e da Rti. La serie è giunta alla sesta stagione. Interpreti sono: Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Max Tortora e altri. La regia è di Francesco Stefano Vicario e Francesco Pavolini[9].
Tornati a piazza Tolomeo prendiamo via Pomponio Mela, al n. 1 il villino di Luigi Castaldi su due piani di finestre incorniciate, tutto intonacato di rosso con una greca a quadretti bianchi e rossi sotto il tetto.
Via Pomponio Mela termina in piazza Copernico. Qui troviamo la TORRETTA, uno dei simboli del Pigneto. Era un vecchio casale facente parte di villa Serventi, che lo utilizzavano come fienile; mentre il casino nobile è stato abbattuto, questo venne ristrutturato per ospitare la sede della cooperativa Termini che ha edificato la Città Giardino Prenestino. E’ un luogo leggendario, si dice che vi abbia dormito Garibaldi. Sulla facciata si trova una grande epigrafe che ricorda i soci della cooperativa e i loro congiunti caduti in guerra, nei bombardamenti e alle Fosse Ardeatine.
Prendiamo via Fra Mauro, anche qui villette circondate da palme e pini con loggette, portici, finestre arcuate e balconcini.
Alla fine della strada il panorama cambia completamente, ci troviamo in quella parte della città costruita solo sulla base delle spinte speculative, tutti intensivi di dieci piani. Giungiamo a via dei Condottieri, percorriamo per tutta la sua lunghezza via Roberto Malatesta fino a giungere in via dell’Acqua Bullicante, la percorriamo in direzione Sud fino a giungere a via Casilina (piazza della Marranella), la oltrepassiamo, prendiamo via di Torpignattara, la prima a destra è via Galeazzo Alessi. Fatti 300 metri giungiamo al
MURALES A PASOLINI
E’ stato soprannominato la “Cappella Sistina di Tor Pignattara”, un tributo a Pier Paolo Pasolini, opera di Nicola Verlato, in arte Hostia. E’ sulla facciata di via Galeazzo Alessi, risale ad aprile 2015. Una “Pietà”, in una scena classica nella quale un uomo precipita nel vuoto.
Una “Pietà” si trova sul lungotevere Testaccio dove fu girata la scena finale di Accattone, rappresenta Pasolini che tiene in braccio se stesso morto, è opera di un anonimo.
Si riprende la via Casilina in leggera salita, dopo la chiesa dei Santi Marcellino e Pietro si trova l’ingresso al
PARCO DI VILLA DE SANCTIS
detto anche parco Casilino Labicano. Il parco ha una superficie di circa 12 ettari, fu aperto al pubblico dal sindaco Rutelli il 5 novembre 1994 (solo una zona di tre ettari all'angolo tra via Casilina e via dei Gordiani). Nel 1942 Filippo De Sanctis, proprietario del fondo, lascia in testamento il terreno all'Ente Comunale di Assistenza di Roma. Solo nel 1950 la villa viene finalmente consegnata al Comune ma la proprietà era stata affittate e subaffittata. Il 31 marzo 1981, con il sindaco Petroselli, viene deliberata la costituzione del parco pubblico, ma l’area è occupata da depositi di auto in demolizione, depositi di materiali edili, un circolo sportivo e un ristorante con parcheggio “La carovana”. Dopo lunghe battaglie legali si arriva finalmente allo sgombero, alla bonifica e all'inaugurazione del 1994.
Fra i resti di epoca romana presenti nella villa è da menzionare un sepolcro sovrastato da un gazebo in ferro battuto, visibile anche da via Casilina.
Fino alla costruzione del quartiere di Casilino 23 era possibile vedere nella zona delle greggi al pascolo.
Nel 2003 (sindaco Veltroni) è stato inaugurato il Parco delle Sculture con la collocazione di 5 opere d'arte contemporanea realizzate utilizzando cinque materiali diversi:
- "Freeze" di Anna Ajò, in vetroresina;
- "Porta Magica" di Immacolata Datti, in terracotta;
- "Porta" di Giuliano Giuliani, in travertino;
- "Romana" di Carlo Lorenzetti, in acciaio;
- "Luna" o "Luna verde" di Costas Varatsos, in vetro[10].
La villa padronale è stata restaurata e dal gennaio 2012 ospita la “CASA DELLE CULTURE”, al piano terra c’è un salone per le mostre, al primo piano si trova il Centro di Documentazione con una piccola biblioteca che si è formata con le donazione degli abitanti del quartiere. Si è arricchita con la donazione della biblioteca di Carlo Maria Colucci professore all’Università di Tor Vergata scomparso prematuramente. Per il futuro si prevede di realizzare nell’edificio l’”Ecomuseo del Comprensorio Casilino”.
Uscendo da villa De Sanctis da via dei Gordiani, andando verso la Casilina c’era la fabbrica della BIRRA PILSEN, prima di questa vi era, negli anni Cinquanta, una PORCARECCIA, gli animali allevati in questo luogo erano alimentati con gli scarti alimentari prelevati dalla immondizia pubblica[11].
L’entrata al parco su via dei Gordiani permette l’ingresso al
QUARTIERE CASILINO 23
Il quartiere, che oggi gli abitanti vogliono chiamare di Villa De Sanctis, è stato progettato da Ludovico Quaroni[12] con Gabriella Esposito, Luciano Rubino e Roberto Maestro. Si tratta di un’area edificata di 50 ettari per complessivi 12.000 abitanti. Lo schema planimetrico è costituito da 29 edifici a “stecca” disposti a ventaglio a partire da un’area a servizi con scuole e centro commerciale. Ogni stecca ha una forma a salire, via via che si allontana dal centro tende a salire fino ad arrivare a dieci piani (alcuni anche a 14 piani), questo rende ogni edificio un trapezio. Ad interrompere la prospettiva radiale sono stati inseriti edici verticali di uno o due piani, che non erano previsti nel piano. Inoltre la visione di insieme che si doveva avere da viale delle Primavera non è possibile perché quel viale è a 4 metri più in basso rispetto al livello del quartiere. Al centro del comprensorio si trova un viale pedonale con negozi, il viale termina alla chiesa parrocchiale. Il quartiere è dovuto a cooperative edilizie, tra queste quelle dei ferrovieri presso la via Casilina. Ci troviamo in un punto particolarmente alto della nostra città, alcuni palazzi, ai piani più alti vedono la cupola di San Pietro. Al di sotto del quartiere vi sono numerose grotte, in parte naturali, in parte scavate dall’uomo per ricavarne materiale da costruzione negli anni di fine Ottocento primi Novecento. La presenza di tali cavità a dato luogo a problemi di staticità degli edifici come è avvenuto per la scuola Romolo Balzani nel 2012.
Il quartiere di Casilino 23 ha le strade intitolate a poeti romaneschi (Romolo Balzani[13], Checco Durante[14], Valentino Banal, e altri). Un referendum consultivo ha deciso che il quartiere di chiami: quartiere di Villa De Sanctis (vi erano altre proposte: Ludovico Quaroni, Primavera, Due Allori, non mancò chi voleva conservare il nome del PdZ). Data la particolarità del quartiere è da alcuni chiamato “I Parioli di Centocelle”. La sua parrocchia è la:
CHIESA DI SAN GERARDO MAIELLA
Si apre su una strana piazza pedonale (parte della piazza presenta un parcheggio sotterraneo) posta lungo il percorso di via Francesco Ferraironi, la festa patronale è a ottobre. La parrocchia è stata creata nel 1978 dal cardinale vicario Ugo Poletti. Il complesso parrocchiale è stato progettato da Aldo Aloysi[15] e realizzato nel 1980-81, consacrata nel 1982. E’ un edificio simile a un capannone industriale o un garage con evidente sviluppo orizzontale, interno a base quadrata. Presenta due ingressi uguali sotto una pensilina, alta croce sulla destra come campanile. Don Benito Vaschetta è stato il primo parroco.
Sulla piazza pedonale della chiesa affaccia anche l’ingresso principale del MERCATO COPERTO realizzato nei primi anni Duemila. In via Romolo Balzani sono da notare la SCUOLA ROMOLO BALZANI che è dotata di un giardino – orto botanico creato dal comune di Roma, la scuola è stata chiusa dal marzo 2013 a fine anno scolastico per lesioni alla struttura dell’edificio dovute alla presenza di cavità sotterranee. Sempre in via Romolo Balzani si trova il CASALE GARIBALDI, uno dei tanti casali della periferia romana, come l’omonimo nel quartiere “Basilica di San Paolo”, nei quali si ritiene che abbia soggiornato l’Eroe dei Due Mondi. Svolge una apprezzata attività sociale e culturale (Upter), vi ha sede il comitato di quartiere. Nella vicina via Checco Durante, in angolo con via dei Gordiani si trova una antenna Telecom che desta preoccupazione negli abitanti per le emissioni elettromagnetiche, tutti i rilevamenti hanno sempre rilevelato emanazioni nei limiti della norma. In via Francesco Ferraironi si trova la SCUOLA ELEMENTARE IQBAL MASIH[16], mentre nella vicina via Guattari la SCUOLA MEDIA FRANCESCO BARACCA[17] dal nome del vicino aeroporto. Sempre in via Guattari si trova il CENTRO COMMERCIALE PRIMAVERA che si affaccia sul viale omonimo ad un livello più basso. I cittadini sono riusciti ad ottenere che tale edificio non avesse le previste torri per diminuirne l’impatto ambientale. E’ aperto tutte le domeniche, dispone di un supermercato Simply, Media World, Ovs, Azzurra Sport e una quarantina di negozi su due piani.
LOCALI
Ristorante Pizzeria Aquila d’Oro, via L’Aquila 24.
L’infernotto Enoteca, via del Pigneto 33.
La gelateria del Pigneto, di Filippo Ruggieri, via Pesaro.
Vitaminas 24, via Ascoli Piceno 40, è un ristorante di cucina biologica, servono cibi crudi. Centrifughe di verdure, frullati senza latte con effetto disintossicante. Tutti i prodotti da un’azienda biologica dei Castelli Romani, i frutti tropicali: acai, acerola, caia, graviola, cupuacu, vengono dal Brasile.
Ristorante Primo, via del Pigneto 46, crocchette di baccalà.
Kino, via Perugia 34,cineclub erede del Grauco, uno dei primi cineclub di Roma.
Fraschetta romana, via del Pigneto 68, ad angolo con circ. Casilina, si mangia porchetta, mozzarella e pasta.
Necci, via Fanfulla da Lodi 68, bar e ristorante, celebri i cornetti a tarda ora. E’ il locale immortalato da Pasolini in “Accattone”.
Circolo degli Artisti, via Casilina Vecchia 42, è vicinissimo al Pigneto, musica dal vivo, pizzeria, braceria, scuola di teatro, eventi. Dal 1989.
IL QUARTIERE NEL CINEMA
Il Pigneto è protagonista del capolavoro del neorealismo “Roma città aperta” (1945) di Roberto Rossellini, in via Montecuccoli vive Pina (Anna Magnani) la protagonista femminile di questa storia che è un affresco della società romana negli anni della guerra e un omaggio alla Resistenza. Per la prima volta si vedono sullo schermo dal vero interni, cortili e scale di vecchi palazzoni popolari, bambini malvestiti e sporchi, litigi familiari, tram affollati, donne incinte senza essere sposate. Sempre al Pigneto è ambientato “Accattone”(1961) di Pier Paolo Pasolini, in via Fanfulla da Lodi si trova il bar da lui frequentato. E’ la storia di un sottoproletario della borgata Gordiani di nome Vittorio (Franco Citti) che vive sfruttando una prostituta, il finale sarà drammatico. Il bar Necci sorge in questa strada dal 1924, gestito sempre dalla stessa famiglia. In passato, nel locale avevano sede due società di ciclismo. E’ frequentato da personaggi del mondo dello spettacolo, tra questi: Fiorella Mannoia, Luca Barbarossa e la “iena” Lucci. Nella notte tra il 30 e il 31 marzo 2009 è stato parzialmente distrutto da un incendio, i proprietari hanno dichiarato di non aver mai ricevuto minacce, hanno fatto riferimento a un gesto di “invidia”. In questo locale è stato girato, nel 2009, il film “Una questione di cuore” scritto e diretto da Francesca Archibugi, con Antonio Albanese e Kim Rossi Stuart. Al Pigneto sono stati ambientati “Bellissima” (1951) film neorealista di Luchino Visconti con Anna Magnani e Walter Chiari, “L’audace colpo dei soliti ignoti” (1959) con Vittorio Gassman, Renato Salvatori, Riccardo Garrone e Nino Manfredi, film di Nanni Loy, “La Domenica della buona gente” (1953) di Anton Giulio Majano con Maria Fiore, Sophia Loren e Renato Salvatori, è girato tra il Pigneto e via Fortebraccio, “Il ferroviere” (1956) di Pietro Germi, con Pietro Germi, Luisa Della Noce, Sylva Koscina, invece è stato girato tra piazzale Prenestino e la circonvallazione Casilina. Anche “La messa è finita” (Moretti, 1985) è un altro film omaggio a questa parte di città. E’ la storia di un giovane sacerdote di Ventotene che torna a Roma, diventa parroco di Santa Maria Mediatrice in via Cori (Prenestino-Labicano), cerca di riprendere contatti con la famiglia e con gli amici ma, trova persone stralunate. In piazzale Prenestino con la tangenziale appena costruita abita il protagonista del film “Un borghese piccolo piccolo” (Mario Monicelli, 1977) con Alberto Sordi, al Cannone di via Casilina c’è la scena finale del film. “Il tetto” di Vittorio De Sica, del 1956, ha per protagonista il borghetto Prenestino, qui il protagonista cerca di costruire la sua baracca tra le altre baracche.
BIBLIOGRAFIA
- AA.VV. Guida d’Italia, Roma, ed. Tci, 1993.
- AA.VV. Roma, libri per viaggiare, ed. Gallimard – Tci, 1994.
- AA.VV. I rioni e i quartieri di Roma, ed. Newton & Compton, 1989.
- AA.VV. Le strade di Roma, ed. Newton & Compton, 1990.
- Claudio Rendina (a cura di), Enciclopedia di Roma, ed. Newton & Compton, 2005.
- Carlo Villa, Le strade consolari di Roma, ed. Newton Compton, 1995.
- Stefania Quilici Gigli, Roma fuori le mura, ed. Newton, 1986.
- Irene de Guttry, Guida di Roma moderna, ed. De Luca 1989.
- Gaia Remiddi e altri, Il moderno attraverso Roma, ed. Groma, 2000.
- Piero Ostilio Rossi, Roma. Guida all’architettura moderna, ed. Laterza, 1991.
- AA.VV. Invito al Pigneto, la città giardino del Prenestino, 2000 (a cura dell’Ass. Cult. Futuro).
- Paolo Montanari, Sul territorio del Prenestino-Labicano, ed. e-doxa, 2004 (a cura del Municipio).
- AA.VV. Stradaroma, ed. Lozzi, 2005.
- AA.VV. Tutto Città, 2011/2012, ed. Seat.
SITOGRAFIA
www.archeoroma.beniculturali.it
www.bandb-rome.it/roma_pigneto.html
Piero Tucci
8.11.15
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
[1] Fosso dell’Acqua Bullicante. Le notizie da: il pinolo.it.
[2] Vladimir Luxuria, al secolo Vladimiro Guadagno (Foggia 1965), attrice, scrittrice e attivista politica, è stata deputata della XV legislatura, la prima transgender.
[3] Pigneto. Problemi di ordine pubblico. Vedi la Repubblica, cronaca di Roma del 22.5.10 (manifestazione contro lo spaccio) e 15.10.13 (visita del sindaco Marino).
[4] Tiziano Terzani. (Firenze 1938 – Orsigna 2004) Giornalista e scrittore italiano.
[5] Hotel Eurostars Aeterna tutte le notizie da: eurostarshotels.it.
[6] Biblioteca Goffredo Mameli. Tutte le notizie da: comune.roma.it. Nel 2011 era sindaco Gianni Alemanno.
[7] Via Fanfulla da Lodi. Vedi nota n. 20.
[8] Museo del Giocattolo. Tutte le notizie da it.wikipedia.org.
[9] I Cesaroni. Tutte le notizie da: it.wikipedia.org.
[10] Parco di Villa De Sanctis. Tutto il paragrafo è preso da: Mausolei di Roma.
[11] Birra Pilsen e Porcareccia. Le notizie di questi due siti da un colloquio orale con Masci Corinto.
[12] Ludovico Quaroni. (Roma 1911-1987) La piazza dell'E42 oggi Marconi con altri, il quartiere INA Casa Tiburtino al settimo chilometro della Tiburtina, il quartiere "La Martella" a Matera, la palazzina la Tarataruga in via Innocenzo X con Carlo Aymonino nel 1951, il complesso polifunzionale a Grosseto in piazza Rosselli, la Chiesa Madre di Gibellina (1972), il quartiere di Casilino 23. A lui è intitolata la facoltà di architettura di Valle Giulia.
[13] Romolo Balzani (Roma 1892-1962) cantautore, attore, poeta. Barcarolo romano e l’Eco der core le sue canzoni più celebri.
[14] Checco Durante (Roma 1893 – 1976) attore e poeta italiano popolare per l’uso del dialetto romanesco, interpreto con schiettezza e bonomia un certo carattere romano. Sposatosi con l’attrice Anita Durante ebbe due figlie, anch’esse attrici, Leila e Luciana, quest’ultima madre del celebre doppiatore Francesco Prando. Dal 1950 la sua compagnia teatrale recitò nel teatro Rossini presso il Pantheon.
[15] Aldo Aloysi. L’arch. È autore della chiesa di San Gregorio Magno alla Magliana, di Nostra Signora di Fatima in via del Fontanile Nuovo alla Borgata Ottavia (presso via Trionfale).
[16] Iqbal Masih Bambino-operaio pachistano, attivista, simbolo della lotta contro il lavoro infantile. Parlò alle nazioni unite contro il lavoro dei bambini nelle fabbriche di tappeti, lavoro condotto in condizioni di schiavitù. Fu ucciso il 16 aprile 1995, a 12 anni, con i suoi due cugini, mentre era in bicicletta, si trattò di un complotto della mafia dei tappeti.
[17] Francesco Baracca. (Lugo 1888-Nervesa della Battaglia 1918) un asso dell’aviazione italiana, medaglia d’oro al valor militare nella prima guerra mondiale, gli vengono attribuite 34 vittorie aeree. Un museo lo ricorda nella sua città natale.
DELIMITAZIONE E STORIA
DEL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI
Il parco si trova nel territorio del VII Municipio (fino al 2013 era il X) fa parte del Parco Regionale dell'Appia Antica ed è compreso nei quartieri XXV Appio Claudio e XXVI Appio Pignatelli (Statuario - Quarto Miglio). E' delimitato dalla via del Quadraro, via Lemonia, via delle Capannelle e la linea ferroviaria per Napoli (con due tracciati quasi paralleli: per Cassino e per Formia). L'estensione del parco è di 240 ettari[1]. Il parco è facilmente raggiungibile con la metro A scendendo alla fermata Giulio Agricola.
Il nome deriva dalla presenza in elevato o sotterranea di sette acquedotti (sei romani[2] e uno rinascimentale): Anio Vetus (sotterraneo), Marcia, Tepula, Iulia e Felice (sovrapposti), Claudio e Anio Novus (sovrapposti). In passato l'area era nota come "Roma Vecchia" dal nome dell'omonimo casale. Fino agli anni Cinquanta - quando iniziò la costruzione del quartiere INA Casa Tuscolano la zona era meta delle passeggiate "fuori porta" del popolo romano, una sorta di vacanza alla portata di tutti.
Nell'area del parco si trovano, oltre a testimonianze dell'epoca romana, manufatti di epoca rinascimentale e ottocentesca: la villa delle Vignacce, la tomba dei Cento Scalini, una cisterna con torretta, varie tombe, resti del basolato della via Latina, il casale di Roma Vecchia, il casello della ferrovia Roma Frascati di Pio IX.
L'area venne destinata a verde pubblico dal PRG del 1965, negli anni Settanta è stata espropriata e liberata dai borghetti popolati da poverissimi immigrati dalle regioni meridionali dell'Italia e dalle campagne. Tale baraccopoli si addossava alle arcate degli acquedotti come avveniva in via del Mandrione al quartiere Tuscolano. Grazie all'opera di sensibilizzazione di un comitato di cittadini e all'appoggio di studiosi quali Lorenzo Quilici, nel 1988 il parco degli Acquedotti fu inserito nel Parco Regionale dell'Appia Antica costituito quell'anno.
Nel 2011 è stato realizzato il ripristino idrico e paesaggistico della Marrana o Fosso dell'Acqua Mariana.
Nel testo ricorrono spesso riferimenti alla via Latina, alla via Appia e alla via Tuscolana. Ne diamo alcune brevi informazioni di carattere generale. Per la via Latina vedi più avanti nell’itinerario.
La via Appia, la "Regina viarum" dei romani, fu un'opera ancora più imponente della precedente, fu fatta costruire da Appio Claudio Cieco nel 312 a.C. per congiungere Roma con Capua senza seguire le vie naturali, anticipando così il concetto di autostrada. In seguito venne lastricata di selci e prolungata (verso il 190 a.C.) fino a Benevento e Venosa (fondata con 20.000 coloni romani), ancora dopo fino a Taranto e Brindisi divenendo la strada per l'Oriente. Il tratto Benevento Taranto Brindisi perse importanza quando venne sostituito dalla via Appia Traiana che toccava invece Aecaes (Troia), Canusium (Canosa), Barium (Bari). Era la più importante delle vie consolari anche per gli splendidi monumenti sepolcrali che sorgevano ai lati di essa. Dopo la decadenza dell'impero rimase a lungo inutilizzata e si deve a Pio VI Braschi (fine Settecento) la sua riapertura.
La via Tuscolana non è una strada antica ma del Medioevo nata collegando tronchi preesistenti. Il nome deriva da Tuscolo, luogo di arrivo della strada, e gli rimane anche dopo la distruzione della città avvenuta nel 1191. La via, che oggi termina a Frascati, ha assunto in epoca moderna tutte le funzioni della via Latina nel collegamento con i Colli Albani. Se anticamente usciva da porta Asinaria, con Gregorio XIII il suo inizio fu spostato a porta San Giovanni. La zona da essa attraversata conservò l'attuale morfologia fino ai primi del Novecento quando il PRG del 1909 inserì il primo tratto della via fino al vallo ferroviario tra le aree edificabili con un sistema di piazze radiali. Il piano regolatore del 1931 incrementò la densità abitativa e portò il limite edificabile agli stabilimenti di Cinecittà che sorgeranno prima dell'ultima guerra. Negli anni Cinquanta e Sessanta il percorso della via Tuscolana fino agli stabilimenti cinematografici di Cinecittà assunse l'aspetto attuale.
ITINERARIO
Si raggiunge la villa dei Sette Bassi dal centro storico percorrendo tutta la via Tuscolana, si raggiunge e si supera piazza di Cinecittà, si passa davanti agli stabilimenti cinematografici di Cinecittà e si giunge ad un grande quadrivio, si prende a destra via di Capannelle fino alla piazzalo che precede l’ingresso al Casale Consolini.
VILLA DEI SETTE BASSI
Purtroppo l'area è recintata, il punto migliore da cui osservarla è da via di Capannelle presso il vivaio Flora (molto comodo il marciapiede che dal grande quadrivio Tuscolana/via di Capannelle/via di Torre Spaccata conduce in sicurezza allo spiazzo antistante il cancello del vivaio) oppure dallo spiazzo che precede il casale Consolini. Il casolare al centro della tenuta agricola è ben visibile dalla via Tuscolana. Si tratta della villa più estesa del suburbio, dopo quella dei Quintili, attribuita al console Settimio Basso, tra le poche che conservino la planimetria complessiva costruita ai tempi di Antonino Pio[3].
La villa occupa un piccolo pianoro collinare e si compone, nella sua parte residenziale, di tre corpi edilizi contigui, che furono eretti in tre fasi diverse, ma che si susseguirono così da vicino che si può pensare ad un progetto unitario realizzato a scaglioni: si tratta in pratica di tre corpi di fabbrica ciascuno a perimetro rettangolare, allineati tra loro in diagonale e completati da giardini.
Il primo edificio è posto a Sud Est, si riconosce perchè è costruito tutto in laterizio, ha pianta quadrata di 50 metri di lato e si accompagnava ad un peristilio-giardino oggi scomparso. Si conserva una sala soggiorno con pareti alte ancora oggi circa 10 metri.
Il secondo edificio è quello centrale, fu costruito verso il 140-150, in opera mista di reticolato di tufo con ammorsature laterizie. E' la parte più alta dei resti archeologici dell'area.
Il terzo edificio fu costruito verso la fine del regno di Antonino Pio: è il più fastoso per le sue vaste aule a più piani e a prospetti finestrati (crollati nel 1951), venne a costituire il lato di fondo del peristilio-giardino. A Nord vi era un impianto termale, a Sud ampie sale di soggiorno. L'ippodromo giardino, lungo 320 metri, si può riconoscere nel suo perimetro per il dislivello del terreno o per il blocco edilizio che lo circonda nel lato corto e nel lato Nord occidentale.
La villa non era isolata nella campagna, ma circondata da altre costruzioni: cisterne, magazzini, abitazioni, templi. Tra queste a Nord Est della villa è ben conservato un piccolo tempio in laterizio a pianta rettangolare della fine del II secolo oggi mancante della facciata in antis[4] e della copertura (visibile in google maps, a Est dei ruderi principali, come edificio rettangolare senza tetto e coperto in tre lati su quattro). Un altro gruppo di rovine si trova su via di Capannelle prima della grande curva a destra, costituiva un avancorpo della villa sulla via Latina. Nelle vicinanze resti di un acquedotto, ramo privato dell'Acqua Claudia (anch'esso ben visibile da google maps).
Si prosegue per via di Capannelle fino ad una grande curva verso destra, qui è stata realizzata recentemente una rotonda dalla quale si stacca via Lucrezia Romana. Poco dopo c’è un’entrata al parco degli Acquedotti. Percorriamo un sentiero rettilineo, fino a raggiungere un grande quadrivio dove si trova la:
CASA CANTONIERA DEL SELLARETTO
Relativa alla ferrovia per Frascati del 1857 (prima ferrovia dello stato Pontificio e una delle più antiche d'Italia, disponeva di 6 locomotive con 6 vagoni viaggiatori, impiegava 28 minuti; era di costruzione inglese) poi proseguita a Ceprano del 1862.
A destra un largo viale alberato scende verso l'incrocio tra via Tuscolana e via di Capannelle, al termine un cancello permette solo il passaggio ai pedoni attraverso le sbarre in fello del cancello stesso (a sinistra ristorante "La Cascina", a destra il meraviglioso vivaio "Flora").
Nell'ultimo tratto la discesa è ripida e il fondo stradale sconnesso. Percorrendo questo viale vediamo sulla sinistra il grande palazzo vetrato della Polizia di Stato che ha il suo ingresso in via Tuscolana dopo piazza di Cinecittà e prima degli Studi Cinematografici. Nel panorama che abbiamo sulla sinistra si vede anche la chiesa di Don Bosco.
La chiesa, consacrata il 2 maggio 1959, opera di Gaetano Rapisardi[5], che è autore anche della piazza, è a forma di parallelepipedo, su cui sovrasta una grandiosa cupola orientaleggiante visibile da vari punti di Roma (es. Appia Antica). La cupola è coronata da statue di bronzo di Alessandro Monteleone[6]. Nella facciata si apre un portico a tre fornici: quello mediano è sormontato da un altorilievo raffigurante il Santo titolare fra Angeli e giovinetti, di Arturo Dazzi[7], mentre quelli laterali incorniciano le statue degli Arcangeli Gabriele e Michele, di Ercole Drei[8]; nelle nicchie le statue di San Francesco di Sales, di Giovanni Amoroso, di San Giuseppe Cafasso di Antonello Venditti, di Pio IX e Pio XI di Francesco Nagni. Sotto il portico si aprono cinque porte bronzee, di cui la mediana ornata di bassorilievi di Federico Papi e le due estreme sormontate dalle statue bronzee del Redentore e di San Giovanni Battista di Attilio Selva. La cupola ha un diametro di m 31.
Il viale che si diparte dal quadrivio verso sinistra raggiunge l'acquedotto, subito prima supera un fosso, quindi sottopassa l'acquedotto e porta al campo di golf. Qui un sentiero corre parallello all'acquedotto sia verso Nord che verso Sud.
Si riprende il viale centrale, detto di Roma Vecchia, perché era il viale di ingresso al Casale omonimo dalla via Tuscolana, meravigliosamente alberato, si sorpassa un acquedotto che appena sporge dal terreno, sulla sinistra si vedono – ad un livello più basso – i resti della
VIA LATINA
La via Latina è una strada molto più antica dell'Appia che ripercorre tracciati preistorici, fu percorsa dagli Etruschi per raggiungere la Campania, in effetti la strada rappresentò sempre un'alternativa all'Appia anch'essa diretta a Sud, ma percorrendo le valli del Sacco e del Liri (oggi Ciociaria). Il tracciato definitivo è del IV - III sec. a.C. Oggi il suo percorso è spezzettato nel tessuto urbanistico di Roma. Iniziava dall'isola Tiberina, poi da porta Capena insieme all'Appia, quindi dalla porta Latina nel tracciato delle mura Aureliane. Saliva verso Tusculum, passava dal passo dell'Algido[9], seguiva nella valle del Trerus oggi Sacco dove si congiunse in seguito con la via Labicana (Casilina), rasentava Anagnia e Ferentinum. A Fregellae scavalcava il fiume Liris (Liri), attraversava Aquinum, Casinum (ultima città del Latium) quindi passava tra gli Appennini e il gruppo vulcanico di Rocca Monfina (il primitivo tracciato si dirigeva a Nord Est per Venafro mettendo in comunicazione con la terra dei Sanniti) per arrivare dove oggi è la stazione ferroviaria di Caianello, toccava Capua (dopo 191 km di percorso), attraversava il Volturno e si immetteva sull'Appia. Durante il III sec. d.C. - grazie ad un imponente sforzo ingegneristico - la strada fu rettificata, basti pensare che il tratto da Roma a Grottaferrata era un unico rettifilo di 15 Km.
Il punto in cui è meglio visibile il vecchio tracciato è il parco delle Tombe Latine, un altro è nella Caffarella, tra la via di Vigna Fabbri e via Cordara.
Si procede per il viale di Roma Vecchia fino a trovare il
CASALE DI ROMA VECCHIA
Prende il nome dalla vicina villa dei Sette Bassi in quanto, data l'estensione delle sue rovine, nel Settecento si riteneva che questa era un'altra città antica vicina a Roma o precedente a Roma stessa (la stessa cosa accadde per la villa dei Quintili sulla via Appia Antica). Si tratta di un casale torre databile al XIII sec. Si trova in posizione strategica tra gli acquedotti dell'Acqua Claudia e Marcia lungo la via Latina, probabilmente era usata come stazione di posta. Nel cortile è una importante raccolta di materiali archeologici. Vi sono anfore, dolii e frammenti marmorei di ogni genere: cornici e architravi fastigiati, basi, colonne, capitelli, statue e sarcofaghi. Tra le iscrizioni si noterà quella di T. Statilio Optato, riguardante il personaggio di ordine equestre al tempo di Claudio o Nerone, e quella in versi con un acrostico scherzoso di Tito Elio Fausto che in vita godè i favori degli imperatori Marco Aurelio e Commodo[10].
Numerosi film sono stati girati in questo luogo. Ne citiamo solo uno: "Orgoglio", una fiction prodotta dalla Titanus e da Rai Fiction e trasmessa in tre serie (39 puntate) da Rai Uno a partire dal 2004. Il film è ambientato nell'agro romano ai primi del Novecento, per le scene è stato utilizzato palazzo Chigi di Ariccia, tra gli interpreti: Daniele Pecci, Elena Sofia Ricci, Franco Castellano, Cristiana Capotondi, Paolo Ferrari e Gabriella Pession. Regia di Giorgio Serafini e Vittorio De Sisti.
Si prende a destra del casale fino a trovare lo
STAGNO E FOSSO O MARRANA DELL'ACQUA MARIANA
Fosso artificiale fatto realizzare da papa Callisto II[11] nel 1120 per riportare a Roma l'acqua degli acquedotti Tepula e Julia, in gran parte era scoperto. Già nel Medioevo prese il nome di Marrana e tale nome presero in seguito tutti i fossi presenti nell'Agro Romano. Tale fosso ha origine nel bacino della Molara tra i colli Tuscolani e quelli Albani in essa confluiscono le acque della valle di Squarciarelli. Anticamente andava in direzione di Morena, poi Tor Sapienza (fosso di Tor Tre Teste) e si immetteva nell'Aniene. Fu il papa Callisto II a deviarlo da Morena (Centroni) sulla via Latina verso il corso dell'acquedotto Claudio e portarlo a Roma. Passava davanti a porta San Giovanni dove formava un laghetto usato come abbeveratoio, entrava nelle mura da porta Metronia, seguiva l'attuale via Druso, Circo Massimo, e sfociava nel Tevere presso la Cloaca Massima. La manutenzione era affidata al senatore della città, poi Bonifacio IX la demandò al capitolo di San Giovanni in Laterano. Innocenzo XII Pignatelli (1691-1700) durante la piena del Tevere del 1695 ordinò lo sbarramento dell'Acqua Mariana prima della confluenza nel Tevere, questo causò l'allagamento delle terre lungo il percorso. Con l'Unità d'Italia fu immessa nel collettore sinistro all'altezza della cosiddetta Passeggiata Archeologica, alla vigilia della prima Guerra Mondiale il fosso venne coperto da porta San Giovanni, negli anni Venti e Trenta venne coperto anche il tratto precedente lungo gli acquedotti. Nel 1957 il suo corso fu deviato nel fiume Almone.
Alle nostre spalle si trova, appena sopra il livello del terreno:
L’ACQUEDOTTO DELL’ACQUA MARCIA
E' l'acquedotto dell'Acqua Marcia condotta a Roma nel 144 a.C. dal pretore Quinto Marcio Re, alla fine del Cinquecento fu utilizzato per l'acquedotto Felice cosiddetto dal nome del papa Sisto V (1585-90) Felice Peretti.
L’Acqua Marcia è il terzo acquedotto di Roma antica in ordine di tempo (Aqua Appia e Anio Vetus), lungo circa 90 Km di cui 80 sotterranei, subì nel tempo numerosi restauri: con Augusto fu in gran parte ricostruito e venne raddoppiato nella portata con la captazione di una nuova sorgente detta Aqua Augusta nei pressi di Agosta, con Caracalla venne potenziata la portata con una nuova sorgente presso Arsoli e realizzò la diramazione dell’Aqua Antoniniana, da porta Furba (tracce sotterranee in circonvallazione Appia, sopraelevate in piazza Galeria, scavalca l’Appia sull’arco di Druso) destinata ad alimentare le terme di Caracalla. Diocleziano fece lo stesso. Le sue arcate vennero utilizzate anche per i condotti dell’Aqua Tepula e l’Aqua Iulia. Augusto, Tito e Caracalla lasciarono sulla porta Tiburtina iscrizioni a memoria dei loro interventi.
Raccoglieva l’acqua da una sorgente nell’alto corso dell’Aniene, oggi presso Marano Equo. Il primo tratto costeggiava la riva destra del fiume, lo scavalcava poco prima di Vicovaro, aggirava i monti Tiburtini, arrivava alla Prenestina. Giunto a Capannelle puntava su Roma seguiva la via Latina per circa Km 9, giungeva a Porta Maggiore (“ad spem veterem”) dove giungevano altri acquedotti, seguiva le mura Aureliane, superava quella che poi divenne porta Tiburtina e terminava presso porta Collina, dove oggi è via XX Settembre/via Piave. Qui sorgeva un castello di distribuzione delle acque. Il ramo principale copriva i 2/3 delle regioni urbane, un ramo secondario partiva da porta Tiburtina e serviva Celio e Aventino. La sua portata alla sorgente era di 2.251 litri al secondo.
Di fronte a noi, in tutta la sua imponenza:
L’ACQUEDOTTO DELL’ACQUA CLAUDIA
E' l'acquedotto che con una serie di arcate imponenti rendono caratteristico il luogo, la loro altezza arriva fino a 28 metri, al di sopra si trova in condotto nel quale scorreva l'acqua per una lunghezza di 68 Km. L'opera fu iniziata nel 38 d.C. da Caligola e portata a termine nel 52 d.C. dall'imperatore Claudio, ma numerosi furono gli interventi di restauro e trasformazione cui fu soggetto l'acquedotto durante i secoli dell'impero al fine di assicurarne sempre il buon funzionamento. Le arcate dell'acquedotto Claudio raggiungono la massima altezza in via del Quadraro. E' in blocchi di tufo tranne le chiavi di volta in travertino, ad esso si sovrappone l'Anio Novus in laterizio, anche questo acquedotto è dovuto agli stessi imperatori.
Raccoglieva le acque di ottima qualità da varie sorgenti nell’alta valle dell’Aniene presso i monti Simbruini, terminava il suo percorso a Porta Maggiore (“ad spem veterem”). Dal VII miglio della via Latina correva su arcate condivise con l’Anio Novus. In località Tor Fiscale incrociava due volte l’Acqua Marcia formando un recinto trapezoidale che venne utilizzato come fortificazione dagli Ostrogoti di Vitige in lotta con Belisario (539), il luogo si chiamò Campo Barbarico. Un ramo secondario fu voluto da Nerone per portare l’acqua alla Domus Aurea (Celio), ancora Domiziano lo deviò per i palazzi imperiali sul Palatino (resti in via di San Gregorio). La portata era di 2.211 litri al secondo. Il percorso era lungo Km 68 di cui 54 in canale sotterraneo.
L’Anio Novus che in questo tratto si sovrappone all’Acqua Claudia, fu anch’esso iniziato da Caligola e terminato da Claudio nel 52. A differenza del precedente captava le acque direttamente dal fiume Aniene. Era l’acquedotto più lungo, misurava Km 87 dei quali 73 in canale sotterraneo. La sua portata era di 2.274 litri al secondo, la maggiore di tutte.
Nel sito del parco appia antica / itinerari / parco acquedotti, c’è una bella mappa che chiarisce la direzione dei vari acquedotti.
Si riprende il viale centrale verso l’uscita, raggiunta l’area giochi, invece di uscire su via Lemonia, si aggira, dentro il parco stesso, la chiesa di San Policarpo, per raggiungere in un altopiano la:
VILLA DELLE VIGNACCE
Risale al 125-130 d.C. attribuita a Q. Servilio Pudente, ricco produttore di laterizi dei tempi di Adriano[12] (117-138) come dimostrano i bolli laterizi e i tubi in bronzo (fistulae) recanti il suo nome. I resti sono riferibili al complesso termale e a una cisterna a due piani alimentata dal vicino acquedotto Marcio.
E' da questa villa che provengono la testa colossale marmorea di "Giulia Domna", le statue di "Tyche" di Antiochia e di "Ganimede rapito dall'aquila" custodite ai musei Vaticani[13].
"A nord-est un terrazzo lungo oltre 120 metri ha al centro una fontana e si conclude con cisterne coperte. Una grande aula a sud era forse un ninfeo, mentre a est era la parte termale. Circa 130 metri a sud ovest si trova una grande cisterna"[14].
"La villa sorgeva su un grande terrazzamento che fronteggia via Lemonia e che si ornava al centro di una fontana absidata e all'esterno di una serie continua di speroni (l'insieme è però riconoscibile a fatica o non lo è affatto). Il nucleo principale rimasto è la parte termale con una sala circolare (è la prima che si vede venendo da san Policarpo) ne rimane circa un quarto) già coperta a cupola e circondata da altri piccoli ambienti absidati che ne sostenevano l'arco della volta sul tamburo. A nord ovest sono i resti di una vasta aula rettangolare absidata, cui si accompagnavano su ciascun fianco altri due ambienti. Notare il muro in opus reticolatum.
La villa fu costruita in età adrianea".[15]
Torniamo sui nostri passi, troviamo un viale sterrato alla nostra destra che va verso gli archi del primo acquedotto. Il viale passa sotto questo primo acquedotto, il fornice prima contiene, a terra, una grande pietra che ricorda don Roberto Sardelli. Nel sopralluogo effettuato il giorno 11.11.15 la lapide è scomparsa.
DON ROBERTO SARDELLI
molto si prodigò per i poverissimi immigrati (650 famiglie) che abitavano le arcate degli acquedotti fino ai primi anni Settanta. La lapide è stata posta dal collettivo di artisti e architetti che studia e mappa la città con particolare attenzione verso i territori marginali della città o in via di trasformazione. Qui le baracche erano senza luce, acqua e fogne, in una di esse don Sardelli fondò la "Scuola 725" dal numero della baracca, di m 3 x 3, con candele e una stufa sbuffeggiante. Nato a Pontecorvo nel 1935 aveva frequentato la scuola di Barbiana di don Milani, quindi in Francia tra i preti operai, poi a Roma nella parrocchia di San Policarpo, quando decise di andare a vivere in una baracca. Nella sua scuola insegnava a leggere e scrivere ad adulti e bambini, con loro compilava un giornale nel quale gli studenti raccontavano le loro storie, commentavano le notizie dei giornali, il testo così ottenuto diventava libro di testo: "Non tacere". Nella baracca capitarono intellettuali come Moravia, Pasolini e il sociologo Franco Ferrarotti. Nel 1973 le ruspe abbatterono le baracche e gli abitanti furono trasferiti in case popolari ad Acilia o a Nuova Ostia. In seguito si interessò dei Rom e creò un gruppo che praticava il flamenco. Dal 1989 al 1998 si occupò dei malati terminali di Aids.
Questo è un ottimo punto per osservare la:
CHIESA DI SAN POLICARPO
Rappresenta l’edificio principale di una delle poche piazze di Roma con portici. La chiesa è posizionata, nella pianta del quartiere, come corrispondente, ma opposta, alla chiesa di San Giovanni Bosco (via Giulio Agricola – via Marco Fulvio Nobiliore).
La costruzione è avvenuta tra il 1964 e il 1967 su progetto dell’arch. Giuseppe Nicolosi[16], la sua consacrazione il 15 luglio 1967. L’impianto è esagonale e ribadito dal tiburio che si staglia sullo sfondo verde del parco degli Acquedotti, la costruzione è visibile anche a grande distanza, come dall’Appia Antica. La semplicità della figura geometrica di base esalta la semplicità dell’interno e la forza scultorea dell’esterno. L’autore si è ispirato ad una lanterna. Sei pilastri interni sorreggono altrettante travi a sostegno della volta che formano la figura della stella di David. Notare i mattoni messi di punta. Singolare la via Crucis formata da chiodi di lunghezza e tipologia diversa. San Policarpo è stato vescovo e martire di Smirne (attuale Turchia), nato nel 69, morto martire nel 155. Fu posto a capo della chiesa di Smirne dagli apostoli stessi. Nel 154 si recò a Roma per discutere con il papa Aniceto sulla data della Pasqua. E’ stato ucciso con la spada.
La parrocchia è preesistente alla chiesa, infatti fu istituita dal cardinale Clemente Micara nel 1960. Negli anni Cinquanta e Sessanta qui vennero girati film del Neorealismo in cui si vede la campagna romana prossima alle case in costruzione e i baraccati che vivono ai margini della città legale. In questo punto venne girato il film di Pasolini “Mamma Roma”[17]. Nei primi anni Settanta la chiesa venne occupata dai baraccati che vivevano sotto gli archi dell’acquedotto alle spalle della chiesa per chiedere una casa popolare, la protesta avvenne con il consenso del parroco don Sardelli. Ottennero la casa a Nuova Ostia in un palazzo lungo Km1,4 che fiancheggia via dell’Idroscalo.
Si riprende il viale centrale, ormai ridotto a sentiero, che segue le mura dell’acquedotto. Si sottopassa la via del Quadraro grazie ad un passaggio reso meno scosceso dai volontari del parco che ci permette di giungere in breve nel parco di Tor Fiscale.
PARCO DI TOR FISCALE
Il parco è stato inaugurato ad aprile 2001, si tratta di una delle aree archeologiche più interessanti e meno conosciute di Roma. Fa parte del Parco Regionale dell’Appia Antica dal 2005, quando la giunta regionale (presidente Piero Marrazzo) approvò una delibera in tal senso.
Per raggiungerlo dobbiamo prendere dalla via Appia Nuova, la via di Tor Fiscale, in fondo ad essa ecco il parco con la grande torre spostata sulla destra. Tor Fiscale è una magnifica costruzione del XIII secolo alta circa 30 metri, costruita proprio nel punto in cui si incrociavano gli acquedotti Marcio e Claudio in modo che si potesse rilevare maggiormente. Detta anche Torre Branca, dal nome del tesoriere (fiscale) proprietario delle vigne della zona nel secolo XVII, permetteva il controllo della via Latina e di un vasto tratto di campagna romana. La torre è situata all’incirca al IV miglio della via Latina. A monte di Tor Fiscale gli acquedotti Marcio e Claudio si intersecano nuovamente tra loro, racchiudento uno spazio trapezoidale. Questo luogo così singolare porta ancora oggi il nome di Campo Barbarico perchè nell'assedio di Roma del 539 da parte dei Goti di Totila, questi, per controllare le vie di accesso alla città tenuta da Belisario costruirono proprio qui un campo trincerato, utilizzando la particolare conformazione degli acquedotti e chiudendo con pietre e terra le luci.
Scrive lo storico Procopio: "Esistono ancora oggi due acquedotti tra la via Latina e la via Appia, molto alti e per lungo percorso rilevati su archi. Questi acquedotti, alla distanza di 50 stadi da Roma, vengono ad incontrarsi, volgendo poi in senso contrario, così che quello che prima era sulla destra passa alla sinistra, riunendosi poi ancora e riprendendo il precedente percorso. I barbari, stipati con pietre e fango la parte inferiore dei fornici diedero al luogo la forma di castello ponendovi così un presidio di non meno di 7.000 uomini perchè controllassero che i nemici non introducessero in città vettovaglie".
Nei pressi è stato restaurato un casale (2012) adibito a ristorante aperto il sabato e la domenica, un altro casaale è diventato museo del parco. E' presente un punto informativo del parco. Nei pressi si trova una fungaia ancora oggi utilizzata con questo scopo ed aperta al pubblico su prenotazione.
BORGATA DI TOR FISCALE
Tor Fiscale è una borgata nata con funzioni agricole poi popolata di immigrati dall'Italia meridionale e dalle campagne del Lazio. All'ultimo censimento vi abitano 2.174 persone. Tra il 1970 e il 1980 il Comune avviò alcune opere di urbanizzazione primaria: rete idrica, fognaria, illuminazione e gas metano), il 24 aprile 1976 venne perimetrata l’area di Tor Fiscale in funzione di un suo recupero urbanistico. Negli anni Novanta, a causa del calo demografico, la chiusura della scuola Media prima, e della scuola Elementare poi, tolsero un importante servizio al quartiere. In quegli anni, all’interno di un deposito Cotral dismesso, si stabilirono degli extracomunitari, che vivevano in gravissime condizioni igieniche, l’accampamento venne eliminato dal Comune di Roma dopo alcuni mesi.
Dalla via Appia si volta a sinistra su via Anicio, quindi a sinistra su via Monte d'Onorio fino a via del Campo Barbarico. All'incrocio di queste due ultime vie, sotto l'apparenza di un VECCHIO FIENILE si conserva in tutta l'altezza un sepolcro rettangolare laterizio di età antonina. Al suo interno si noterà sul fondo una grande nicchia tra due minori e superiormente un'abside con copertura a catino, sempre tra due minori a fondo piano e copertura ad arco ribasssato, sono visibili resti della decorazione a stucco.
“Si tratta di un colombario di ragguardevoli dimensioni… dell’ingresso antico non c’è più traccia, così come è andata del tutto distrutta la volta del primo piano allorquando il monumento fu trasformato in fienile. Il rivestimento interno conserva stucchi originari e delle decorazioni in cotto. Lo stato di conservazione generale è discreto”[18].
In questa via, ma ad angolo con via di Torre del Fiscale si trova il CASALE RAMPA e il suo borgo, il cuore della borgata, il casale era un'antica vaccheria (quest'ultima notizia da: comune.roma.it / municipio IX / parco di tor fiscale). “La cisterna, di cui rimangono solo alcuni tratti di muratura in opera reticolata, è inglobata nell’antico casale Rampa, nel mezzo di alcuni casali della stessa età. Lungo la strada che fiancheggia la costruzione e che ricalca sempre il tracciato della via Latina, si possono riconoscere alcuni blocchi di marmo romano e frammenti di materiale archeologico[19]”.
Nella stessa via si trova la CHIESA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE costruita nel 1955 prende il nome dal santo a cui è dedicata la basilica del V secolo voluta da Leone Magno nel vicino parco delle Tombe Latine. La chiesa fu visitata da papa Paolo VI il 10 aprile 1966 e da papa Giovanni Paolo II il 26 aprile 1998. E’ a pianta rettangolare, presenta sull’altare maggiore una statua in ceramica che raffigura colui che la Chiesa ritiene il primo martire della sua storia ucciso il giorno di Pentecoste, come raccontato negli Atti degli Apostoli. Sopra il portone d’ingresso il santo è raffigurato tra due palme che simboleggiano il martirio. Campanile a vela.
Via di Campo Barbarico ricalca il percorso della via Latina.
In fondo a via di Tor Fiscale si trova via di Torre Branca che costeggia il parco di Tor Fiscale e sulla quale si aprono vari ingressi del parco stesso. Hai una foto d’epoca di via di Torre Branca scattata mentre passa una processione. In vicolo di Tor Fiscale si trova l’ingresso al centro sportivo – ristorante LA TORRE, vicinissimo a Tor Fiscale stessa.
“Il piano particolareggiato di Tor Fiscale, avviati nel contesto di quelli in zona “O” di piano regolatore per il recupero delle borgate ha rappresentato un buon esempio di riqualificazione dell’area e ha saputo stabilire un rapporto organico con le importanti emergenze archeologiche e monumentali della zona”[20].
AGGIORNAMENTI
6.5.15 Ripristino del paesaggio. Lungo il viale di Roma Vecchia sono stati messi a dimora 25 nuovi alberi di pino domestico in sostituzione di altrettanti morti negli ultimi anni. Questo viale costituisce una delle vedute più belle e famose di Roma. La sostituzione è opera dell’Ente Parco Appia Antica, del Comune e del Municipio VII. Gli alberi hanno una età variabile tra i 10 e i 15 anni, avranno cure attente per i prossimi tre anni.
Giugno 2015 Il restauro degli acquedotti presenti nel parco di Tor Fiscale (compresa la torre stessa) è stato appena concluso.
BIBLIOGRAFIA
- AA.VV. Guida d’Italia, Roma, ed. Tci, 1993.
- AA.VV. Roma, libri per viaggiare, ed. Gallimard – Tci, 1994.
- AA.VV. I rioni e i quartieri di Roma, ed. Newton & Compton, 1989.
- AA.VV. Le strade di Roma, ed. Newton & Compton, 1990.
- Claudio Rendina (a cura di), Enciclopedia di Roma, ed. Newton & Compton, 2005.
- AA.VV. Charta Appia, ed. Palombi, s.d.
- AA.VV. Il parco dell'Appia Antica, ed. dipartimento X del Comune di Roma, s.d.
- AA.VV. Il parco dell'Appia Antica, ed. Humus, s.d.
- Carlo Villa, Le strade consolari di Roma, ed. Newton Compton, 1995.
- AA.VV. Enciclopedia Universale, ed. Garzanti, 2003.
- AA.VV. Enciclopedia dell’Arte, ed. Garzanti, 2002.
- Stefania Quilici Gigli, Roma fuori le mura, ed. Newton Compton, 1986.
- Roma ieri, oggi e domani, ed. Newton Compton.
- Forma Urbis, ed. Service Sistem.
- Capitolium, ed.
- AA.VV. Stradaroma, ed. Lozzi, 2005.
- AA.VV. Tutto Città, 2011/2012, ed. Seat.
- AA. VV. Carta dei parchi e delle aree naturali protette.
- Mappa dei percorsi ciclopedonali, 2008.
- Roma in bici. Mappa del pc presenti e future, Comune di Roma, 2001-08.
SITOGRAFIA
www.comune.roma.it
www.archeoroma.beniculturali.it
www.romasegreta.it
www.laboratorioroma.it
www.romasparita.eu
www.info.roma.it
www.abcroma.com
www.romanoimpero.com
www.archeoroma.com
www.amicidiroma.it
www.romaspqr.it
www.tesoridiroma.net
www.iloveroma.it
www.romasotterranea.it
www.sotterraneidiroma.it
www.repubblica.it
www.corriere.it
www.ilmessaggero.it
www.romatoday.it
www.ansa.it
www.viamichelin.it
www.tuttocittà.it
www.parcoacquedotti.it
www.parcoappiaantica.it
Piero Tucci
22.11.15
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
[1] Estenzione del parco il dato è fornito da: it.wikipedia.it e confermato da: parcoacquedotti.it. Non è credibile amicidiroma che parla di soli 15 ettari.
[2] Acquedotti costruiti dai romani in tutto erano 11.
[3]Antonino Pio imperatore romano dal 138 al 161. Rientra tra gli imperatori per adozione, fu successore di Adriano. Di carattere mite, diminuì le spese dell’impero, visse modestamente e passò alla storia come il migliore imperatore romano.
[4] Tempio in antis = nei templi greci e latini erano così chiamati quelli che avevano le pareti dei lati lunghi che si rpolungavano in avanti fino a costituire le ante (antae) per delimitare lateralmente il pronao.
[5] Gaetano Rapisardi (Siracusa 1893 - Roma 1988) architetto. Sposò la figlia di Gino Coppedè. Con Piacentini prese parte al progetto della Città Universitaria. Progettò il palazzo di Giustizia di Palermo e di Pisa. Con lo scultore Arturo Dazzi iniziò a costruire a Livorno il mausoleo della famiglia Ciano, rimasto incompiuto.
[6] Alessandro Monteleone (Taurianova, Reggio Calabria 1897 - Roma 1967) principalmente scultore, titolare della cattedra di scultura all'Accademia di Roma. Con Nagni ha realizzato una delle porte di San Pietro.
[7] Arturo Dazzi (Carrara 1881 - Pisa 1966) scultore. Una delle sue prime opere I costruttori fu acquistata dalla Gnam. Lavorò con Rapisardi al mausoleo di Ciano rimasto interrotto. Realizzo un colosso marmoreo in piazza della Vittoria a Brescia, simbolo del fascismo, rimosso dopo la liberazione ed ora nei depositi comunali.
[8] Ercole Drei (Faenza 1886 - 1973) soprattutto scultore ma anche pittore e disegnatore. Ha abitato a villa Strohl Fern dal 1921 alla morte. Bassorilievi per il ponte Duca d'Aosta a Roma, la stele per il lavoro nei campi nel giardino dell'Eur, il Seminatore alla Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale. Presente alla Quadriennale romana e alla Biennale.
[9] Passo dell’Algido. Si trovava tra Lariano e i Pratoni del Vivaro (Tuscolo). Fu importante nei primi anni della Repubblica Romana per le battaglie con gli Equi e i Volsci.
[10] Casale di Roma Vecchia le notizie della raccolta archeologica presente nella corte del casale da: Stefania Quilici Gigli, Roma fuori le mura, ed. Newton, 1986, pag.145.
[11] Callisto II papa dal 1119 al 1124. Fu ecclesiastico riformatore e aveva un forte punto di vista sulla “lotta per le investiture”, ma fu disposto a negoziare con Enrico V che lo portò a raggiungere il Concordato di Worms con il quale venivano stabiliti i mutui diritti di Chiesa e Impero. Nel 1123 tenne il Primo Concilio Laterano. Era di nascita francese.
[12] Adriano (imperatore dal 117 al 138) Saggio quanto il suo predecessore Traiano, fu un uomo molto colto. Viaggiando continuamente attraverso l’impero controllò personalmente le necessità dei suoi sudditi. In Britannia eresse il famoso Vallo, a Roma la Mole Adriana poi Castel Sant’Angelo, presso Tivoli la villa che porta il suo nome e dove fece riprodurre i monumenti più belli che aveva conosciuto girando per l’impero.
[13] Statue proveniente dalla villa delle Vignacce la notizia da: "I rioni e i quartieri di Roma" op.cit. vol. VIII pag. 2224.
[14] Villa delle Vignacce questa descrizione è tratta dal depliant "Il parco regionale dell'Appia Antica" ed. Humus.
[15] Villa delle Vignacce, questa descrizione è tratta da: Stefania Quilici Gigli, Roma fuori le mura, ed. Newton, 1986, pag.144.
[16] Giuseppe Nicolosi (1901-1981) nel 1928 realizzò cinque villini alla Garbatella, nel 1956 progettò l'ampliamento della facoltà di Ingegneria di Roma, fu tra i progettisti del quartiere Ina Casa di Torre Spaccata con la chiesa Regina Mundi. Fu tra gli autori del PRG della Città dell'Aria a Guidonia, progetto abbandonato in seguito alle distruzioni belliche.
[17] Film "Mamma Roma" del 1962 con Anna Magnani e Franco Citti, soggetto, sceneggiatura e regia di Pier Paolo Pasolini. Altre scene girate nel palazzo dei ferrovieri a Casal Bertone e al quartier Ina Casa Tuscolano. Spesso appare in lontanza la cupola di Don Bosco.
[18] Fienile di Tor Fiscale. Questo paragrafo è tratto da: Maria Letizia Sementilli, Il patrimonio archeologico della IX Circoscrizione, Comune di Roma, 1988, pag.75.
[19] Casale Rampa. Il paragrafo tra virgolette è preso da: Sementilli, Il patrimonio archeologico della IX Circoscrizione, Comune di Roma, 1988, pag. 76.
[20] Piano Particolareggiato di Tor Fiscale. La considerazione urbanistica è tratta da: Paolo Grassi, Il IX Municipio dal 1870 ad oggi, in: AA.VV. Il parimonio culturale del IX Municipio, ed. Comune di Roma – Palombi editore, 2010, pag. 127.
INTRODUZIONE
Il mausoleo è una tomba di eccezionale monumentalità costruita per conservare il corpo di un grande personaggio e i membri della sua famiglia. In genere ha al suo interno una stanza in cui si conservano sarcofagi o urne cinerarie.
Il termine deriva dal re Mausolo di Caria, satrapo persiano, la cui moglie Artemisia fece costruire il famoso Mausoleo di Alicarnasso (oggi Bodrun, Turchia, sul mar Egeo, non lontano da Rodi), nel 351 a.C. una delle sette meraviglie del mondo[1]. Vi lavorarono artisti come Prassitele, Briassi, Leochares, Timoteo e Skopas. Fu distrutto da un terremoto, oggi sono visibili le rovine e i resti dei cavalli e della quadriga al Britsh Museum di Londra.
MAUSOLEO DI AUGUSTO
in Campo Marzio, presso l'Ara Pacis.
Noto anche come Augusteo è la tomba dell'imperatore Augusto e della sua famiglia, si tratta del più imponente monumento funerario del I secolo a.C. sorse in un'area chiamata Campo Marzio.
Il Mausoleo di Augusto fu iniziato nel 29 a.C. al ritorno da Alessandria del primo imperatore dei romani dopo che aveva visitato l'Egitto e dove aveva visto la tomba di Alessandro Magno ispirata a quella di Alicarnasso.
Il primo ad essere sepolto nel Mausoleo fu Claudio Marcello, nipote di Augusto, a cui è intitolato anche il teatro, tale sepoltura avvenne nel 23 a.C. Seguirono la madre di Augusto Azia Maggiore, Marco Vipsanio Agrippa, Druso Maggiore, Lucio e Gaio Cesare. Augusto venne sepolto nel 14 seguito da Germanico e Livia. Non sappiamo se vi furono sepolti Vespasiano e Claudio. L'imperatore Caligola vi portò le ceneri della madre Agrippina e dei fratelli. La figlia di Augusto Giulia Maggiore e l'imperatore Nerone vennero invece esclusi per indegnità. L'ultimo ad essere sepolto fu Nerva nel 98, mentre il suo successore Traiano venne cremato e le sue ceneri poste ai piedi della colonna Traiana. L'ultima ad esservi sepolta fu Giulia Domna, nel 217, moglie di Settimio Severo, che sosteneva di discendere dalla famiglia Julia.
Il monumento venne per secoli saccheggiato e deturpato, trasformato in fortezza dai Colonna (detta l'Agosta conquistata e smaltellata da papa Gregorio IX), utilizzato come cava di materiali, addirittura fu trasformato in una terrazza per la coltivazione della vite, ospizio per signore indigenti, teatro e da ultimo come sala da concerti detta l'Augusteo. Nel 1354 venne utilizzato per cremare il corpo di Cola di Rienzo ucciso durante un tumulto e trascinato fin qui per sfregio per le strade della città. L'urna che conteneva le ceneri di Agrippina Maggiore, madre di Caligola, fu trasformata in contenitore e unità di misura di granaglie, usata al mercato del Campidoglio, piena conteneva una rubiatella ovvero un quintale di cereali. Su di essa venne inciso lo stemma del Comune di Roma sorretto da un balestriere. Oggi è conservata ai musei Capitolini. Dal Cinquecento, a cura della famiglia Soderini, venne adattato ad arena ed utilizzato per le giostre, esercitazini di giovani romani sulla groppa di tori o bufale, in quegli anni il luogo venne chiamato Corea dal nome dell'impresario di tali giostre il portoghese Vincenzo Corea, tali esibizioni vennero abolite nel 1829. Il banchiere Telfmer, ai primi del Novecento, lo coprì con un lucernaio e lo trasformò in sala da spettacoli, quindi magazzino, poi studio dello scultore Chiaradia che vi modellò la statua di Vittorio Emanuele II posta sul Vittoriano. Dal 1905 il Comune di Roma lo adattò a sala da concerti, prese così il nome di Auditorium Augusteo. La programmazione musicale durò fino al 1930 quando la sala venne demolita per i lavori di scavo e indagine archeologica. In base al piano regolatore del 1931 il monumento venne liberato dall'interramento e dalle strutture che vi si erano appoggiate. La piazza realizzata tra il 1937 e il 1940 si deve all'architetto Vittorio Ballio Morpurgo[2] che si ispirò ad uno stile freddamente monumentale. Contestualmente si ebbe l'isolamento delle chiese di San Carlo al Corso (abside con le due gigantesche statue di San Carlo di Attilio Selva e di Sant'Ambrogio di Arturo Dazzi), di San Rocco e San Girolamo degli Illirici o dei Croati (più vicina a via Tomacelli).
Il mausoleo aveva un basamento quadrangolare alto m 12 e forse terminato da un fregio con metope e triglifi, su di esso poggiava l'edificio circolare (m 87 di diametro) composto da sette anelli concentrici collegati da muri radiali, al di sopra un tamburo con il tumolo (terra e piante sempreverdi). Al centro un grande pilastro contenuto in una stanzetta circolare con la tomba di Augusto (urna con le ceneri) in significativa corrispondenza con la statua bronzea dell'imperatore che sorgeva alla sommità del pilastro (m 44). Augusto morì nell'anno 14, il 19 sestile detto in suo onore Agosto. Sono stati ritrovate l'urna cineraria della sorella di Augusto Ottavia e l'epigrafe che ricordava Marcello. Doveva trovarsi all'interno di giardini aperti al pubblico.
L'ingresso era sul lato Sud, davanti erano i due pilastri con affisse le tavole bronzee sulle quali era incisa l'autobiografia ufficilae di Augusto (Res gestae Divi Augusti detto Monumentum Ancyrarum dal nome della città in cui venne ritrovato Ancyra oggi Ankara) di cui una copia è giunta fino a noi (tempio di Augusto e Roma ad Ankara). Tale autobiografia è incisa oggi sulla parete esterna della teca che contiene l'Ara Pacis. L'ingresso era fiancheggiato da due obelischi provenienti dall'Egitto, oggi sono al Quirinale e all'Esquilino.
La piazza è attualmente interessata da lavori di riqualificazione che sono stati assegnati dopo un concorso pubblico bandito nel maggio 2006, a luglio erano stati presentati 48 progetti, una commissione ne ha selezionati dieci e a novembre è stato scelto quello presentato dall'architetto Francesco Cellini. Contestualmente era previsto un sottopasso per il lungotevere in modo da unire l'Ara Pacis ad un affaccio pedonale al Tevere. Molte polemiche hanno fatto si che questo progetto fosse bocciato anche perchè si prevedeva un parcheggio sotterraneo. Il muro dell'Ara Pacis davanti alla fontana sarà abbassato per permettere la visuale delle facciate delle due chiese (San Girolamo degli Illiri e San Rocco) dal lungotevere. Il livello stradale della piazza (pedonalizzata) sarà abbassato per avvicinarlo all'ingresso dell'Augusteo. Dei gradini molto bassi e lunghi risaliranno verso il Tevere. I lavori cominceranno nel 2013 e dureranno un anno e mezzo, costo 17 milioni[3]. Dovrebbe essere tutto pronto per il bimillenario della morte di Augusto 14-2014.
MAUSOLEO DI ADRIANO
Castel Sant'angelo
Grandiosa opera voluta e probabilmente ideata dallo stesso imperatore Adriano e forse eseguita dall'architetto Demetriano. Iniziato nel 135[4] fu compiuto da Antonino Pio nel 139, un anno dopo la morte dell'imperatore; per raggiungere questo luogo venne costruito il pons Aelius poi ponte Sant'Angelo, uno dei pochi ponti sul Tevere sempre funzionante, principale porta di accesso a San Pietro per i pellegrini e per i romani stessi. Nel corso dei secoli ha subito profonde trasformazioni fino a rederlo il castello della città, il suo punto difensivo più saldo. Il "Passetto" lo collega a San Pietro. Nonostante 1.900 anni di demolizioni, ricostruzioni, cambiamenti di funzioni, il monumento resta abbastanza leggibile. Oggi è sede del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo[5] visitato ogni anno da 700.000 persone.
L'imperatore Adriano lo volle per se e la sua famiglia. Vi furono sepolti, oltre all'imperatore Adriano e a sua moglie Sabina, il suo successore e figlio adottivo Antonino Pio e sua moglie Faustina Maggiore con i loro tre figli, gli imperatori Elio, Commodo, Marco Aurelio con i suoi tre figli, Settimio Severo e sua moglie Giulia Domna con i figli e imperatori Geta e Caracalla. Era composto di una base cubica di m 84 di lato, rivestita di marmo lunense, con un fregio decorativo a teste di buoi, detti bucrani, e lesene angolari. Nel fregio prospiciente il fiume si leggevano i nomi degli imperatori sepolti all'interno. Sempre su questo lato si trovava l'arco di ingresso intitolato ad Adriano, il dromos (passaggio di ingresso al mausoleo) era interamente rivestito di marmo giallo antico.
Al di sopra del cubo di base era posato un tamburo realizzato in peperino e opera cementizia di m 64 di diametro, il tutto rivestito in travertino e lesene scanalate. Al di sopra di esso vi era il tumulo di terra alberato circondato da statue di cui restano frammenti. In cima si trovava una quadriga in bronzo guidata dall'imperatore Adriano in figura di sole. Attorno al mausoleo correva un muro di cinta con cancellata in bronzo decorata da pavoni, due di essi sono conservati ai musei Vaticani. All'interno si trova la scala elicoidale in laterizio che sale alla cella posta al centro del tumolo. La cella era a pianta quadrata, rivestita di marmi policromi e sormontata da altre due sale, ancora esistenti, anch'esse celle sepolcrali.
Il mausoleo cambiò nome nel medioevo, quando nel 590 la città era afflitta da una grave pestilenza, per allontanarla il papa Gregorio I Magno organizzò una processione che - giunta in prossimità del mausoleo - si fermò in quanto il papa disse di aver visto l'arcangelo Michele che rinfoderava la spada, segno dell'imminente fine dell'epidemia. Da allora i romani chiamarono il mausoleo Castel Sant'Angelo. A ricordo del prodigio, nel XIII secolo venne posta la statua dell'angelo nel punto più alto del Castello. La statua bronzea attuale è opera di Pietro Von Verschaffelt e sostituisce l'antica in pietra di Raffaellino da Montelupo, uno dei collaboratori più stretti Michelangelo, oggi nel cortile d'onore o delle Palle per i cumuli di palle di granito e travertino munizioni del castello.
Quando nel 403 l'imperatore Onorio incluse l'edificio nelle mura Aureliane, da quel momento divenne un baluardo avanzato oltre il Tevere nella difesa della città. Il castello fu valido punto di difesa e non venne conquistato durante il Sacco di Roma dei Visigoti di Alarico nel 410 e durente il sacco del Vandali di Genserico nel 455. In quest'ultima occasione i difensori del castello scagliarono contro i barbari tutto quello che avevano, comprese le statue, così il fauno Barberini sarà ritrovato nei fossati. Esso ebbe parte importante nella guerra gotica. Teodorico fu il primo a farne un carcere.
Il suo possesso fu causa di lotte tra le famiglie nobili romane. Nel X secolo fu possesso del senatore Teofilatto e della sua famiglia tanto che la figlia di costui Marozia (concubina di Sergio III) volle sposarsi nella camera sepolcrale degli imperatori. Da allora il castello venne usato anche come prigione, uso che conservò fino al 1901.
Il castello passò poi ai Crescenzi (tanto che venne chiamato Castrum Crescentii), ai Pierleoni e agli Orsini. Niccolò III Orsini (1216 - 1280, papa dal 1277) vi trasferì parzialmente la sede apostolica perchè il palazzo Lateranense era considerato poco sicuro. In quell'occasione fece costruire il celebre "Passetto". Nel 1367 le chiavi del castello vennero simbolicamente affidate ad Urbano V per invogliarlo a porre termine alla cattività avignonese (1305 - 77). Da allora in poi il Castello identifica la sua storia con quella dello stato della Chiesa, non fu solo fortezza e rifugio nei momenti di pericolo, anche archivio, tesoro, tribunale e prigione. Nel 1395 il papa Bonifacio IX incaricò l'architetto Niccolò Lamberti di eseguire una serie di interventi di potenziamento, da allora entrare nel castello sarà possibile solo attraverso un ponte levatoio. In pieno Rinascimento Nicolò V dotò il Castello di una residenza papale. Alessandro VI Borgia incaricò Antonio da Sangallo il Vecchio di ulteriori lavori di fortificazione per cui furono costruiti i quattro bastioni pentagonali dedicati agli Evangelisti, lo stesso papa fece erigere un nuovo appartamento affrescato dal Pinturicchio. Queste opere permisero di reggere l'assalto dei Lanzichenecchi del 6 maggio 1527 durante il famoso Sacco di Roma durante il pontificato di Clemente VII.
Quest'ultimo papa fece costruire la Stufa, cioè il bagno privato, una piccola stanza affrescata con ornamenti profani.
Visto il buon esito dell'assedio i succesivi papi fecero eseguire altre fortificazioni e per la decorazione delle stanze venne chiamato Perin del Vaga e Livio Agresti (sotto papa Paolo III). Clemente IX (tra il 1667-69) fece collocare dieci angeli di marmo sul ponte che da allora si chiamerà Sant'Angelo. Nell'Ottocento venne utilizzato come carcere politico. Dopo l'unità d'Italia venne impiegato come caserma, sottoposto a restauri da parte del genio militare e finalmente il 13 febbraio 1906 destinato a museo. Nel 1933-34 furono ripristinati i fossati e sistemata a giardino tutta la zona intorno al castello.
Numerosi i detenuti del castello. Tra i più celebri Benvenuto Cellini (1538) che riuscì ad evadere con un corda fatta con le lenzuola; il celebre avventuriero Giuseppe Balsamo detto conte di Cagliostro, il celebre umanista Platina, lo studioso Pomponio Neto, la sventurata Beatrice Cenci, il frate riformatore Giordano Bruno. Numerosi i patrioti nel Risorgimento.
Le prigioni costituiscono lo scenario del terzo atto della Tosca di Giacomo Puccini.
Oggi guardando dall'esterno si presenta in basso con una cinta quadrata rafforzata agli angoli da bastioni, al centro il nucleo romano riconoscibile dai grandi blocchi di travertino e peperino, quindi il maschio cilindrico rialzato da Benedetto IX (1033 - 44)
e completato in alto dalla bella cortina in cotto di Alessandro VI Borgia coronata da beccatelli, più sopra ancora la costruzione rinascimentale degli appartamenti papali, ornata dalla leggiadra loggia marmorea di Giulio II Della Rovere; in cima, la grande terrazza sormontata dalla statua bronzea dell'Angelo ad ali spiegate. Il giorno di San Pietro e Paolo, 29 giugno, santi patroni di Roma, vi si tiene uno spettacolo pirotecnico denominato la "Girandola", rievocazione di analogo spettacolo rinascimentale documentato da dipinti oggi al Museo di Roma in Trastevere.
MAUSOLEO DI LUCILIO PETO
su via Salaria prima dell'incrocio con via Po.
Chiuso da una cancellata, semicoperto dalla vegetazione, si trova dopo villa Albani, di fronte a via Basento. Grandioso monumento dell'epoca augustea, cilindrico e con grande epigrafe sulla fronte che ci informa che Lucilio Peto lo costruì quando era ancora in vita per sè e la sorella Lucilia Polla, era coperto da un tumulo di terra e contiene una camera sepolcrale. Il basamento cementizio è rivestito di travertino, con cornice a dentelli. Nella parte posteriore la porta che dà accesso al corridoio nelle cui pareti sono scavati numerosi loculi, il corridoio conduce alla camera sepolcrale.
Nel IV secolo al di sotto del mausoleo fu scavata una catacomba, a questa si giunge sempre attraverso il corridoio.
Nei pressi, ma sull'altro lato della strada, si vede villa Albani Torlonia di proprietà privata (famiglia Torlonia) opera settecentesca dell'architetto Carlo Marchionni[6]. Conserva un'importante collezione di arte antica, in particolare sono di notevole interesse le pitture della tomba Francois di Vulci (IV sce. a.C.) e altri reperti di quell'area etrusca del viterbese. Il parco della villa è sistemato secondo il gusto dei giardini all'italiana. Nel casino centrale sono conservate opere di Perugino, Tintoretto, Giulio Romano, David e altri.
Poco più avanti una lapide ricorda il luogo esatto in cui fu ucciso dalle Brigate Rosse il professor Massimo D'Antona, consulente del ministero del Lavoro, il 20 maggio 1999. Gli autori del tragico fatto di sangue sono stati arrestati e condannati dopo tre gradi di giudizio.
MAUSOLEO DI SANTA COSTANZA
su via Nomentana
presso sant'Agnese fuori le mura.
Fatto costruire nel 350 da Costantina, figlio dell'imperatore Costantino presso la sepoltura di sant'Agnese. Vi furono sepolte Costantina e la sorella Elena. Erroneamente Costantina fu scambiata per una santa e quindi prese questo nuovo nome. Nel Rinascimento, a causa delle sue caratteristiche l'edificio fu lungamente studiato, anche se per le scene di vendemmia fu scambiato per un tempio di Bacco.
Dal punto di vista stilistico l'edificio è esempio dell'architettura tardo classica e dell'architettura paleocristiana. Ha una pianta centrale con un vano circolare coperto da una cupola e illuminato da dodici finestre concluse ad arco situate nel tamburo. La cupola possia su 12 coppie di colonne binate in senso radiale disposte ad anello. Oltre si trova un deambulatorio (corridoio circolare) coperto da volte. Tale struttura crea spazi fortemente caratterizzati dal contrasto tra luce e penombra. La pianta circolare di questo edificio fa pensare al tempio della Minerva Medica oggi in via Giolitti (ninfeo degli Orti Liciniani), anche se qui c'è il deambulatorio. All'esterno correva un altro ambulacro oggi scomparso, si può fare riferimento alla chiesa di Santo Stefano Rotondo al Celio. All'interno si trovava il sarcofago in porfido di Costantina oggi ai Musei Vaticani.
Quando il mausoleo fu trasformato in battistero venne costruito un nartece che precede ancor oggi la chiesa vera e propria.
La cupola dell'edificio era ricoperta di mosaici distrutti nel 1620. Le pareti del tamburo erano in opus sectile, con tarsie di marmi preziosi. Rimangono ancora i mosaici originari del IV secolo nella volta del deambulatorio. Si tratta di una delle più alte testimonianze di cultura artistica del periodo paleocristiano. Vi sono rappreseentati motivi geometrici e naturalistici: pavoni, colombe, rami con frutti; scene di vendemmia, protomi (cioè ritratti del volto) femminili a mosaico tra cui è riconoscibile Costantina. Certamente è uno dei primi casi di adattamento di temi pagani ai nuovi temi cristiani.
MAUSOLEO DETTO "IL TORRIONE" o "IL TORRACCIO"
tra via Prenestina e via Ettore Fieramosca.
Ci troviamo al Pigneto, l'area è fortemente segnata dalla Tangenziale Est. E' consigliabile entrare da via Ettore Fieramosca e fare poi il giro del giardino recentemente riqualificato. Al tempo dell'antica Roma qui eravamo al II miglio[7] della via Prenestina. Si tratta di una tomba a tumulo dell'ultimo quarto del I secolo a.C. Come tutti i mausolei aveva un ampio tamburo circolare in calcestruzzo ricoperto di marmo dal diametro di 62 metri, quindi il più grande di Roma dopo il mausoleo di Augusto e il mausoleo di Adriano. Ovviamente c'era una camera sepolcrale all'interno, in questo caso stranamente l'ingresso era dal lato della strada. Il cono di terra che sovrastava il monumento culminava con una colonna, al di sopra si trovava la statua del defunto in abiti ufficiali. Non sappiamo chi sia il committente. Un cartello posto da Legambiente sul lato di via Prenestina afferma che la critica moderna attribuisce l'opera ad un certo Marcus Aurelius Syntonus o Titus Quintus Atta. Nel tardo medioevo quest'area fu proprietà dei Ruffini, che lo adibirono a cantina, costruendovi a fianco un casolare con uno spazio recintato come è alla Torre del Quadraro in piazza dei Consoli, inoltre vi era una torre merlata a più piani. Di questi fabbricati nulla è rimasto come di una fontana medioevale. Dal 1911 appartiene allo Stato italiano.
Due immagini del Torraccio
con vista interna ed esterna,
foto di Piero Tucci del nov. 2012.
Il giardino che circonda il Torrione ha riaperto al pubblico dopo due anni di restauri il 28 dicembre del 2010, l'area verde è stata ampliata da 5 a 8.000 mq, comprende un'area per cani, due fontanelle e un'area giochi per bambini. Costo dell'operazione 1.250.000 €.
TOMBA DI CECILIA METELLA
su Appia Antica prima del III miglio
dopo la villa di Massenzio
Cecilia Metella era la figlia di Quinto Cecilio Metello Cretico e moglie di Crasso, il figlio di quel Crasso che aveva costituito il primo triunvirato con Cesare e Pompeo (aveva anche soffocato la rivolta di Spartaco nel 60 a.C.). Si tratta quindi di un mausoleo del I secolo a.C. e le scene di guerra che accompagnano l'epigrafe sono evidente intento di celebrare l'importanza della famiglia.
Il monumento era formato dall'edificio circolare che ancora è visibile, alla sua base si trovava un'opera cementizia quadrangolare. Il tamburo ha il diametro di 30 metri ed è alto 39. Era interamente rivestito di blocchi di travertino, probabilmente terminava con una piccola cupola, ancora nel Mille veniva denominato monumento appuntito. Al di sopra della tabula con l'intitolazione correva un fregio di festoni floreali alternati a bucrani, per cui nel medioevo la zona fu chiamata Campo di Bove.
Alla fine del XIII secolo i Caetani, la potente famiglia che diede alla Chiesa il papa Bonifacio VIII, creò intorno alla Tomba di Cecilia Metella un vero e proprio castello a cavallo della via Appia, di tale castello la tomba costituiva il maschio. Nel recinto esisteva un borgo abitato e la chiesa intitolata a Nicola di Bari di cui oggi restano in piedi solo i muri perimetrali. Il castello passò poi ai Savelli, agli Orsini, ai Colonna, ai Cenci e infine, con le tenute circostanti (anche la Caffarella) ai Torlonia.
MAUSOLEO DI CASAL ROTONDO
su Appia Antica al VI miglio
angolo via di Casal Rotondo/via di Torricola.
Il mausoleo è così chiamato perchè nel medioevo al di sopra vi fu costruito un casale oggi trasformato in villa privata. Vicino al mausoleo l'archeologo Luigi Canina fece edificare nell'ottocento una quinta architettonica ornata con i frammenti di marmo riportati alla luce nell'area circostante (forse un'edicola circolare situata sulla cima del mausoleo).
Il mausoleo risale al 30 a.C., è costituito da un grande cilindro del diametro di 35 metri chiuso da un anello di base decorato da un fregio di grifi e un tetto conico a squame. Nella parte inferiore si trovavano una sorta di sedili per la sosta. Nell'iscrizione compare solo il cognome Cotta in cui è stata riconosciuto Messalla Corvino console nel 31 a.C., ma si tratta solo di un ipotesi.
MAUSOLEO DI ELENA
in via Casilina (Tor Pignattara)
Ci troviamo al III miglio[8] dell'antica via Labicana[9]. Venne costruito dall'imperatore Costantino tra il 326 e il 330 per se stesso ma venne poi utilizzato come sepolcro per Elena, madre dell'imperatore, morta nel 328.
Il mausoleo si trovava all'interno di una vasta proprietà imperiale denominata "Ad duos Lauros" che si estendeva dall'attuale basilica di santa Croce fino al III miglio della via Labicana, il suo territorio coincide con l'attuale VI Municipio. Fanno parte di quest'area le catacombe dei Santi Marcellino e Pietro, la basilica omonima di cui restano pochi ruderi e sui quali fu costruita la chiesa attuale. Nella zona era anche il cimitero degli Equites singulares ma non è stato possibile individuare l'esatta ubicazione.
Come tutti i monumenti romani, nel medioevo, venne smantellato per essere riutilizzato per materiale da costruzione. Nell'VIII secolo divenne fortezza difensiva, nonostante ciò continuò ad ospitare la tomba di Elena fino al Mille quando il sarcofago fu portato in Laterano (invece il corpo all'Ara Coeli), oggi è conservato nei Musei Vaticani (il fatto che sul sarcofago vi siano scene militari ha fatto pensare che fosse stato costruito per Costantino e poi utilizzato per la madre di lui). All'interno del mausoleo si trova una chiesetta intitolata ai santi Marcellino e Pietro dei tempi di Urbano VIII (1632), dai primi del Novecento e fino alla costruzione della vicina chiesa, questa era la parrocchia di Torpignattara.
Si tratta di un edificio a pianta circolare formato da due cilindri sovrapposti e terminante a cupola. Il cilindro inferiore (che internamente è ottagonale) ha un diametro esterno di m 27,74 ed interno di m 20,18. L'altezza era di m 25,42, mentre oggi è di circa 18. Ai vertici troviamo delle nicchie che nell'anello superiore diventano otto finestre ad arco. Per alleggerire il peso della cupola sono state inserite delle anfore ancora oggi ben visibili, per il popolo erano delle "pignatte" per cui Tor Pignattara, il nome attuale.
Tra il 1993 e il 2000 il mausoleo ha subito un'importante opera di restauro e di completamento delle opere di scava iniziate precedentemente. Durante gli scavi è stato scoperto un pozzo al centro del mausoleo dal quale sono stati recuperati vasi dei secoli XI e XII. Il restauro ha permesso la realizzazione di due ballatoi che permettono la vista dall'alto di apprezzarne la dimensione e l'insieme. Sono stati restaurati i pochi frammenti rimasti del pavimento originario.
Oggi il mausoleo risulta nel cortile - oratorio - campo di calcio della parrocchia dei Santi Marcellino e Pietro, per giungervi bisogna oltrepassare un portale settecentesco. La chiesa fu costruita nel 1922 su progetto dell'architetto Guglielmo Palombi.
Una bella visione del mausoleo si ha dal parco di Villa De Sanctis detto anche parco Casilino Labicano. Il parco ha una superficie di circa 12 ettari, fu aperto al pubblico dal sindaco Rutelli il 5 novembre 1994 (solo una zona di tre ettari all'angolo tra via Casilina e via dei Gordiani). L'area era precedentemente occupata da depositi di auto in demolizione, depositi di materiali edili, un circolo sportivo e un ristorante "La carovana". Nel 1942 Filippo De Sanctis, proprietario del fondo, lascia in testamento il terreno all'Ente Comunale di Assistenza di Roma. Solo nel 1950 la villa viene finalmente consegnata al Comune ma la proprietà era stata affittate e subaffittata. Nel 1981, con il sindaco Petroselli, viene costituito il parco pubblico, dopo lunghe battaglie legali si arriva finalmente allo sgombero, alla bonifica eall'inaugurazione del 1994.
Nel 2003 è stato inaugurato il Parco delle Sculture con la collocazione di 5 opere d'arte contemporanea realizzate utilizzando cinque materiali diversi:
- "Freeze" di Anna Ajò, in vetroresina;
- "Porta Magica" di Immacolata Datti, in terracotta;
- "Porta" di Giuliano Giuliani, in travertino;
- "Romana" di Carlo Lorenzetti, in acciaio;
- "Luna" o "Luna verde" di Costas Varotsos[10], in vetro.
CAPPELLA DI SAN ZENONE
nella chiesa di Santa Prassede,
come mausoleo di Teodora voluta dal figlio papa Pasquale I.
La chiesa si trova in via di San Martino ai Monti nel rione Monti, molto vicina alla Basilica di Santa Maria Maggiore. A metà della navata destra si trova la Cappella di San Zenone eretta da Pasquale I[11] come mausoleo per la madre Teodoro. Le due colonne di granito nero e la ricca cornice curva sostengono un'urna cineraria con i resti di Zenone, sacerdote e martire. L'interno è a volta con colonne negli angoli, è magnifica in quanto ricoperta da mosaici che sono stati definiti "Il giardino del Paradiso". Vi sono rappresentati: il Cristo, la Madonna, Santa Prassede e Teodora con il nimbo quadrato dei viventi. Sopra l'altare la Madonna con Bambino. Il pavimento è in opus sectile. A destra è custodita la colonna portata a Roma da Gerusalemme nel 1223 che secondo la tradizione è quella a cui fu legato e flagellato Gesù.
BIBLIOGRAFIA
- AA.VV. Guida d’Italia, Roma, ed. Tci, 1993.
- AA.VV. Roma, libri per viaggiare, ed. Gallimard – Tci, 1994.
- AA.VV. I rioni e i quartieri di Roma, ed. Newton & Compton, 1989.
- AA.VV. Le strade di Roma, ed. Newton & Compton, 1990.
- Claudio Rendina (a cura di), Enciclopedia di Roma, ed. Newton & Compton, 2005.
- Giorgio Carpaneto, I palazzi di Roma, ed. Newton & Compton, 1991.
- Mariano Armellini, Le chiese di Roma, ed. Pasquino, 1982.
- Carlo Zaccagnini, Le ville di Roma, ed. Newton Compton, 1991.
- Giuliano Malizia, Gli archi di Roma, ed. Newton Compton, 1994.
- Giuliano Malizia, Le statue di Roma. Storia, aneddotti, curiosità, ed. Newton Compton, 1996.
- Mauro Quercioli, Le mura e le porte di Roma, ed. Newton Compton, 1993.
- Sergio Delli, I ponti di Roma, ed. Newton Compton, 1992.
- Carlo Villa, Le strade consolari di Roma, ed. Newton Compton, 1995.
- AA.VV. Enciclopedia Universale, ed. Garzanti, 2003.
- AA.VV. Enciclopedia dell’Arte, ed. Garzanti, 2002.
- Roma ieri, oggi e domani, ed. Newton Compton.
- Forma Urbis, ed. Service Sistem.
- AA.VV. Stradaroma, ed. Lozzi, 2005.
- AA.VV. Tutto Città, 2011/2012, ed. Seat.
SITOGRAFIA
www.comune.roma.it
www.archeoroma.beniculturali.it
www.museiincomune.roma.it
www.romasegreta.it
www.romasparita.net
www.info.roma.it
www.abcroma.com
www.palazzidiroma.it
www.villediroma.com
www.romaspqr.it
www.vicariatusurbis.org
www.repubblica.it
www.ilmessaggero.it
www.corriere.it
www.viamichelin.it
www.tuttocittà.it
Piero Tucci
29.06.12
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
http://inbiciperoma.org
AGGIORNAMENTI
23.9.13 Mausoleo di Augusto. Due milioni di euro dal “decreto valore cultura” del governo per restaurare il mausoleo nel bimillenario della morte di Augusto. Una somma insuffficiente per il restauro ne occorrono 12. Un terzo dei soldi dovrebbe metterli lo stato, un altro terzo il Comune, il terzo mancante dovrebbe venire da privati ancora da trovare. Il bando del 2012 è andato deserto. Il monumento è chiuso al pubblico da 77 anni.
25.10.13Mausoleo di Augusto. L’ass. Caudo dichiara come rinascerà l’area che sarà pedonalizzata e avrà una scalinata tra Mausoleo e Ara Pacis, avrà una cavea. Da via del Corso a via Ripetta sarà tutta ripavimentata entro l’anno.
Ven. 17.1.14 Piazza Augusto Imperatore. Verso il bimillenario della morte dell’imperatore Augusto. Sbloccati 17 milioni di euro per riqualificare la piazza. Una grande piazza al livello del monumento, una scalinata che degrada dall’abside di San Carlo al Corso e una che risale verso l’Ara Pacis tra le due chiese San Girolamo degli Illiri e San Rocco. La commissione roma Capitale ieri ha dato l’ok definitivo al progetto. Il progetto è dell’arch. Cellini, ma ad esso hanno partecipato l’assessore Caudo, Mario Manieri Elia e Renato Nicolini. Non è previsto il restauro del monumento che spetta alla Sovrintendenza. Entro l’estate la gara d’appalto.
6.3.14Piazza Augusto Imperatore. 12 milioni per il gioiello del Tridente. La giunta sblocca i fondi. Caudo: “Sarà l’ingresso spettacolare del nuovo centro pedonalizzato. Fondi anche per Monti (ripavimentazione delle strade con 3 milioni) e via Boncompagni (trasformazione di un isolato da 22.000 mq). Il complesso immobiliare si trova tra via Boncompagni, via Puglia, via Sicilia e via Romagna. Sono tre fabbricati disposti a corte, la facciata ipermoderna su progetto dello Studio Mad di Pechino con un gioco di onde e vetrate. E’ proprietà di Unicredito Immobiliare Uno, controllata da un fondo lussemburghese e da una società del gruppo Unicredit.
20.8.14 Mausoleo di Augusto. Nel giorno del bimillenario della morte di Augusto il fossato si allaga per un guasto nelle tubature e viene a mancare la corrente. Il Comune annuncia che la gara per il restauro e per la nuova piazza partirà entro il 2014.
17.4.15 Piazza Augusto Imperatore.Finalmente il 22 giugno saranno assegnati i lavori che inizieranno a metà ottobre. Il progetto di Cellini prevede due scalinate che scendono a livello del Mausoleo.
[1] Le sette bellezze del mondo antico sono: la piramide di Cheope, i Giardini Pensili di Babilonia, il Faro di Alessandria, la tomba di Mausolo ad Alicarnasso, il Colosso di Rodi, il tempio di Artemide ad Efeso e la statua di Zeus a Olimpia.
[2] Vittorio Ballio Morpurgo (Roma1890 - 1966) casa d'abitazione in via Sannio via Ardea, ministero degli Affari Esteri (in coll.). Nel dopoguerra: torre dei Molini Pantanella in via Casilina, quartiere Ina Casa Torre Spaccata (in coll.), palazzo della Esso all'Eur in p.le dell'Industria (con Luigi Moretti). E' stato docente universitario e preside della facoltà di Architettura.
[3] Riqualificazione piazza Augusto Imperatore le notizie da Repubblica, da casaeclima.com e da romacapitalenews.com
[4] Mausoleo di Adriano sulla data di inizio dei lavori i testi sono discordanti. La guida di Roma del Tci del 1993 fornisce la data del 123, wikipedia quella del 125, l'enciclopedia di Roma di Claudio Rendina non fornisce la data di inizio dei lavori solo quella di fine, come "I rioni e i quartieri di Roma" della Newton Compton.
[5] Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo opere di Luca Signorelli, Lorenzo Lotto, Dossi Dossi, Carlo Crivelli e del Cavalier d'Arpino.
[6] Carlo Marchionni è famoso per aver progettato e realizzato la sacrestia della basilica di San Pietro.
[7] un miglio romano equivale a m 1.480.
[8] Un miglio romano equivale a m 1.480.
[9] Via Labicana Una delle più antiche strade romane, probabile sentiero del periodo preistorico. Si tratta di un percorso alternativo alla via Latina perchè le due strade si congiungevano a Labicum. Usciva dalla porta Esquilina delle mura Serviane (arco di Gallieno), poi da porta Maggiore delle mura Aureliane, seguiva il percorso dell'attuale via del Pigneto fino a piazza della Marranella dove proseguiva sul percorso dell'attuale Casilina. Passava per Tusculum, quindi arrivava a Labicum sulle pendici settentrionali dei Colli Albani congiungendosi con la via Latina. La via arrivava così a Casilinum oggi Capua, nel medioevo il suo nome divenne Casilina.
[10] Costas Varotsos (Atene, 1955) scultore greco, si è trasferito a Roma per studiare e poi diplomarsi all'Accademia di Belle Arti di Roma, poi si laurea in architettura a Pescara. Dal 1999 è docente all'Università Aristotele di Salonicco la più grande università grea. I materiali ulitizzati sono il vetro, l'acciaio e la pietra.
[11]Papa Pasquale I (papa dal 817-824, romano, santo) Fu lui a ritrovare il corpo di Santa Cecilia nelle catacombe di San Callisto e portarlo nella omonima chiesa di Trastevere. Fece costruire S. Cecilia, S. Prassede e S. Maria in Domnica.