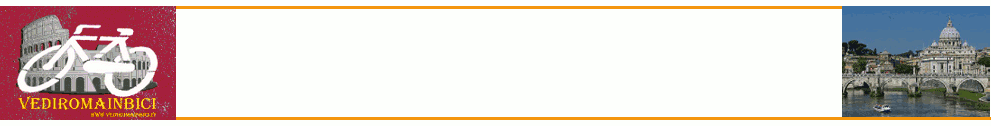Foto e Schede 2015
COLLOCAZIONE GEOGRAFICA
Il quartiere si trova nel quadrante Sud di Roma e fa parte del IX Municipio del Comune di Roma. E' delimitato dal Gra, da via Cristoforo Colombo, da via di Mezzocammino e dalla via Ostiense (o ferrovia per Ostia), occupa una superficie di 190 ha[1] di cui 40 saranno di parco pubblico. Sono previsti 15.000 ab, chiesa, sette scuole, una pista ciclabile, una fermata del treno per Ostia, un centro commerciale, un centro sportivo, un campo da golf, un mercato. Tutte le strade sono intitolate a creatori di fumetti da un'idea di Maurizio Nicastro, presidente del Consorzio, che è collezionista di Tex (in effetti via Bonelli è la più lunga).[2] Il progettista del quartiere è il professor architetto Sergio Petruccioli[3] con Alberto Alieri, Alessandro Del Vescovo e Luisa Morpurgo. Attualmente presenta un ingresso dal quartiere Torrino attraverso via Pechino che si prolunga con il nome di viale Luigi Guglielmi. Altri tre ingressi sono dalla via Cristoforo Colombo: via Ercole Drei, con sottopasso, viale Bartolomeo Cavaceppi (il principale) e via Gianluigi Bonelli. Un ingresso è dalla via Ostiense, presso piazza Mario Uggeri e via Gianluigi Bonelli.
Il quartiere dovrebbe avere al suo interno uno schema stradale formato da un quadrilatero: via Bonelli, via Pratt, via Cavaceppi e via Galleppini. Dalla carta del quartiere pubblicata sul sito internet del consorzio, all'interno di questo quadrilatero di strade si trova il parco dei Fumetti.
Il quartiere è collegato alla metro B Magliana dalla linea 787 (percorre via dell’Oceano Indiano e via della Grande Muraglia) che fa capolinea in via Gianluigi Bonelli (largo Bertasi).
TOPONOMASTICA
Le strade sono intitolate ad artisti (verso la Colombo e il Gra) o a disegnatori di fumetti (parte centrale del quartiere).
STORIA
ORIGINE DEL NOME
La zona si è sempre chiamata così perchè si trova, sulla via Ostiense, a metà strada tra Roma e Ostia, nel punto in cui sostavano le navi che risalivano il Tevere. Per questa operazione occorrevano due giorni, le barche erano trainate da muli sulle due sponde, in questo punto avveniva la sosta notturna. Questo nome è anche riferito al ponte sul Tevere su cui passa il Gra e dove termina la pista ciclabile Dorsale Tevere Sud. Il ponte è detto anche di Spinaceto, fu realizzato nel 1938 dalla ditta Tudini & Talenti, misura m 385 e si sviluppa su 15 campate. La campata centrale, in origine, era apribile. Nel 2000 è stato affiancato da un nuovo ponte.
STORIA RECENTE DEL QUARTIERE
Il 2 ottobre 1997 il Consiglio Comunale del Comune di Roma approva il progetto di lottizzazione delle aree della zona denominata Torrino - Mezzocammino, le opere di urbanizzazione sono a cura e spese dei proprietari. Nel gennaio 2001 il Consiglio Comunale autorizza i lavori di urbanizzazione. Nel settembre 2002 si ha la stipula della Convenzione urbanistica con il Comune. Il 19 novembre 2004 il IX Dipartimento del Comune di Roma autorizza la costruzione di 610.000 mc residenziali e 90.000 non residenziali. Il 20 aprile 2006 con delibera della Giunta Comunale si approva la rete stradale e parcheggi.
Il 16 novembre 2007 apre il sottopasso della Colombo che collega il quartiere con Casal Brunori Spinaceto, è intitolato all'architetto Manlio Cavalli ideatore del nuovo quartiere da 13.000 ab. L'11 aprile 2008 si insediano i primi dieci inquilini del quartiere. Il 31 luglio 2009 si inaugura il parco dei Fumetti, il 20 novembre dello stesso si inaugura piazza Andrea Pazienza[4] con arredo di personaggi di fumetti[5]. Il 16 ottobre 2010 si è inaugurato un primo tratto di Km 4,5 (largo Piraino - piazza Uggeri) della pista ciclabile che farà il giro completo del quartiere e avrà un tratto che lo attraverserà da Est a Ovest[6]. Il 18 ottobre 2010 ha aperto la scuola Elementare Geronimo Stilton di via Roberto Raviola (non lontano da piazza Andrea Pazienza)[7]. Nel 2013 ha aperto il Centro Commerciale nei pressi di piazza Andrea Pazienza.
ITINERARIO
Entriamo nel quartiere dal Torrino, da piazza del Monte Tai prendiamo via Pechino, larga, in curva verso destra, in breve scende per sottopassare il Gra, la strada risale e siamo nel quartiere in costruzione di Mezzocammino.
La strada si chiama viale Luigi Guglielmi[8], è larga, ha quattro corsie separate, con larghi marciapiedi. Ci accoglie sulla sinistra un parco recintato e ben tenuto con una nuovissima pista ciclabile. Le case sono su 3/4 piani tra molte aree non edificate. Prima del rondò vediamo sulla sinistra un edificio bianco, si tratta della scuola dell'Infanzia "La Pimpa" (inaugurata a novembre 2010), sulla destra invece in un prefabbricato la
CHIESA DEL SANTO GIOVANNI XXIII[9], parrocchia del quartiere con ingresso da via Giuseppe Lucchetti Rossi. La parrocchia è stata istituita l'8 settembre 2006, il suo territorio coincide perfettamente con quello del quartiere ed è stato desunto dalla parrocchia di Vitinia: Sacro Cuore Agonizzante di Gesù. L'unico sarcedote a disposizione della parrocchia è il parroco.
Il rondò è verde, ben tenuto, e presenta la scritta "Mezzocammino" rivolta verso di noi. Qui è stato collocato il monumento in ceramica a Tex. La strada che lo taglia si chiama viale Bartolomeo Cavaceppi[10]. Verso destra si arriva a piazza Andrea Pazienza / Guido Crepax[11]. Qui si trovano 27 pannelli mosaicati per una quindicina di personaggi dei fumetti.
Proseguiamo per via Aurelio Galleppini, dopo poco vediamo alle nostre spalle il Centro Commerciale di recente realizzazione con supermercato Conad Superstore, Upim e un grande casalinghi. Qui anche un grande bar Tornatora (20 settembre 2014), più avanti una grande pizzeria. Prima di raggiungere il rondò denominato Largo Jacovitti si trova il ponte Sergio Petruccioli. Da qui si gode un vasto panorama verso il Gra, la Magliana Vecchia con i palazzi a Ventaglio di Lafuente. Proseguendo per via Bonelli, ma verso destra, la strada prende a scendere, in breve si arriva a piazza Marco Uggeri, dove dovrebbe sorgere la stazione della ferrovia Roma – Ostia. Da qui si entra in uno dei parchi denominati “Parco dei Fumetti”, è la porta del signor Bonaventura. Da questo punto si può fare il giro del quartiere su pista ciclabile. Nell’ordine si trovano le porte: Lupo Alberto, Corto Maltese, Valentina e Dylan Dog, siamo tornati in via Luigi Guglielmi, la strada di ingresso al quartiere. Da questo punto prendiamo a sinistra fino a viale Cavaceppi, rondò, quindi a sinistra.
Dopo una leggera e breve salita si arriva ad uno slargo sulla destra chiamato largo Amalia Camboni[12] con un edificio bianco ad uso ufficio dalla linea architettonica molto innovativa, nei locali a piano terra una banca e l'unico bar del quartiere. Ancora sulla piazza, ma in fondo, un asilo nido, sul lato opposto l'ingresso ad un'altra area verde con pista ciclabile, denominata parco dei Fumetti, al suo interno un tratto di strada romana. Subito dopo un altro slargo è chiamato piazza Enrico Martini[13], forma un tutt'uno con la piazza precedente. Si procede ancora per poco e si giunge ad un altro rondò.
Questo rondò è senza nome, di fronte a noi si vede la Colombo, prendiamo a destra viale Hugo Pratt[14]. Questa strada presenta due traverse, entrambe sulla destra: via Fausto Melotti e via Emilio Greco[15]. Torniamo al rondò e proseguiamo dritti di fronte a noi per via Vico Consorti, strada lunga, la maggior parte delle case è terminata, anche qui un parco con pista ciclabile. A metà circa inizia sulla destra via Ercole Drei con sottopasso della Colombo[16]. Torniamo indietro fino al rondò, non ci resta che raggiungere la Colombo (viale Bartolomeo Cavaceppi presenta due piazze nel punto in cui confluisce sulla Colombo, si tratta di piazza Clemente Origo[17]). Da questo punto iniziamo a percorrere il perimetro del quartiere.
La corsia laterale della Colombo è in discesa, vediamo all'interno una pista ciclabile, la stessa che abbiamo trovato in via Cavaceppi prima di arrivare sulla Colombo. Superiamo un centro sportivo. Eccoci così a via Gianluigi Bonelli[18], una delle arterie del quartiere. Proseguiamo sulla Colombo finchè non giungiamo alla via di Mezzocammino.
Via di Mezzocammino è stretta, a due corsie, è rimasta come era tanti anni fa. Sulla sinistra c'è una area verde che separa il quartiere di Mezzocammino dal quartiere di Vitinia, sulla destra - in alto - vediamo i palazzi del quartiere già conclusi.
Finalmente siamo sulla via Ostiense, dopo pochissimo siamo in piazza Mario Uggeri[19], via Gianluigi Bonelli ci permette di rientrare nel quartiere. Terminiamo il perimetro del quartiere percorrendo la via Ostiense, stretta e pericolosa, sottopassiamo il Gra, finchè non troviamo alla nostra destra via del Fosso di Torrino.
VALORE DELLE CASE IN VENDITA
Da una ricerca fatta sul sito internet di Tecnocasa nel giugno 2015: una mansarda di 40 mq vale 100.000 €, un monolocale di 45 mq vale 179.000 euro, un bilocale di 60 mq vale 239.000 euro, un trilocale di 70 mq vale 290.000 euro.
AGGIORNAMENTI
25.5.15 Torrino – Mezzocammino. Un quartiere nuovo, vivibile, con aree verdi, tra cinque anni dovrebbe essere finito, crisi permettendo. Carenze: pulizia stradale, assenza di vigili urbani (le macchine sfrecciano), c’è solo il bus atac 787 passa ogni 30/35 minuti, nei prefestivi e festivi anche ogni 50, alle 22 l’ultima corsa. Progetto fermata Roma-Lido, non se ne sa niente. No car sharing perché oltre il Gra.
BIBLIOGRAFIA
AA.VV. Stradaroma, ed. Lozzi, 2005.
SITOGRAFIA
www.comune.roma.it
www.portalidiroma.it/mezzocammino/index
www.it.wikipedia.org
www.mezzocammino.it
www.torrinomezzocammino.net
www.vicariatusurbis.org
www.romasette.it
www.maps.google.it
www.viamichelin.it
Piero Tucci
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
04.06.15
[1] Superficie del quartiere. Si può paragonare alla Caffarella (200 ettari), al parco degli Acquedotti (240), a villa Doria Pamphili 184, Villa Ada 160, mentre villa Borghese è molto più piccola 79.
[2] Dati quartiere Mezzocammino, tutti i dati riportati in corsivo provengo da "la Repubblica", cronaca di Roma, dell'11 aprile 2008.
[3] Sergio Petruccioli architetto, fratello del Presidente deputato Pci e poi del consiglio di amministrazione della Rai (2005-09) Claudio Petruccioli. Sergio, docente alla Sapienza (m. 2004) è il fondatore dello Studio Petruccioli e associati con sede in via della Giustiniana. Ha progettato il restauro del Teatro Ambra Jovinelli, il CC Romanina, il CC Lunghezza, il Centro Polifunzionale all'Ostiense, il Comune della Repubblica di San Marino e ha redatto il piano particolareggiato di Fiano Romano. Tutte le notizie da peaarch.com.
[4] Andrea Pazienza (San Benedetto del Tronto 1956 – Montepulciano 1988) fumettista e pittore, ha collaborato con Il Male, Tango supplemento satirico de l’Unità, Linus, ha creato il manifesto per La città delle donne” di Fellini, alla sceneggiatura del Piccolo Diavolo di Benigni.
[5] Storia recente del quartiere riferite in questo paragrafo da cronaca di Roma de "la Repubblica".
[6] Pista ciclabile. La notizia dal sito internet del consorzio Torrino Mezzocammino.
[7] Scuola Elementare Geronimo Stilton. La notizia dal sito del consorzio torrino Mezzocammino.
[8] Luigi Guglielmi (1834 - 1907) scultore.
[9] Papa Giovanni XXIII (Sotto il Monte BG 1881 - Città del Vaticano 1963) Angelo Giuseppe Roncalli, papa dal 1958 al 1963, l'11 ottobre 1962 aprì il Concilio, evento che non succedeva da 90 anni, definito il "Papa buono", fu beatificato il 3 settembre 2000. E’ stato canonizzato il 27 aprile 2014 da papa Francesco insieme a Giovanni Paolo II.
[10] Bartolomeo Cavaceppi (Roma 1715-1799) scultore e restauratore. Curò la preziosa collezione di opere antiche di Alessandro Albani. Il suo atelier di restauro fu frequentato da famosi collezionisti, tra cui Federico II di Prussia e Caterina II di Russia. Fu amico di Winckelmann. Suoi restauri sono ai Capitolini.
[11] Guido Crepax (Milano 1933-2003) disegnatore di fumetti, noto per aver creato il personaggio di Valentina.
[12] Amalia Camboni (1913-1985) scultrice.
[13] Enrico Martini.
[14] Hugo Pratt (Rimini 1927 - Losanna 1995) il creatore del personaggio Corto Maltese, marinaio avventuriero.
[15] Emilio Greco (1913- 1995) scultore, ottiene grandissima fama con il monumento a Pinocchio e la fatina del 1956 per il parco di Collodi. Suo il ciclo delle Grandi bagnanti, il monumento a Papa Giovanni in San Pietro e le porte del Duomo di Orvieto del 1970, musei a lui intitolati sono a Catania, Orvieto e Sabaudia.
[16] Via Vico Consorti. Secondo la mappa del quartiere, pubblicata sul sito internet del Consorzio, alla fine di questa strada vi dovrebbe essere una stazione della metropolitana. Vico Consorti (Semproniano, Roccalbegna 1909 - 1979) scultore autore della Porta Santa in San Pietro (1950), della porta della Riconoscenza nel duomo di Siena, della porta del santuario di Oropa. Per questa sua attività i compaesani lo chiamarono Vico dell'Uscio. E' autore delle quattro sculture di un pilone del Ponte Duca d'Aosta a Roma.
[17] Clemente Origo (1855-1921) scultore.
[18] Gianluigi Bonomelli (1908 - 2001) fumettista e scrittore, creatore di numerosi personaggi tra cui Tex Willer.
[19] Mario Uggeri (Codogno, Lodi 1924 - Merate, Lecco 2004) autore di fumetti, pittore, collaboratore del Corriere dei Piccoli. QUI DOVREBBE SORGERE LA STAZIONE DELLA ROMA - OSTIA A SERVIZIO DEL QUARTIERE.
INTRODUZIONE
La Società Sportiva Lazio, nota più semplicemente come “la Lazio” è una società polisportiva nota soprattutto per la sua sezione calcistica. Fu fondata a Roma il 9 gennaio 1900 come “Società podistica Lazio” da nove atleti guidati dal sottufficiale dei bersaglieri Luigi Bigiarelli. I colori sociali sono il bianco e il celeste, la divisa per le partite in casa è: maglietta celeste e pantaloncini bianchi con calzini bianchi e riga in alto celeste; in trasferta: tutta rossa con una striscia biancoceleste. Gioca nel campionato di serie A, oggi il presidente è Claudio Lotito, l’allenatore Stefano Pioli, gioca nello stadio Olimpico di Roma. L’inno ufficiale della Lazio è “Vola Lazio vola” composto e interpretato nel 1983 dal cantautore romano Toni Malco. Uno dei più accesi sostenitori è stato Mario Riva.
Nella sua storia ha disputato 72 campionati di serie A a girone unico su 83 totali, ha vinto due scudetti (nel 1973/74 e nel 1999/2000), 6 Coppe Italia e una Coppa delle Coppe. Attualmente è terza nella classifica di serie A con 66 punti, distanziata di 20 punti dalla capolista Juventus (situazione al 25.05.15).
Vip tifosi della Lazio sono: Tania Zamparo, Enzo Garinei, Ray Lovelock, Asia Argento, Nicola Arigliano, Enrico Brignano, Bruno Corbucci, Gianfranco D’Angelo, Eleonora Daniele, Cristian De Sica, Anna Falchi, Fraiese Paolo, Pino Insegno, Franco Interlenghi, Ubaldo Lai, Nanni Loy, Franco Marini, Federico Moccia, Enrico Montesano, Paolo Panelli, Marco Pannella, Nicola Pietrangeli, Francesco Rutelli, Delia Scala, suor Paola, Aroldo Tieri, Paola Turci, Trilussa.
STORIA DELLA LAZIO
La Società Podistica Lazio (solo nel 1925 rinominata Società Sportiva Lazio) fu fondata il 9 gennaio 1900, in piazza della Libertà da un gruppo di nove giovani con a capo il sottoufficiale dei Bersaglieri, oltre che atleta podista, Luigi Bigiarelli.
Fin dai primissimi anni si rivelò la più forte squadra di calcio della capitale, nel 1908 si affiliò alla FIF, la Federazione Italiana Footbal, dal 1910 partecipò alle competizioni federali, dal 1912 giocò in prima categoria. Fino allo scoppio della prima guerra mondiale raggiunse la finalissima del torneo nazionale quattro volte, senza però mai vincerlo. La finalissima del 1915 fu annullata a causa dello scoppio della grande guerra.
Nel 1927 la Lazio, resistette alla volontà del regime fascista di avere nella città una sola squadra di calcio, quella che poi sarà la Roma. Nella stagione 1936/37, guidati da Silvio Piola, storico attaccante della Nazionale e maggior autore di gol italiano di tutti i tempi, la Lazio sfiorò lo scudetto, raggiungendo il secondo posto nella classifica finale del campionato di calcio di serie A. Nello stesso anno raggiunse la fina della Coppa dell’Europa, detta poi Mitropa, sconfitta da una squadra ungherese.
Nel secondo dopoguerra la Lazio attraversa un periodo di difficoltà anche per il trasferimento del cannoniere Silvio Piola tra le fila del grande Torino. Tra risultati altalenanti, alla fine degli anni Cinquanta arriva il primo trofeo ufficiale: la Coppa Italia del 1958. Successivamente i biancazzurri retrocessero per la prima volta il serie B nel 1961 per ritornare in A due anni dopo. Dopo alcuni anni di piazzamenti a metà classifica, la Lazio retrocede in B nel 1971 e tornò in A l’anno dopo. Sorprendentemente si dimostrò all’altezza delle migliori squadre, ovvero il Milan e la Juventus sfiorando la vittoria nell’ultima giornata sul campo del Napoli. Il merito principale di questa grande ripresa della Lazio va al difensore, nonché capitano Pino Wilson, ai centrocampisti Luciano Re Cecconi e Mario Frustalupi, al cannoniere Giorgio Chinaglia e all’indimenticabile Tommaso Maestrelli. Era maturo il momento della conquista del primo scudetto che avvenne nel 1973/74.
Purtroppo la squadra dovette affrontare alcuni momenti negativi, le tragiche scomparse di Re Cecconi e di Maestrelli, il trasferimento negli Usa di Chinaglia. In quegli anni entusiasmarono i sostenitori della squadra biancoceleste i gol di Bruno Giordano, nel 1979 divenne capocannoniere della serie A.
Nel 1980, per sentenza del giudice sportivo, la Lazio fu retrocessa in serie B a causa di uno scandalo per scommesse illecite che prese il nome di Totonero. Rimase in B per tre stagioni, il periodo più buio della storia del club. Tornata in serie A nel 1983, non ebbe tempo di gioire della promozione che nella stagione 1984/85 ebbe una nuova retrocessione, nel 1986 fu colpita da una nuova penalizzazione di nove punti per un nuovo scandalo di illecite scommesse detto Totonero-bis, venne coinvolto il capitano Claudio Vinazzani. La squadra dovette affrontare una dura lotta per non retrocedere in C, ci vollero gli spareggi finali contro Taranto e Campobasso per salvare la squadra da una ulteriore retrocessione. La Lazio tornò in serie A nel 1988.
La presidenza di Sergio Cragnotti, nel 1992, cambiò radicalmente la storia della squadra grazie ai suoi importanti investimenti che portarono la Lazio a primeggiare in Italia e in Europa. Cragnotti acquistò calciatori del calibro di Juan Sebastian Veron e Christian Vieri, con essi superò di molto le cifre degli altri acquisti di calciatori; successivamente acquistò il centravanti argentino Hernan Crespo.
Ecco arrivare una serie di piazzamenti che la Lazio non aveva mai conosciuto nella sua storia, seconda nel 1995, terza nel 1996, quarta nel 1997, ancora seconda nel 1999 ad un solo punto dal Milan nell’ultima giornata di campionato, finalmente nel 2000 lo scudetto nello stesso anno della Coppa Italia con lo svedese Sven Goran Eriksson come allenatore. Nel 1999 la Lazio conquistò l’ultima Coppa delle Coppe, il primo titolo di livello europeo per la squadra capitolina. Nel 1998 divenne il primo club italiano ad essere quotato in borsa.
A partire dal 2002, anche a seguito di alcuni problemi finanziari del presidente Cragnotti e della sua società, la Cirio, i risultati della Lazio iniziarono a peggiorare, la squadra perse il capitano e simbolo Alessandro Nesta. Nel 2004 la società si trovò sull’orlo della bancarotta nonostante due aumenti di capitale in gran parte sottoscritti dai tifosi delle Aquile. Nel 2004 l’imprenditore romano Claudio Lotito acquistò il club e salvò la società dal fallimento grazie ad una transazione con l’Agenzia delle Entrate che raiteizzò in 23 anni i debiti accumulati. Ritornò alla Lazio l’attaccante Paolo Di Canio, sotto la guida di Delio Rossi la società arrivò alla qualificazione per la Coppa Uefa nel 2006/07 ma, a causa dello scandalo calciopoli, fu estromessa dalle competizioni europee, penalizzata di 11 punti, ridotti poi a 3. La Lazio riuscì comunque a piazzarsi terza guadagnando l’accesso alla Champions League. Il 26 maggio 2013 la Lazio, guidata dall’allenatore bosniaco Vladimir Petkovic, conquista la sua sesta Coppa Italia battendo, in un derby storico, i rivali cittadini della Roma. Il 12 giugno 2014 la società ufficializza l’ingaggio del parmense Stefano Pioli come nuovo allenatore.
LE SEDI DELLA SSLAZIO
1900 Lungotevere dei Mellini e vicolo degli Osti, 15
1900-1904 via Valadier 6
1904-1906 Via Pompeo Magno 94
1906-1910 Casina di via dell’Uccelliera
1910 Via Sistina 123
1910-1913 Casina dell’Uccelliera
1913-1914 Via delle Coppelle 16
1914-1924 Via Vittorio Veneto 7
1924-25 Via Santo Stefano del Cacco 16
1925-26 Vicolo dei Due Macelli
1926-1929 Via Tacito
1929-1934 Vicolo D’Ascanio 11
1934-1958 Via Frattina 89
1958-1963 Viale Rossini 21
1963-66 Via Nizza 45
1966-87 Via Col di Lana 8
1987-1992 Via Margutta 54
1992-1995 Corso Italia 19
1995-1998 Via Umberto Novaro 32
1998-2001 Via di Santa Cornelia 1000 (Centro Sportivo Formello)
2001-2003 Via Augusto Valenziani 10
2003-2004 Via Borgognona 47
2004- Via di Santa Cornelia 1000 (Centro Sportivo Formello)
ITINERARIO
PIAZZA DELLA LIBERTA’
In questa piazza venne fondata la Società Podistica Lazio (solo nel 1925 rinominata Società Sportiva Lazio) il 9 gennaio 1900, da un gruppo di nove giovani con a capo il sottoufficiale dei Bersaglieri, oltre che atleta podista, Luigi Bigiarelli.
Luigi Bigiarelli aveva preso parte, come sottufficiale dei Bersaglieri alla battaglia di Adua (1896) in cui perirono oltre 5.000 soldati italiani. Con i fratelli si esercitava in allenamenti di resistenza allo sforzo e velocità.
Il Bigiarelli desiderava partecipare al Giro podistico di Castel Giubileo in programma per il 21 aprile 1900, ma ad esso potevano partecipare solo atleti iscritti a società ufficiali, decise di fondare una propria società sportiva con il fratello Giacomo e gli amici Odoacre Aloisi, Arturo Balestrieri, Alceste Grifoni, Giulio Lefevre, Galileo Massa, Alberto Mesones ed Enrico Venier. Adottarono come emblema l’aquila imperiale di alcune legioni romane e come colori il bianco e il celeste che richiamo i colori della Grecia, patria delle Olimpiadi.
Fin dai primissimi anni si rivelò la più forte squadra di calcio della capitale, nel 1908 si affiliò alla FIF, la Federazione Italiana Footbal, dal 1910 partecipò alle competizioni federali, dal 1912 giocò in prima categoria. Fino allo scoppio della prima guerra mondiale raggiunse la finalissima del torneo nazionale quattro volte, senza però mai vincerlo. La finalissima del 1915 fu annullata a causa dello scoppio della grande guerra.
Bigiarelli, dopo la fondazione della Lazio, emigrò in Belgio per lavoro, diventò campione mondiale di podismo sul tempo di mezz’ora (Km 6,742) e anche dell’ora al Bois de Boulogne di Parigi (Km 11,282), morì per una polmonite a 32 anni. Nel 2011 è stata individuata la sua tomba nel cimitero della cittadina belga di Ixelles, uno dei comuni che formano la città di Bruxelles, presso l’area che ospita le istituzioni dell’Unione Europea. In occasione dei festeggiamenti per il centenario della Lazio, tenutisi nello stadio Olimpico, l’attore Enrico Brignano, in una scenetta ha interpretato Luigi Bigiarelli.
Ci troviamo nel rione Prati, al di là di ponte Margherita, all’inizio di via Cola di Rienzo. La piazza è costituita da due aiuole verdi e circondata da villini o palazzi di stile eclettico, la costruzione del sottopasso del lungotevere nel 1960 ha snaturato in parte la bellezza del luogo. Oltre alla lapide che ricorda la fondazione della Lazio, vi si trova il monumento al drammaturgo Pietro Cossa e Casa De Salvi, una palazzina del 1930 opera di Pietro Aschieri (autore della piazza e del palazzo della Civiltà Romana all’Eur con altri, case popolari alla Garbatella, in via Taranto, della Casa di Lavoro dei Ciechi di guerra in via Rovereto). “Rappresenta un classico della palazzina romana che ebbe in Aschieri un magistrale interprete, con quell’andamento ritmico e ondulato delle finestre e dei balconi in un’alternanza di concavo e convesso, tipica espressione di gusto scenografico particolarmente accentuata nella plastica accentuazione delle angolare” (da: Rendina – Paradisi, Le strade di Roma, ed. Newton, 2003, vol. II, pag. 707). In questa piazza c’era l’ufficio elettorale per Francesco Rutelli sindaco nel 1993. Una lapide ricorda la fondazione del Comitato di Liberazione Nazionale il 9 settembre 1943 con a capo Ivano Bonomi. Un’altra lapide ricorda Massimo Gizzio, nel punto in cui venne ucciso dai fascisti mentre conduceva una manifestazione di studenti del vicino liceo Dante. Il 20 maggio, il giardino del lato Nord è stato intitolato a Ettore Troilo comandante della brigata partigiana che agiva sulla Majella, in Abruzzo. Sempre nel lato Nord della piazza, ma più vicino al Tevere si trova il monumento a tutti i Caduti delle Forze dell’Ordine. In angolo con via dei Gracchi e via Orsini si trova uno dei più bei villini liberty di Roma: il villino Cagiati.In esso Garibaldi Burba si diverte a recuperare lo stile medioevale componendo liberamente gli elementi di una costruzione. Eccezionale la qualità delle decorazioni. Splendido il sottotetto con dipinto di girasoli, sopra e sotto le finestre altri dipinti floreali, sono opera di Galimberti. Un gazebo sul giardino di via dei Gracchi. Le ceramiche sul muro di cinta di via Orsini sono di Galileo Chini, particolari portalumi all’ingresso.
Vi ha sede la fondazione Gabriele Sandri, un tifoso della Lazio ucciso l’11 novembre 2007 alla stazione di servizio Badia al Pino, presso Arezzo, da un solo colpo di pistola sparato dall’agente di Polizia Luigi Spaccarotella che si trovava sull’altra carreggiata dell’autostrada. Gabriele è colpito al collo metre si trovava all’interno di un’auto. L’intervento dell’agente era stato sollecitato da una rissa tra tifosi laziali e juventini nel parcheggio dell’area di servizio. Dopo vari gradi di giudizio Spaccarotella viene condannato per omicidio volontario a 9 anni e 4 mesi di reclusione. In tutti gli stadi si osserva un minuto di silenzio, la partita Roma – Cagliari viene rinviata, nonostante ciò un centinaio di ultras laziali e romanisti attaccano la stazione di polizia in via Guido Reni, in commissariato in via Fuga, gli uffici del Coni e la caserma dei carabinieri di Ponte Milvio. La fondazione, organizzazione senza fini di lucro, ha lo scopo di onorare la memoria del giovane attraverso la promozione di iniziative per lo studio e il contrasto della violenza, soprattutto fra i giovani e i bambini. Un gruppo si occupa di donazione del sangue, un altro di premi letterari, un altro ancora di iniziative nelle scuole.
PIAZZA MAZZINI
Qui era il primo impianto sportivo utilizzato dalla Lazio, nel 1905 si trasferì al Parco dei Daini. Qui era la piazza d’armi di Roma. Con questo termine architettonico si definivano quei luoghi atti alle esercitazioni militari, o semplicemente usati per la raccolta di truppe e pezzi d’artiglieria. Come ricordo tangibile della piazza d’armi di Roma restano tutte le caserme lungo viale delle Milizie, tra questo e viale Giulio Cesare. Molte di queste caserme sono state trasformate in uffici giudiziari.
Ci troviamo nel quartiere Della Vittoria di cui rappresenta il centro, attraverso via Ferrari – Lepanto – Marcantonio Colonna - Cicerone si trova in asse con piazza Cavour. Sia la via che la piazza furono sistemate urbanisticamente su progetto del tedesco Joseph Stubben, le prime case risalgono al 1919-21, furono costruite dall’Icp con una serie di piccoli villini in seguito demoliti. Grande incremento alla zona fu dato con la costruzione delle case Incis nel 1924. La piazza è stata sistemata a giardino nel 1926 su progetto di Raffaele De Vico (negli stessi anni sistemò villa Glori, il monumento ai caduti della Grande Guerra al Verano, il serbatoio dell’acqua a porta Maggiore, l’ingresso del Colle Oppio, l’uccelliera e parte dello zoo nel 1935).
PARCO DEI DAINI
Qui la Lazio giocò dal 1905 al 1913 quando un tiro dell’attaccante Fernando Saraceni centrò in pieno volto una nobildonna in carrozza, il marito era il prefetto Angelo Annaratone, la squadra fu sfrattata dal campo.
Il Parco dei Daini si trova all’interno di villa Borghese, alle spalle della Galleria Borghese, ma dispone di ingressi autonomi da via Pietro Raimondi (quartiere Pinciano). Si possono ammirare: la fontana di Venere, il serbatorio dell'Acqua Marcia, la prospettiva del Teatro e il viale dei Sarcofagi. Si compone di un giardino rettangolare più vicino al Casino (progettato da Flaminio Ponzio ma portato a termine da Giovanni Vasanzio nel 1617) e di uno successivo. Al centro del primo spazio rettangolare (piazzale Scipione Borghese) una volta c'era la fontana del Narciso oggi sostituita da quella di Venere. Erme con rigogliose ceste di frutta e verdure sono attribuite a Bernini padre e figlio. A ridosso del muro che separa dal bioparco (lato Nord) è ancora visibile, seppure in parte, il teatro progettato nel 1613-16 da Girolamo Rainaldi (con il figlio Carlo lavorò a palazzo Pamphili in piazza Navona e al palazzo Nuovo al Campidoglio), qui era l'iscrizione della legge ospitale della villa ora a Londra. Fra tutte le costruzioni spicca il serbatoio dell'Acqua Marcia costruito in forme neobarocche agli inizi del Novecento da Raffaele De Vico.
FARNESINA
Qui la Lazio giocò dal 1913 al 1914 poi si trasferì allo stadio della Rondinella.
Si trova nel quartiere Della Vittoria, tra Monte Mario e il Tevere, porta questo nome perché un tempo i terreni erano proprietà dei Farnese.
Il palazzo della Farnesina è sede del Ministero degli Affari Esteri. Fu iniziato nel 1937 dagli architetti Enrico Del Debbio, Arnaldo Foschini e Vittorio Ballio Morpurgo vincitori di un concorso che volevano questo edificio in vari luoghi, si era ipotizzato anche che sorgesse lungo via dei Fori Imperiali. Doveva essere la sede nazionale del Partito Nazionale Fascista. Interrotti per la guerra, i lavori ripresero nel 1946 quando già era decisa la destinazione a ministero degli esteri. Con più di 1.300 stanze e nove piani, con una facciata lunga 169 metri e alta 51, è uno dei palazzi più grandi d’Italia insieme alla Reggia di Caserta. I lavori di costruzione terminarono nel 1959.
All’interno si trova una importante raccolta di arte italiana contemporanea, in occasione delle giornate del Fai è aperta al pubblico. Sul piazzale antistante si trova la “Sfera grande” di Arnaldo Pomodoro (sua la scultura Novecento posta davanti al Palalottomatica all’Eur nel 2004, una fondazione a Milano presso la Darsena di porta Ticinese, vivente) di cui esistono una replica nella Gnam e un’altra nel cortile della Pigna all’interno dei palazzi Vaticani.
STADIO DELLA RONDINELLA
Qui la Lazio giocò dal 1° novembre 1914 (inaugurazione dello stadio con la partita contro l’Audace vinta per 3-2) fino al 1931.
Lo stadio della Rondinella si trovava tra l’attuale stadio Flaminio e il Palazzetto dello Sport, venne costruito nel 1914, ricostruito nel 1924 e dotato di tribuna coperta in legno, spogliatoi, docce, abitazione del custode, spalti su tre lati, con una capienza di 15.000 spettatori. In attesa del trasferimento al campo Testaccio l’impianto ospita anche le partite della Roma, tra queste lo storico 9-0 contro la Cremonese vittoria casalinga con maggior reti di scarto nella storia del club giallorosso. Nel 1957 viene distrutto da un incendio, ciò che rimane viene abbattuto e trasformato in parcheggio.
STADIO NAZIONALE
Qui la Lazio giocò dal 1931 al 1953.
Lo stadio nazionale venne costruito nel 1911, ristrutturato nel 1927 e ribattezzato Stadio del Partito Nazionale Fascista, dopo la guerra riprese il nome originario, dopo il disastro di Superga fu chiamato Stadio Torino, nel 1953 fu dismesso, nel 1957 demolito. Al suo posto venne costruito l’attuale Stadio Flaminio in previsione delle Olimpiadi di Roma del 1960.
Il progetto dello stadio si deve a Marcello Piacentini, sorse presso villa Flaminia, i campi ippici di villa Glori e ai monti Parioli. Piacentini richiamò i tratti classici dei modelli ellenici, aveva la forma di una U allungata, l’ingresso era formato da due enormi corpi laterali che reggevvano colossali statue sedute della Forza e della Civiltà, internamente si trovavano quattro colonne onorarie congiunte da nastri e festoni di bronzo e sovrastate da statue in bronzo. Misurava 220 metri di lunghezza e 120 di larghezza, era affiancato da due lunghe gradinate raccordate da un lato a semicerchio, un altro lato era aperto per il pubblico. All’interno si trovavano piste podistiche e ciclistiche, dentro numerosi locali su due piani per l’Istituto Nazionale di Educazione Fisica, palestre, bagni, refettori, uffici e dormitori per atleti. Non fu mai utilizzato per incontri di calcio. Fu abbandonato durante la Grande Guerra.
Lo stadio fu ristrutturato nel 1927 prendendo il nome di Stadio del Partito Nazionale Fascista, la tribuna centrale fu dotata di una tettoia a struttura in cemento armato per 7.000 posti. Sul lato di ingresso venne inserita una piscina all’aperto lunga 50 metri e larga 18, dotata di spalti. Internamente vi trovarono posto una vasca coperta, palestre, alloggi, uffici della direzione generale del Coni. Al centro venne realizzato un campo di calcio, la pista podistica venne trasformata in anulare. L’ingresso fu sostituito da una facciata classicheggiante con semicolonne e quattro sculture di Amleto Cataldi, oggi nei giardini del Villaggio Olimpico. Venne inaugurato ufficialmente il 25 marzo 1928 con una amichevole Italia – Ungheria, terminata 4-3. Il 24 maggio 1931 si ebbe la prima partita della Lazio, un derby finito in parità, seguito da una rissa che fu punita con la squalifica del campo di entrambe le squadre. Per i mondiali del 1934 venne eliminata la piscina e ampliato nella capienza. Dal 1940 anche la Roma iniziò a utilizzare questo stadio. Durante l’ultima guerra fu requisito dalle truppe alleate, Roma e Lazio usarono il Motovelodromo Appio e lo stadio della Rondinella. Nel 1953 lo stadio fu abbandonato da Roma e Lazio che preferirono il nuovo stadio Olimpico.
STADIO OLIMPICO
Qui la Roma e la Lazio vi giocano dal 1953/54 e tutt’ora. Si trova nel quartiere Delle Vittorie, all’interno del Foro Italico, in viale dello Stadio Olimpico. Siamo alle pendici di monte Mario.
Creato nel 1927 come stadio dei Cipressi su progetto di Enrico Del Debbio (autore del Foro Mussolini, Palazzo del Ministero degli Esteri con altri, la facoltà di Architettura a valle Giulia, la palestra di via Populonia), fu ricostruito nel 1937 da Luigi Moretti (autore dell’Accademia di Scherma, il Villaggio Olimpico e il quartiere di Decima). Durante la guerra venne usato come autoparco delle truppe alleate. Nel 1953 venne ampliato e parzialmento ricostruito da Annibale Vitellozzi (autore nuova stazione Termini, sede biblioteca nazionale), fu chiamato lo stadio dei Centomila, per la capienza. Lo stadio venne inaugurato con la partita Italia-Ungheria e con l’arrivo della tappa Napoli-Roma del Giro d’Italia. Con l’assegnazione a Roma delle Olimpiadi del 1960 fu ribattezzato stadio Olimpico nome che gli rimane tutt’ora. In occasione dei campionati del mondo del 1990, lo stadio è stato quasi completamente ricostruito (progetto di Vitellozzi e Clerici) e ricoperto da una tensostruttura bianca in acciao e teflon che causarono polemiche con gli ambientalisti (forte impatto visivo sulla collina di Monte Mario). Il costo previsto di 80 miliardi di lire salì fino a 200, causando una inchiesta giudiziaria. Da allora può ospitare al massimo 72.698 persone, che lo rendono il secondo stadio d’Italia dopo il Meazza. Qui venne giocata la finale di quei mondiali di calcio tra Germani Ovest e Argentina che videro la vittoria dei tedeschi. Ospita regolarmente competizioni ufficiali di atletica leggere come il Golden Gala dal 1980 e i campionati europei di atletica leggera nel 1974 e quelli mondiali del 1987.
Nel periodo estivo è utilizzato per i concerti.
CENTRO SPORTIVO DI FORMELLO
Il Centro Sportivo si trova nei pressi della cittadina di Formello, sulla via Cassia (altezza di Le Rughe), nel parco regionale di Veio, il comune ha 13.000 abitanti circa e si trova a 225 metri slm. Fu costruito nella seconda metà degli anni Novanta dall’allora presidente Sergio Cragnotti e inaugurato ufficialmente il 7 aprile 1997.
Precedentemente la Lazio si allevana sul campo di Tor di Quinto.
Il Centro Sportivo di Formello si estende su un’area di 40 ha e comprende un campo principale dove disputa le partite casalinghe la formazione Primavera, tale campo è stato intitolato alla memoria di Mirko Fersini, giovane calciatore scomparso prematuramente in un incidente stradale. Vi sono altri campi da gioco, palestre con macchinari all’avnguardia, campi da tennis, piscine, una foresteria, un centro medico, una sala stampa e altri ambienti.
Qui ha sede la redazione del mensile Lazio Style 1900 Official Magazine, studi televisivi e radiofonici.
BIBLIOGRAFIA
- Francesco Valitutti, Breve storia della grande Lazio, ed. Tascabili Newton, 1995.
- Francesco Campanella, Forza Lazio, ed. Bancarella romana, 1994.
SITOGRAFIA
- www.it.wikipedia.org alla voce Società Sportiva Lazio
- www.sslazio.it alla voce storia
Piero Tucci
05.01.15
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
inbiciperoma.blogspot.com
PREMESSA
La prima guerra mondiale fu il più grave conflitto armato che l’umanità avesse mai conosciuto, coinvolse non solo l’Europa ma anche gli Stati Uniti, il Giappone e si interessò anche le colonie degli stati europei e altri paesi extraeuropei. Si combattè dall’estate 1914 alla fine del 1918. Venne chiamata la “Grande Guerra”.
La causa scatenante fu l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo Este avvenuto il 28 giugno 1914 a Sarajevo, in seguito a ciò l’Impero Austro Ungarico dichiarò guerra alla Serbia. A causa delle alleanze che esistevano da anni si formarono due blocchi di Stati contrapposti, da una parte gli Imperi Centrali: Germania, Austria-Ungheria e Impero Ottomano (a cui si unì la Bulgaria), dall’altra parte gli Alleati: Francia, Regno Unito e Impero Russo (ad essi si unì l’Italia nel 1915, con loro la Serbia, il Montenegro, la Grecia, la Romania, il Belgio, il Portogallo, e il Giappone. Dal 1917 gli Stati Uniti). Oltre 70 milioni di uomini furono mobilitati nei due fronti, di questi 9 milioni caddero sui campi di battaglia; altri 7 milioni di civili morirono in conseguenza della guerra. L’Italia ebbe 615.000 morti e quasi un milione di feriti, molti di più della seconda guerra mondiale che venne combattuta su tutto il territorio nazionale e venne attraversato da eserciti opposti con il fenomeno della Resistenza. Nella seconda guerra mondiale l’Italia ebbe 313.000 vittime militari e 130.000 civili.
Le prime operazioni militari videro una avanzata fulminea dell’esercito tedesco in Belgio, Lussemburgo e nel nord della Francia ma, gli anglo-francesi riuscirono a bloccare tale avanzata nella prima battaglia della Marna. Il contemporaneo attacco russo da Est spense la speranza tedesca di una guerra rapida, anzi divenne una logorante guerra di trincea su tutti i fronti, con questa caratteristica rimase fino alla fine.
Due fatti importanti accaddero durante il conflitto: lo scoppio della rivoluzione in Russia e l’ingresso in guerra degli Usa al fianco degli Alleati. La guerra si concluse con l’armistizio di Villa Giusti (4 novembre 1918) per il fronte italiano e con l’armistizio di Rethondes (11 novembre 1918).
RIPERCUSSIONI ECONOMICO SOCIALI
“La guerra determinò all’interno di ciascuno stato ripercussioni di estrema gravità… La guerra, con le sue enormi esigenze di armanento, di munizioni, di approvvigionamento di ogni genere, poneva davanti a ogni governo un problema di dimensioni mai viste fino ad allora. Si rendeva necessaria una enorme dilatazione delle industrie di guerra, si affacciava la necessità di controllare pressocchè interamente la vita econnomica del paese, onde far converger tutte le risorse ai fini bellici e assicurare, insieme, un minimo di possibilità alimentari ai combattenti e alla popolazione civile, si profilava il problema di assicurare contemporaneamente la mano d’opera alle industrie, all’agricoltura, alla navigazione mercantile, senza diminuire l’afflusso di nuove masse di combattenti sui fronti. Tutto questo determinava un intervento ed un controllo dello Stato in profondità, in ciascun settore della vita nazionale, rompendo la tradizione del liberismo ecomomico… mentre la sicurezza militare portava fatalmente a sospendere le stesse libertà fondamentali, sulle quali si basava tutto il sistema politico europeo…
Organizzazione della produzione di guerra, sistemi di razionamento e tesseramento dei generi alimentari, con tutto ciò lo Stato assumeva su di se compiti direttivi nel campo economico, quali mai erano stati prospettati… Libertà di stampa e di riunione, segreto epistolare, diritti personali, scomparivano a vantaggio dei poteri del governo e dei militari. Per la prima volta nella storia anche l’Inghilterra, terra classica del liberismo, era costretta ad adottare la coscrizione obbligatoria e a sospendere gran parte dei diritti dei cittadini.
Di converso tutto ciò ingigantiva il peso che nella politica interna… venivano ad avere gli elementi militari e i grandi complessi industriali, dai quali in definitiva dipendeva l’esito della guerra… Si verificarono ovunque rapidissimi e violenti spostamenti di fortune…, mentre alcuni erano rovinati dal conflitto, altri riuscivano ad accumulare fortune colossali…
Tutti questi fenomeni di ordine economico e sociale dovevano ben presto assumere un’importanza enorme nel determinare l’erosione del liberalismo classico, preso come in uma morsa tra il nazionalismo autoritario da una parte e la rinnovata spinta rivoluzionaria delle masse operaie e contadine dall’altra. Due fenomeni caratteristici…” del Novecento, il fascismo e il comunismo, “trovano già le loro radici nella situazione maturata in seguito alla guerra mondiale nella maggior parte d’Europa[1]”.
ITINERARIO
PIAZZA VENEZIA
Oltre all’Altare della Patria, che conserva la sepoltura del Milite Ignoto,
la piazza ricorda i trofei di guerra tolti agli austriaci.
Nel Vittoriano si trova il Sacrario delle Bandiere
con i mas e altri armamenti, e il Museo del Risorgimento
con cimeli della Grande Guerra.
Sul lato Sud della piazza, addossato al colle Capitolino, si trova il MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II, detto anche VITTORIANO o ALTARE DELLA PATRIA.
Grandiosa mole dell’arch. Giuseppe Sacconi, iniziato nel 1885 per celebrare il cinquantenario dell’unità nazionale e inaugurato nel 1911. Il calcare di Botticino (Brescia) usato nella costruzione, di un bianco freddo e abbagliante non si armonizza con la tinta calda e dorata del travertino, la pietra dominante a Roma; né il monumento riesce ad ambientarsi nella scenografia delle rovine circostanti.
Un’ampia scalinata sale all’ALTARE DELLA PATRIA e si divide poi in due rampe che, girando dietro l’altare, si ricongiungono alla statua del re, si aprono nuovamente per sboccare su un vasto ripiano, dominato dal porticato a esedra che corona l’edificio.
Nell’esedra di destra la fontana del Tirreno di Pietro Canonica, in quella di sinistra l’Adriatico di E. Quadrelli. Davanti a quest’ultima i resti della tomba di Caio Publicio Bibulo, del I sec. a. C. importante caposaldo della della topografia di Roma antica: si trovava infatti fuori della cerchia delle mura Serviane (come è noto era vietato seppellire in città).
Alle testate della scalinata due grandi gruppi allegorici in bronzo dorato: Il pensiero di Giulio Monteverde a sinistra e L’azione di Francesco Jerace a destra.
Sul primo ripiano l’ALTARE DELLA PATRIA, vasta e armoniosa composizione architettonica e scultorea con nel mezzo, contro un’edicola, la solenne statua di Roma, verso cui convergono, in altorilievo i Cortei trionfali del lavoro, a sinistra, e dell’Amor patrio a destra, opere dello scultore Angelo Zanelli. Ai piedi della statua di Roma si trova, dal 1921, la TOMBA DEL MILITE IGNOTO, la salma di un soldato sconosciuto morto nella prima guerra mondiale, costantemente guardata da due sentinelle armate.
Le scale salgono ai due portali del Museo del Risorgimento, quindi proseguono fino alla STATUA EQUESTRE DI VITTORIO EMANUELE II di Enrico Chiaradia, alta e lunga 12 metri, in bronzo già dorato. Poggia su un basamento con le statue delle città italiane di Eugenio Maccagnani.
Segue un altro grande ripiano conotto are con i simboli araldici delle città italiane liberate nella guerra 1915-18 e in mezzo un masso del monte Grappa.
Sovrasta il grandioso PORTICO in curva, composto di 16 colonne alte 15 metri; nell’attico le statue delle regioni d’Italia, alte cinque metri. Dal portico meraviglioso panorama di Roma.
Sopra i propilei spiccano due colossali quadrighe di bronzo con Vittorie alate, opera di Carlo Fontana e di Paolo Bartolini (1908).
Alla fine della Grande Guerra venne deciso di onorare tutti i soldati morti in guerra per la patria tumulando in questo luogo uno dei tanti caduti italiani di cui non si conosceva l’identità. Venne scelta la madre di un volontario delle terre irredente, che aveva disertato l’esercito austriaco, caduto in combattimanto senza che il corpo fosse stato ritrovato: Maria Bergamas[1]. Alla donna venne dato l’incarico di scegliere una salma tra undici tutte non identificate. La cerimonia avvenne ad Aquileia il 26 ottobre 1921, la donna passò davanti alle salme, giunta davanti ad una non riuscì più a proseguire, si accasciò al suolo pronunciando il nome del figlio: Antonio. Tale feretro fu collocato su un affusto di cannone e, accompagnato da reduci decorati di medaglia d’oro, fu deposto su un carro ferroviario.
Le altre dieci salme furono tumulate nel cimitero di guerra collocato nel prato dietro la basilica di Aquileia. Il viaggio venne effettuato a velocità ridotta, il convoglio si fermò in molte stazioni dove la gente ebbe modo di onorarlo. Una folla strabocchevole lo attese anche per ore. A Roma venne accolta dal Re, dai rappresentanti dei combattenti, delle vedove e delle madri dei caduti, inoltre erano presenti le bandiere di tutti i reggimenti, si fermò nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, finalmente il 4 novembre 1921 venne tumulata nel Vittoriano.
Negli anni Trenta il feretro venne traslato nella cripta interna al Vittoriano costruita con rocce provenienti dalle montagne in cui si combattè la prima guerra mondiale: il Grappa, il Carso e altre.
Ogni capo di Stato in visita in Italia e il Presidente della Repubblica appena eletto fa visita al Milite Ignoto e gli rende omaggio.
MUSEO CENTRALE DEL RISORGIMENTO Fa parte dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano che comprende il centro di Studi, l’Archivio, le pubblicazioni e il museo vero e proprio. Nel museo è documentata la storia d’Italia dalla metà del Settecento a tutta la prima guerra mondiale. Queste testimonianze sono formate da documenti cartacei: lettere, diari, manoscritti; da quadri, sculture, disegni, incisioni, stampe, armi che rievocano fatti e protagonisti del periodo storico preso in esame. L’ultima sezione del museo è dedicato alla Prima Guerra Mondiale che secondo alcuni storici non è altro che la IV Guerra d’Indipendenza. Si possono vedere il calamaio d’argento con penna utilizzato per firmare l’armistizio di Villa Giusti, borracce, maschere antigas, uno dei volantini lanciati da Gabriele D’Annunzio su Vienna nell’agosto del 1918 e – nell’ultima sala – l’affusto di cannone sul quale venne trasportata a Roma la salma del Milite Ignoto. Di tale conflitto mondiale abbiamo anche filmati dell’Istituto Luce e registrazioni sonore. Alcuni artisti vennero ingaggiati dai comandi militari per documentare gli avvenimenti di guerra: tra questi Giulio Aristide Sartorio, Tommaso Cascella, Anselmo Bucci. Esisteva inoltre, un reparto di fotocinemaoperatori che documentò la vita di trincea e quella sul mare.
Il museo, dopo un lungo periodo di chiusura, è stato riallestito nel 2001, anche per interessamento dell’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che molto si è adoperato per la valorizzazione del Vittoriano.
SACRARIO DELLE BANDIERE Raccoglie le bandiere di guerra dei reparti disciolti, nonché le bandiere degli istituti militari. Sono custoditi cimeli particolarmente importanti relativi alle guerre combattute dalle Forze Armate italiane. Tale area fu inaugurata nel 1968, in occasione del cinquantenario della vittoria nella Prima Guerra Mondiale. Il Museo Sacrario della Marina, ubicato al piano terra, fu istituito nel 1961 per celebrare i cento anni di vita della Marina Militare.
Il Mas 15 con cui, nei pressi di Premuda, Luigi Rizzo, effettuò il 10 giugno 1918 un audace attacco contro una formazione navale austriaca che culminò nell’affondamento della corazzata Szent Istvan. Accanto vi è il Siluro lenta corsa o maiale della Seconda Guerra Mondiale, di Tesei e Vicentini, con cui furono violate le più munite basi navali del nemico, da Gibilterra ad Alessandria, da Algeri ai porti italiani occupati dai tedeschi.
Il MAS è la sigla di Motoscafo Armato Silurante, è una piccola imbarcazione militare usata come mezzo d’assalto veloce. Fondamentalmente si trattava di un motoscafao da 20/30 tonnellate con una decina di uomini di equipaggio e armamento costituito generalmente da due siluri e alcune bombe di profondità, oltre a mitragliatrice o cannoncino.
Tra le altre bandiere vi sono quelle della fregata Re di Portogallo che si battè valorosamente a Lissa e quella della corazzata Duilio che al suo nascere rivoluzionò la tecnologia navale dell’epoca. Con i suoi 4 cannoni da 450 mm in due torri binate e la velocità di 15 nodi, al momento della sua apparizione fu, per velocità, protezione e armamento, unanimemente riconosciuta la corazzata più potente in servizio (varata nel 1880 – radiata nel 1909). La più antica bandiera attualmente conservata nel sacrario è quella della fregata Garibaldi, già borbonica Borbone.
PIAZZA DELL’ESQUILINO
E’ il luogo delle manifestazioni interventiste,
furono la spinta popolare all’entrata in guerra dell’Italia.
Questa fu il teatro delle manifestazioni favorevoli all’intervento italiano nella grande guerra. Tra via Cavour e via di Santa Maria Maggiore c’è un balcone (detto “Prua d’Italia”) dal quale si esibì Gabriele D’Annunzio in uno dei suoi discorsi pieni di retorica patriottica. Da tali discorsi e da questa mobilitazione prese successivamente spunto il fascismo per porsi come erede dello spirito della Grande Guerra. D’Annunzio parlò anche al Campidoglio, altre manifestazioni si tennero in piazza del Quirinale per sollecitare o sostenere il Re all’intervento in guerra.
La guerra mondiale scoppiò il 28 luglio 1914 mentre l’Italia era rimasta neutrale. Erano contrari all’intervento in guerra dell’Italia i socialisti e i cattolici; i primi perché era inconcepibile che proletari di un paese combattessero contro proletari di un altro paese, i secondi perché era altrettanto inconcepibile che i cattolici italiani combattessero contro i cattolici austriaci. Anche Giolitti e i suoi seguaci liberali erano contrari all’intervento perché avrebbe esposto l’Italia ad un cimento superiore alle sue forze. A favore della guerra erano i nazionalisti i socialisti riformisti (come Bissolati) e i socialisti rivoluzionari (come Mussolini), gli ambienti monarchici che vedeva una occasione di gloria per la monarchia ma soprattutto una possibilità per liberare le “terre irredente”, in breve Trento e Trieste. Un grande aiuto venne a questi ultimi dal poeta Gabriele D’Annunzio con la sua parola ricca i fascino.
Anche se il parlamento era in maggioranza contrario alla guerra, il capo del governo Salandra, esponente dell’estrema destra e la corona si adoperarono per la partecipazione al conflitto contando sul fatto che una vittoria militare avrebbe portato ingrandimenti territoriali, maggiore prestigio per la corona, minacciato dalla Settimana Rossa (giugno 1914).
PIAZZA DEI CINQUECENTO
E’ il luogo nel quale una grande folla accolse come trionfatori
Armando Diaz e Pietro Badoglio alla fine del conflitto.
Un’altra manifestazione, alla fine del conflitto, accolse
Vittorio Emanuele Orlando che aveva abbandonato
Parigi sede delle trattative di pace.
Nel clima di esaltato patriottismo determinato dai sacrifici della guerra e dalla vittoria contro l’impero asburgico, si tenne una vera e propria manifestazione tra piazza dei Cinquecento e piazza Esedra (oggi della Repubblica), con essa, una folla strabocchevole accolse il generale capo di Stato Maggiore Armando Diaz che aveva guidato l’esercito italiano dopo la sconfitta di Caporetto (24 ottobre – 12 novembre 1917) e Pietro Badoglio che, insieme a Gaetano Giardino, aveva affiancato Diaz nel ruolo di vice comandante di Stato Maggiore.
Si formò un corteo che raggiunse il Quirinale per omaggiare il Re.
Un’altra manifestazione di popolo, di grandi dimensioni avvenne per il rientro in patria di Vittorio Emanuele Orlando, capo del governo e Sidney Sonnino, ministro degli Esteri. I due stavano partecipando ai trattati di Pace. Un grave disaccordo era intervento tra l’Italia e gli altri paesi vincitori del conflitto sulle condizioni di pace. Vediamo di ricostruire brevemente quanto accaduto.
L’Italia era entrata in guerra in seguito al patto di Londra, con esso l’Italia aveva diritto a prendersi non solo territori indiscutibilmente italiani come il Trentino, Trieste e la costa dell’Istria, ma anche il Sud Tirolo tedesco e l’interno dell’Istria slavo, nonché la Dalmazia anch’essa slava ad eccezione di Zara italiana. Ciò era stato fatto al fine di garantirsi da una riscossa austriaca, ma l’impero asburgico era sparito, erano nati nuovi stati come la Jugoslavia, e l’Austria era ridotta a un piccolo stato con una capitale Vienna enorme, si disse un piccolo corpo con una grande testa.
Se quindi i rappresentanti italiani richiedevano la rigida attuazione del patto di Londra, la Jugoslavia reclamava le terre abitate da slavi sulla base del principio di nazionalità. A complicare le cose sorgeva il problema di Fiume che il patto di Londra lasciava alla Croazia come sbocco al mare, ma fin dal 30 ottobre 1918, la popolazione aveva proclamato la volontà di unirsi all’Italia.
Tutta l’intransigenza italiana si ritorceva contro di noi rispetto al problema delle ex colonie tedesche che avevano un valore economico ben più alto delle povere terre abitate da slavi. Inoltre l’Italia aveva tutto l’interesse ad avere buoni rapporti con la Jugoslavia dove la nostra industria poteva esportare i propri prodotti, tale interesse era anche della Jugolavia, ma la nostra rigidità ci creava nemici nei balcani invece di alleati.
Davanti a tutto ciò la delegazione italiana si ritirò dalla conferenza di pace, tale gesto restò sterile.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Nella chiesa la sepoltura di Armando Diaz e Thaon di Revel.
Armando Diaz, oltre ad essere considerato il “Duca della Vittoria”, generale e capo di Stato Maggiore del Regio Esercito, dopo la guerra fu ministro della guerra tra il 1922 e il 1924 nel governo presieduto da Mussolini; ebbe il titolo di Maresciallo d’Italia.
La famiglia era di lontane origini spagnole, era nato a Napoli nel 1861, fu avviato giovanissimo alla carriera militare, frequentò la Nunziatella, divenne ufficiale all’Accademia militare di Torino. Prese servizio in un reggimento di artiglieria da campo. Dal 1895 lavorò allo Stato Maggiore nella segreteria del generale Alberto Pollio, nel 1899 venne promosso maggiore, nel 1905 tenente colonnello. Nel 1910, durante la guerra di Libia comandò il 21° fanteria, fu ferito a Zanzur nel 1912. Durante la prima guerra mondiale fu assegnato alla III armata che gli valse la medaglia d’argento per una ferita riportata alla spalla. La sera dell’8 novembre 1917 fu chiamato a sostituire Luigi Cadorna nella carica di capo di Stato Maggiore dell’Esercito, per via della disfatta di Caporetto. Organizzò la resistenza sul monte Grappa e sul Piave, decentrò molte funzioni ai sottoposti, riservandosi un ruolo di controllo. Nell’autunno del 1918 guidò alla vittoria le truppe italiane, iniziando l’offensiva il 24 ottobre, con 58 divisioni contro 73 austriache. Il piano prevedeva l’attacco in un solo punto, a Vittorio Veneto, preceduto da un’azione diversiva lungo il Piave. Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre l’esercito passò all’attacco, il fronte austriaco si spezzò avviando una reazione a catena. Il 3 novembre si arrivò a Trento. Il 4 novembre l’Austria capitolò, in questa occasione Diaz stilò il celebre “Bollettino della Vittoria”. Alla fine della guerra divenne senatore. Venne onorato da una parata a New York, primo fra gli italiani. Entrò nel primo governo Mussolini su precisa condizione del Re che intendeva porre una figura di prestigio e di sicura fede monarchica. Da ministro accettò la costituzione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale sottoposta direttamente a Mussolini. Terminata l’esperienza governativa si ritirò a vita privata, era sposato dal 1895, morì nel 1928.
La chiesa di Santa Maria degli Angeli venne sistemata da Michelangelo nell'aula del tepidarium delle terme di Diocleziano nel 1563-66 e rimaneggiata da Vanvitelli nel 1749. E' la chiesa preferita per le funzioni religiose di carattere ufficiale (matrimonio di Umberto II, funerali di Eleonora Duse). La facciata disadorna, in cotto, è formata dall'esedra di una sala delle terme, probabilmente il calidarium. Ai primi del Novecento si decise di demolire la facciata opera di Vanvitelli. Le due porte della basilica sono opera dell'artista polacco Igor Mitorj, rappresentano: a sinistra il Redentore, a destra l'Annunciazione (poste in opera il 28 febbraio 2006). Interno a croce greca. La navata trasversale veramente dà l'idea della grandiosità delle costruzioni romane, m 90,8 di lunghezza, m 27 di larghezza, m 28 di altezza; tre volte a crociera coprono la navata, 8 immense colonne di granito rosa, monolistiche sono parzialmente interrate perchè Michelangelo dovette alzare il livello della chiesa. Entrando in chiesa subito a sinistra e destra le sepolture di Salvator Rosa e Carlo Maratta. Nella cappella di destra "Cristo in Croce con San Girolamo e devoto" di Daniele da Volterra. Nella navata trasversale si trovano grandiose pale d'altare provenienti da San Pietro, nella tratto di sinistra "Caduta di Simon Mago" di Pompeo Batoni; nella navata trasversale sono sepolti il maresciallo Armando Diaz, "il generale della Vittoria" (di Antonio Munoz), il grand'ammiraglio Thaon di Revel e il capo di governo Vittorio Emanuele Orlando (entrambe del Canonica). Sul pavimento è presente una grandiosa meridiana voluta da papa Clemente XI per il giubileo del 1700 al fine di dimostrare la correttezza della riforma del calendario gregoriano. Notare le costellazioni che fiancheggiano la linea di meridiana. Nella tribuna si trovano il "Matirio di San Sebastiano" del Domenichino, il "Battesimo di Gesù" di Carlo Maratta e nell’abside il sepolcro di papa Pio IV.
CIMITERO MONUMENTALE DEL VERANO
Nel nuovo settore si trova il monumento che
ricorda tutti i caduti, è opera dell’arch. De Vito.
Nel cimitero monumentale del Verano si trova un imponente e spettacolare monumento che ricorda le vittime del grande conflitto mondiale. Si trova la margine Est, lungo la tangenziale. Una parete di marmo bianco concava reca i nomi di tutti i romani caduti. E’ opera del 1926 dell’arch. Raffaele De Vico, il celebre architetto dei giardini romani (Villa Glori, Giardini di piazza Mazzini, Colle Oppio, ampliamento dello zoo con l’uccelliera, parco Nemorense e parco Savello sull’Aventino, serbatoio idrico di porta Maggiore). Al di sotto vi è una grandiosa cripta a pianta circolare dalla quale si accede da due scale circolari. E’ denominato Monumento Ossario ai Caduti della Guerra 1915-18. Tale monumento si vede anche dall’esterno del cimitero, passando da via Tiburtina e guardando dall’ingresso / cancellata di Portonaccio.
Il Verano è il Cimitero Monumentale di Roma la cui entrata è presso la basilica di San Lorenzo fuori le Mura, deve il suo nome alla gens Verani, senatori dai tempi della repubblica. La zona era da sempre luogo di sepoltura perché si trovava lungo una antichissima via consolare, la Tiburtina. Nelle catacombe di Santa Ciriaca fu sepolto San Lorenzo, sulla cui tomba sorse la basilica. Durante il dominio francese su Roma venne applicato l’editto di Saint Cloud che stabiliva che tutte le sepolture dovessero essere fuori dai centri urbani. Il progetto del cimitero si deve a Giuseppe Valadier, lo stesso autore di piazza del Popolo tra il 1807 e il 1812. Con la restaurazione i papi mantennero l’uso del cimitero. Sotto la direzione di Virginio Vespignani venne realizzato il quadriportico d’ingresso (1880), dopo l’unità d’Italia il cimitero si ingrandì ancora fino ad acquistare villa Mancini, zona oggi denominata il Pincetto. Dagli anni Sessanta nel cimitero possono essere sepolte solo le persone che dispongono di cappelle di famiglia, da allora le sepolture avvengono nel cimitero Flaminio detto dai romani di Prima Porta. Il 19 luglio 1943 un terribile bombardamento degli alleati, che aveva lo scopo di colpire lo scalo ferroviario, causò gravissimi danni nel vicino quartiere di San Lorenzo e la morte di circa 1.000 persone. Anche il cimitero venne colpito, furono danneggiati il quadriportico, il Pincetto, il sacrario militare e il crollo di un tratto di mura a destra dell’ingresso causando la morte di alcune persone che vi avevano cercato riparo. Anche le tombe di Petrolini e della famiglia Pacelli subirono danni.
L’ingresso al cimitero è caratterizzato da tre fornici, tra due corpi di fabbrica, con quattro grandi statue sedute de: la Meditazione (di Francesco Fabj-Altini), la Speranza (di Stefano Galletti), la Carità (sempre di Fabj-Altini) e il Silenzio (di Giuseppe Blasetti). E’ opera di Virginio Vespignani degli anni 1874-78. Da questo spettacolare ingresso si accede al quadriportico opera di Vespignani che ha nel fondo la cappella di Santa Maria della Misericordia dello stesso architetto ma precedente all’ingresso, all’interno della cappella “Le anime purganti”, pala d’altare di Tommaso Minardi. Per l’importanza storica e culturale da alcuni anni si organizzano visite guidate al cimitero stesso. Molti sono gli artisti degli ultimi due secoli che hanno realizzato tombe e sculture: Duilio Cambellotti, Mirko Basaldella, Raffaele De Vico e tanti altri.
Il 15 luglio 2003 è stato inaugurato il Centro di Documentazione dei Cimiteri Storici di Roma dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Collocato all’ingresso del portico è aperto su richiesta, nella settimana della Cultura (in primavera) e nel periodo della commemorazione dei defunti. Video, fotografie, proiezioni e cataloghi informatizzati costituiscono il materiale che si può consultare nel centro.
TORPIGNATTARA
VIA CASILINA ANGOLO VIA FRANCESCO BARACCA
Uno dei più singolari monumenti ai caduti.
In uno slargo, lungo la Casilina, presso via Francesco Baracca, si trova l’unico monumento di Roma che utilizza un cannone, cioè una delle armi usate durante la Grande Guerra. A lato si trova un parallelepipedo in travertino che porta incisi i nomi dei caduti del “suburbio” come veniva denominato allora il quartiere. Il giardinetto è delimitato da un recinto in ferro, agli angoli dei proiettili per cannoni.
Il luogo è famoso anche per essere apparso nel film “Un borghese piccolo piccolo” del 1977, diretto da Mario Monicelli con Alberto Sordi.
PIAZZA SALERNO
Sulla piazza la chiesa dei Sette Santi Fondatori,
nella cripta il sacrario con tutti i caduti per la Patria.
Sulla piazza del quartiere Nomentano si trova una chiesa moderna, pochi romani sanno che la cripta della chiesa è dedicata ai morti e ai dispersi italiani di tutte le guerre, vi sono conservate le memorie relative ai caduti, foto, medaglie, divise, bandiere, armi, nonché i loro nomi scolpiti nelle pareti.
Si tratta della chiesa dei Sette Santi Fondatori, costruita tra il 1946 e il 1956 su progetto dell’arch. Alberto Tonelli ed intitolata ai sette fondati dell’ordine dei Serviti (devoti fiorentini del secolo XIII). La parrocchia è preesistente, risale al 1935. La chiesa è a pianta dodecagonale, esternamente presenta due ordini: quello inferiore rivestito di marmo bianco, quello superiore di mattoni di laterizio attraversato da nervature verticali in cemento armato e coronato da una serie di finestre-vetrate policrome. L’interno a forma circolare con una serie di dieci pilastri di cemento che accennano ad una navata perimetrale. Dietro l’altare maggiore è collocato un mosaico realizzato nel 1964 da Ambrogio Fumagalli. Da segnalare l’affresco “La visione della Madonna ai Sette Santi Fondatori” di Maceo Casadei, del 1959.
La chiesa si affaccia su una piazza circolare, al centro un caratteristico monumento a Guido Baccelli, eretto nel 1930, con bronzi di Attilio Selva. Si compone di tre colonne di travertino unite al vertice da una trave, la base è in pietra scura, tra le colonne i bronzi di Selva. Attilio Selva (Trieste 1888 – Roma 1970) studiò a Trieste, quindi si stabilì a Milano e Torino dove lavorò con Bistolfi, dal 1909 si stabilì a Roma. Realizzò la fontana di piazza dei Quiriti a Roma, la statua di San Carlo a piazza Augusto Imperatore, il monumento a Oberdan a Trieste, il monumento a Nazario Sauro a Capodistria, a Montecassino il gruppo bronzeo della Morte di San Benedetto e paliotto in argento nel 1970, ma la sua opera più celebre resta il monumento ai caduti di Trieste presso San Giusto. Guido Baccelli (Roma 1830 – 1916) medico e uomo politico. Si adoperò per curare la malaria. Deputato e consigliere comunale fu per ben sette volte ministro della pubblica istruzione. Promosse la realizzazione del Policlinico di Roma, della Gnam, gli scavi alle terme di Caracalla con la passeggiata archeologica e scavi a Pompei.
PORTA PIA
MUSEO STORICO DEI BERSAGLIERI
In questo, come negli altri musei storici delle armi,
vari cimeli ricordano il contributo dato da ognuna
nella Grande Guerra.
Il museo si trova all’interno di porta Pia, o meglio nella struttura ideata da Virginio Vespignani, che precede la porta stessa. In esso si trovano i cimeli ed i ricordi relativi alla istituzione del Corpo, seguendo il filo logico delle vicende alle quali parteciparono reparti di bersaglieri.
Nel lato Sud dell’edificio, il piano inferiore, è dedicato alla Prima Guerra Mondiale: targhe, fotografie, gagliardetti di reparto, statue celebrative, ritratti e medaglieri di comandanti e bersaglieri semplici, armi italiane ed austriache, tra queste la mitragliatrice che falciò, alle ore 16 del 4 novembre 1918 al Quadrivio del Paradiso, il diciannovenne sottotenente Alberto Riva di Villasanta ed i suoi bersaglieri, ultimi caduti nella Grande Guerra.
Il museo venne inaugurato il 18 settembre 1932 in concomitanza con quella del monumento al Bersagliere nel piazzale antistante. Nel cortile di ingresso al museo sono collocati busti in bronzo di alcuni dei più illustri rappresentanti del Corpo e il monumento al più romano dei bersaglieri Enrico Toti, volontario per vocazione. Al piano terreno una saletta è dedicata a La Marmora, il fondatore del corpo, vi sono esposte due carabine con fiaschetta per polvere a misurazione automatica per il rapido caricamento, furono ideate da lui nel 1836. Tra i cimeli la Proposizione originale, scritto di pugno da La Marmora per ottenere da Carlo Alberto la costituzione del corpo.
Il monumento al Bersagliere è opera dello scultore Publio Morbiducci (romano, autore dei dioscuri al Colosseo quadrato, della fontana al Viminale, monumento a Emanuele Filiberto in piazza Castello a Torino), mentre il progetto architettonico è di Italo Mancini, venne inaugurato nel 1932. Il progetto di Morbiducci risultò vincitore perché sembrò di facile impatto sul pubblico ed interpretava in modo autentico il carattere popolare del bersagliere. L’autore coniuga un esasperato realismo con un forte vigore plastico.
Il monumento è costituito da una imponente scultura in bronzo, alta 4 metri, che raffigura il bersagliere scattante all’assalto, posto su un basamento di travertino opera di Mancini. Sui lati maggiori dello stesso basamento si trovano bassorilievi in pietra di Trani che raffigurano personaggi e battaglie combattute dai bersaglieri: il ponte di Goito, Luciano Manara, Porta Pia a sinistra, Sciara Sciat, Enrico Toti, Riva di Villasanta a destra.
PIAZZA SANTA CROCE
MUSEO STORICO DELLA FANTERIA
Chiuso per restauro dal 22 luglio 2013.
Il museo è articolato in tre settori: - Armi, bandiere e uniformi, è organizzato su una direzione, la biblioteca con archivio storico e il sacrario. Dispone di 35 sale espositive a cui si devono aggiungere 5 gallerie o androni. Il patrimonio del museo è costituito da cimeli, documenti e ricordi provenienti da donazioni o da acquisti, da pitture, disegni e sculture. Una sezione è dedicata alla Prima Guerra Mondiale. Tra le opere d’arte si segnala la statua marmorea del “Partente” di B. Poidimani, posta al piano terra presso l’ingresso e il “Redentore sulla Croce” nell’atto di piegarsi a sorreggere due fanti morenti, dello scultore Edmondo Furlan.
PIAZZALE APPIO
Uno dei tanti monumenti ai caduti sparsi nei quartieri e nei rioni di
Roma, ma anche in tutti i comuni e frazioni d’Italia.
Il monumento ai caduti del quartiere Appio Latino e Tuscolano è costituito da una lapide murata sulle Mura Aureliane presso porta San Giovanni, in viale Castrense. Si vede un angelo che sorregge un fante ormai defunto, il militare regge ancora nella mano destra il fucile; la presenza di un capitello e di una corona ingentilisce la scena. Nel primo anniversario della fine della seconda Guerra Mondiale alla suddetta lapide è stata affiancata un’altra lapide che ricorda i partigiani del quartiere (VI zona) morti nella lotta di Liberazione Nazionale, la lapide fu voluta dal partito d’azione. Tra i nomi che vi sono riportati spicca quello di Pilo Albertelli, docente di storia e filosofia nel Liceo Classico Umberto I oggi intitolato a lui, fu membro del comitato militare antifascista durante l’occupazione tedesca di Roma, arrestato il primo marzo del 1944 per denunzia di un delatore, fu portato nella pensione Oltremare occupata dalla Banda Koch, fu torturato ma non fece i nomi dei compagni di lotta, venne ucciso alle Fosse Ardeatine (è medaglia d’oro). Si è così creato, volutamente, un rapporto tra i caduti per la Patria in due diverse contingenze storiche.
PIAZZA DELLA CROCE ROSSA
MONUMENTO AL FERROVIERE
Uno tra i tanti monumenti dedicati
alle categorie di lavoratori morti in guerra.
A Roma vi sono monumenti ai caduti morti nella Grande Guerra dedicati agli impiegati comunali, ai postelegrafonici, impiegati alle Corte dei Conti e così via. Questo dedicato ai ferrovieri si trova davanti alla sede generale delle Ferrovie dello Stato. E’ un monumento di grandi dimensioni, è opera di un artista di rilievo, le sue opere si trovano alla Gnam, alla Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale, è Amleto Cataldi[2]. Non si conosce la data esatta della sua erezione, certo non dopo il 1924.
VIA NOMENTANA
VILLA PAGANINI
Monumento ai caduti del Nomentano e Salario.
Forse il monumento ai caduti più bello tra quelli dedicati agli abitanti dei quartieri di Roma caduti in guerra. Da foto d’epoca si vede che era inizialmente collocato ad un incrocio di quattro strade, piazza Regina Margherita, poi spostata per ragioni di traffico veicolare. Oggi si trova nella villa Paganini, guarda verso via Nomentana e villa Torlonia, il monumento è dedicato ai caduti dei quartieri Nomentano e Salario.
Il monumento rappresenta una Vittoria alata su cavallo, è opera di Arnaldo Zocchi. Scultore fiorentino, presidente dell’Accademia di San Luca, lavorò al Vittoriano, realizzò il monumento a Garibaldi a Bologna, ad Altamura un monumento alla libertà in onore dei martiri del 1799 che difesero la repubblica Partenopea contro l’esercito del card. Ruffo.
Verso via Dalmazia si trova il portale in tufo non ben conservato (all’interno si intravede un edificio scolastico, una targa recita “Scuola di mosaico”) e l’ingresso alla villa recentemente riqualificata (2011, ma oggi in grave stato di abbandono) voluta dal cardinale Giulio Alberoni (1661 – 1752) che fu ministro di Filippo V di Spagna. Al centro della villa c’è una finta grotta da cui scaturisce acqua che forma un piccolo corso d’acqua, un laghetto sovrastato da un bel ponte in legno. Una parte della villa è occupata da padiglioni in legno. Le vie sono intitolate alle vittime della mafia (D’Antona, La Torre, Impastato, Savena, Antiochia, Caponnetto, Ambrosoli, Marco Biagi, Rita Atria).
VILLA BORGHESE – PINCIO
Emiciclo con i caduti eroici della Grande Guerra e
monumento a Enrico Toti.
Sono busti collocati a semicerchio subito dopo il ponte che scavalca il muro Torto. Furono collocati nel 1926. Il busto di Damiano Chiesa è opera di Pietro Melandri. Il busto di Fabio Filzi è opera di Publio Morbiducci.
Oltrepassato il ponte si trova la doppia esedra arborea degli eroi con i busti bronzei di alcuni eroi della prima guerra mondiale, tutti irredentisti, a sinistra Guglielmo Oberdan, a destra Damiano Chiesa, Francesco Rismondo, Cesare Battisti, Nazario Sauro e Fabio Filzi.
Guglielmo Oberdan, triestino, uno dei massimi esponenti dell’irredentismo, condannato a morte per aver espresso la volontà di attentare alla vita di Francesco Giuseppe nell’occasione della visita dell’imperatore nella città per festeggiare i 500 anni di Trieste austriaca. Davanti alla magistratura austriaca si autoaccusò del proposito. Una scuola elementare gli è intitolata a Roma in largo Ravizza (Monteverde) ubicata in una villa gentilizia (villa Baldini). Damiano Chiesa era un patriota di Rovereto, si arruolò volontario nell’esercito italiano sotto falso nome pur essendo cittadino dell’impero austriaco, catturato dagli austriaci fu riconosciuto da un orologiaio prussiano di Rovereto e fucilato come disertore. Francesco Rismondo, nativo di Spalato, fu presidente del Veloclub della sua città in quanto appassionato ciclista, allo scoppio della guerra si arruolò volontario tra i bersaglieri ciclisti, disperso durante la battaglia di Opacchiasella morì a Gorizia o in un tentativo di fuga o fucilato. Cesare Battisti, di Trento, giornalista, geografo, cittadino austriaco di nascita fu deputato socialista al parlamento di Vienna. Allo scoppio della guerra si arruolò con gli italiani, catturato fu processato e impiccato per alto tradimento. Nazario Sauro, di Capodistria, tenente di vascello della marina italiana, fu giustiziato per alto tradimento a Pola. Fabio Filzi, di Pisino, si unì volontario ai soldati italiani, fu fatto prigioniero insieme a Cesare Battisti di cui era subalterno, condannato a morte per tradimento la sentenza fu eseguita per impiccagione nel castello del Buon Consiglio di Trento.
Di ben maggiori dimensioni è il monumento a Enrico Toti che si trova in un angolo del giardino del Pincio, è opera di Arturo Dazzi[3], del 1921. Enrico Toti (Roma 1882- Monfalcone 1916) nato nel quartiere di San Giovanni da padre ferroviere e madre di Cassino. Arruolatosi nella marina militare, si congedò e fu assunto come ferroviere, nel 1908, mentre lavorava alla lubrificazione di una locomotiva nella stazione di Colleferro, scivolò e rimase incastrato sotto gli ingranaggi con la gamba sinistra che gli venne amputata. Perso il lavoro si dedicò alla realizzazione di piccole invenzioni che sono documentate nel museo dei bersaglieri di Roma. Nel 1911 pedalando in bici con una gamba sola raggiunse parigi, da lì il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Russia, la Polonia e rientrò in Italia. Nel 1913 raggiunse Alessandria d’Egitto e il confine con il Sudan dove le autorità ingesi gli imposero di concludere il viaggio. Allo scoppio della guerra mondiale Toti presentò tre domande per essere arruolato. Raggiunse in bicicletta il fronte a Cervignano del Friuli, qui fu accolto come civile volontario, riuscì a farsi trasferire presso i bersaglieri ciclisti del terzo battaglione, presso i quali iniziò a combattere. Il comandante maggiore Renzini gli consegnò le stellette e l’elmetto piumanto da bersagliere. Nell’agosto 1916 cominciò la sesta battaglia dell’Isonzo che si concluse con la presa di Gorizia il 6 agosto. Enrico Toti, lanciatosi con il suo reparto all’attacco di Quota 85 a est di Monfalcone, fu ferito più volte dai colpi avversari, prima di morire scagliò la cruccia verso il nemico esclamanto “Nun moro io”, “Io non muoio”. Nel 1922 la sua salma fu portata a Roma per ricevere solenni funerali. Nel clima incandescente che precedette la marcia su Roma, il feretro fu oggetto di colpi di arma da fuoco, ne seguirono scontri con un morto e 25 feriti, in zona San Lorenzo. E’ sepolto al Verano, in un riquadro rialzato a cinquanta metri dall’ingresso principale a sinistra.
Non passa inosservato il monumento all’umile eroe e all’alpino che si trova davanti alla Fortezzuola. E’ opera di Pietro Canonica, sul monumento è la scritta: "Ca custa lonca custa viva l'Austa" 1915-1918". In dialetto valdostano significa: “A qualunque costo: viva Aosta”, che è il motto del battaglione alpini di Aosta. Opera in bronzo del 1940 che riproduce Scudela = scodella, il mulo decorato con croce di guerra, nel 1957 fu aggiunto l'alpino anch’esso in bronzo. Il mulo porta l'affusto del 75. Scudela era il più resistente e coraggioso dei muli di una batteria di montagna durante la Grande Guerra. Ogni giorno, per anni, ha portato sulla groppa il suo cannoncino per gli aspri sentieri di montagna, sotto la neve e sotto il fuoco nemico, fedele compagno dell’alpino da cui era inseparabile e di cui sapeva comprendere al volo ogni gesto e parola. Una mattina, durante un durissimo scontro, la batteria fu costretta alla ritirata e Scudela con il suo alpino vennero dati per dispersi. Al calar della notte il mulo raggiunse i resti del reparto, ma senza il suo compagno, di cui restava solo il cappello con la penna nera.
La fortezzuola è sede del museo Canonica. La fortezzuola era, prima dei lavori del Settecento, la "casa del Gallinaro". Nel 1926 il Comune la concesse allo scultore Pietro Canonica perchè ne facesse la sua abitazione e il suo studio. Dopo la sua morte (1959) le opere rimaste nello studio andarono a costituire il museo aperto al pubblico nel 1961, in esso si mischiano oggetti personali dello scultore con ritratti di sovrani, capi di stato e personalità d'Europa e d'America. Fu infatti ritrattista della nobiltà e di numerose case regnanti europee.
PIAZZA SANT’AGOSTINO
Uno dei monumenti ai caduti dei rioni di Roma
più curati dal punto di vista artistico.
In questa piazza si trova uno dei più artistici monumenti ai caduti dei rioni di Roma. Guardando la facciata della chiesa è sulla destra, precede l’ingresso alla biblioteca Angelica. Presenta in alto una lastra, molto grande, con l’elenco dei caduti del rione. Essendo un elenco molto nutrito questo ci fa capire come questa zona fosse molto popolata negli anni di inizio Novecento. Al di sotto si trova un’altra lapide più piccola, quindi una sorta di sarcofago affiancato da due cesti di frutta.
MINISTERO DELLA MARINA MILITARE
Davanti all’ingresso le ancore di due
corazzate austriache affondate in guerra:
la Viribus Unitis e la Teghenthoff.
Sul lungotevere delle Navi, nel quartiere Flaminio si trova il MINISTERO DELLA MARINA MILITARE progettato da Giulio Magni (autore della cosiddetta cattedrale di Ostia, delle case popolari a Testaccio, a Santa Croce, molti villini al Salario) nel 1914 ma realizzato fra il 1924 e il 1928. E’ un edificio imponente ispirato allo stile barocco con torri angolari, corpi centrali avanzati, lunghe lesene, bugnato e finestre con timpano aggettante. Ha pianta trapezoidale, un cortile centrale più grande e altri più piccoli. Davanti all’ingresso principale si trovano le ancore delle corazzate austriache “Viribus Unitis” e “Teghetthoff” affondate dai mas italiani nella rada di Pola il 1° novembre 1918. Sul lato opposto del ministero, in piazza della Marina, un bel giardino all’italiana.
VILLA GLORI
Il parco delle Rimembranza creato per
ricordare i caduti della Prima Guerra Mondiale.
Il Comune di Roma, con delibera del 23 ottobre 1923, decise di trasformare l’area dove oggi è villa Glori, in Parco della Rimembranza dedicato ai caduti della Grande Guerra. Il progetto del nuovo parco fu affidato a Raffaele de Vico, architetto del Servizio Giardini, in soli otto mesi creò un giardino per passeggiate immerse nel verde mediterraneo di pini, lecci, querci, lauri, aceri, cedri, ippocastani ed ulivi, tutti puntigliosamente allineati a filari. Il parco fu inaugurato il 18 maggio 1924. Una grande croce e un enorme altare sono la memoria tangibile dei caduti in guerra.
Venne scelto questo luogo perché il 23 ottobre 1867 qui avvenne uno scontro tra le truppe pontificie e una settantina di patrioti al comando dei fratelli Cairoli. Tale azione doveva scatenare l’insurrezione della popolazione romana, cosa che avvenne ma in misura minore, ma soprattutto doveva anticipare e giustificare l’intervento di volontare guidati da Garibaldi. Purtroppo i patrioti venne sopraffatti dalle truppe pontificie e uccisi, sulla sommità dell’altura si trova ancora un ramo secco di mandorlo dove morì Enrico Cairoli, mentre il fratello Giovanni, gravemente ferito, morì poco dopo. I superstiti raggiunsero Mentana dove combatterono con Garibaldi. In quegli anni vi era una vigna proprietà di un tale Vincenzo Glori, in essa anche un casale poi riadattato ad uso agricolo.
L’idea di farne un parco pubblico era già prevista dal piano regolatore del 1883, si iniziò con gli espropri e nel 1895 fu inaugurata una colonna in marmo di Pietrasanta a ricordo dei patrioti del 1867. Nel 1924 il parco venne inaugurato. Nel 1929 fu avviata la costruzione di tre padiglioni in legno destinati ad ospitare una colonia estiva per i bambini dalla salute precaria, il Dispensario Marchiafava. Dal 1988 tali padiglioni sono stati affidati alla Caritas che ne hanno fatto una casa famiglia per malati di Aids. Nel 1997, sindaco Francesco Rutelli, su idea della critica d’arte Daniela Fonti, il Comune di Roma ha promosso la costituzione di un parco di scultura contemporanea all’aperto intitolata Varcare la soglia che voleva esprire la possibilità di integrazione tra luogo di sofferenza e luogo di svago. Sono state così installate opere di Dompè “Meditazione”, Mattiacci “Ordine”, Mochetti “Arco-laser”, Caruso “Portale mediterraneo”, Castagna “Monadi”, Kounellis “Installazione”, Nunzio “Linea”, Staccioli “Installazione”. Nel 2000 si sono aggiunti “La porta del Sole” di Giuseppe Uncini e “Uomo erba” di Paolo Canevari. Nel 2003, alle spalle del mandorlo di Enrico Cairoli, è stata collocata una piccola lapide dedicata ai carabinieri morti a Nassiryia, in Iraq.
PALAZZO BRASCHI
In questi giorni una mostra fotografica
ripercorre gli anni di guerra vissuti dalla popolazione civile romana.
Dal 29 ottobre al 30 aprile 2015 è in corso la mostra “Roma e la grande guerra, la capitale d’Italia in 35 immagini”. La sala della Fotografia al secondo piano del Museo di Roma, appositamente riallestita in occasione del centenario dell’ingresso in guerra dell’Italia, ospita 35 immagini provenienti dai fondi dell’Archivio Fotografico del Museo stesso che illustrano come Roma, anche se lontana dal teatro degli scontri, affrontò da protagonista quegli anni.
Si possono vedere la serie di fotografie, attribuite a Giuseppe Primoli, riferita all’incontro tra Guglielmo II e Leone XIII in Vaticano o altre, attribuite a Carlo Tenerani, del passaggio del corteo in via Nazionale in occasione della visita a Roma di Edoardo VII d’Inghilterra. Alcune immagini della Fotografia Molitari registrano l’arrivo di Gabriele D’annunzio a Roma e l’attesa per il suo discorso in Campidoglio nel maggio 1915 in favore dell’entrata in guerra dell’Italia. Altre immagini documentano le manifestazioni interventiste in piazza di Spagna e piazza del Quirinale. Nella vetrina al centro della sala vi sono alcune rare foto dal fronte alpino di tre reduci romani: i fratelli Emilio e Mario Giglioli, militari di carriera e l’archeologo Giulio Quirino Giglioli, volontario. Particolarmente suggestiva la foto che ricorda l’esplosione della cima del Col di Lana, minata dagli italiani nell’aprile 1916.
Al termine della mostra le immagini della tumulazione del Milite Ignoto il 4 novembre 1921, in una foto il re, Ivanoe Bonomi e il duca d’Aosta eroe della guerra.
PIAZZA RISORGIMENTO
MUSEO STORICO DEI CARABINIERI
Nel museo viene ricostruita la storia del corpo
e il suo contributo durante il primo conflitto mondiale
con molti cimeli.
Nel corso della Prima Guerra Mondiale i carabinieri si distinsero nelle battaglie dell’Isonzo, del Carso, del Piave, sul Sabotino e San Michele, in particolare sulle pendici del Podgora. I carabinieri furono i primi ad entrare a Gorizia il 9 agosto 1916. Il 2 novembre 1918 circa 200 militari del Battaglione Carabinieri Mobilitato presso il Comando Supremo, furono i primi a sbarcare a Trieste liberata. Il loro comandante Umberto Russo fu il primo a toccare il suolo di Trieste. Durante il conflitto caddero 1.400 carabinieri, 5.000 furono feriti. Ai reparti e singoli militari furono conferiti una Croce all’Ordine Militare di Savoia, 4 medaglie d’Oro, 304 d’Argento, 831 di bronzo, 801 Croci di Guerra e 200 Encomi solenni, tutti al valor militare.
Tutto ciò è documentato nel museo che esiste dal 3 dicembre 1925, allora disponeva di sole sei sale, dal 1937 si estende su tutta la palazzina di fine Ottocento che è stata ristruttura e decorata per il nuovo ufficio dall’arch. Scipione Tadolini. Nel 1985 il museo è stato ristrutturato e ammodernato, alla sua inaugurazione è intervenuto il ministro della difesa Spadolini.
LUNGOTEVERE CASTELLO
CASA MADRE DEI MUTILATI E DELLE VEDOVE DI GUERRA
I romani lo chiamano il “Pentagono”, perché ha una pianta pentagonale con cortile interno. Costruito tra il 1925 e il 1937 su progetto di Marcello Piacentini, presenta al suo interno un ciclo di affreschi che esaltano i vari corpi dell’esercito nella prima guerra mondiale.
Nella sala Pietro Ricci si trovano medaglioni con teste di uomini illustri: Francesco Rismondo, Guglielmo Oberdan, Nazario Sauro, Cesare Battisti, Fabio Filzi, Damiano Chiesa, sono opere di Ettore Colla in collaborazione con Federico Papi. La decorazione parietale realizzata su cartoni è di Edoardo Del Neri.
Sulla facciata esterna il motivo di teste di fanti con l’elmo è di Giovanni Prini, la facciata esterna lato nord con Due angeli che porano la bandiera è sempre di Giovanni Prini.
Nel cortile delle Vittorie l’Aquila è di Ettore Colla, nel lato est le Battaglie combattute dai soldati italini sono di Cirpiano Efisio Oppo (1936-37), quelle del lato ovest sono di Antonio Giuseppe Santagata, la Vittoria è di Guido Galletti. Nel vestibolo est le erme di giulio Giordani e Fulcieri Paulucci de Calboli sono di Adolfo Wildt.
Nel sacrario delle Bandiere si trova l’affresco del Duce con Vittorio Emanuele II a cavallo, opera di Mario Sironi del 1938.
APPENDICE
L’ARTE NELLA GRANDE GUERRA
Agli inizi del Novecento il panorama artistico europeo e nordamericano è sconvolto da una serie di movimenti artistici d’avanguardia che cambiano completamente il modo di esprimersi degli artisti, le tecniche usate e il ruolo stesso dell’artista nella società. Si tratta di movimenti di rottura, che si rifiutano di operare come tutte le generazioni precedenti.
In Italia il movimento artistico d’avanguardia prese il nome di Futurismo. Nel 1909 viene pubblicato il manifesto del Futurismo che interessa la letteratura, il teatro e il cinema, seguito nel 1910 dal manifesto della pittura futurista e nel 1912 da quello dell’architettura. Il sogno del futurista è quello di distruggere tutto il passato, solo il futuro può esistere e ad esso bisgona tendere, rinnovandosi continuamente, abbandonando le regole imposte dalla tradizione. Le immagini non possono che essere nuove in un mondo sempre più rinnovato dalle macchine. La rappresentazione del movimento è dunque alla base della pittura e scultura metafisica. I principali esponente del futurismo furono Giacomo Balla e Umberto Boccioni (che morirà nel corso della prima guerra mondiale). Ma furono elementi di spicco anche Carlo Carrà, Gino Severini, Luigi Russolo.
Molti di questi artisti videro nella guerra “l’igiene del mondo”, l’evento che poteva cambiare la storia del paese e dargli il posto di rilievo che meritava. Furono quindi interventisti. Basta andare alla Gnam dove si possono vedere i quadri di Giacomo Balla che parlano delle manifestazioni in favore dell’entrata in guerra dell’Italia, le manifestazioni di cui abbiamo riferito a piazza Esquilino, Campidoglio e Quirinale. Un quadro per tutti: “Forme grido Viva l’Italia” di Giacomo Balla del 1915. Molti di questi nel primo dopoguerra aderirono al fascismo (Balla realizzò un quadro sulla Marcia su Roma ispirato chiaramante al Quarto Stato di Pellizza da Volpedo), anche se il regime li tenne sempre ai margini come è nel caso di Filippo Tommaso Marinetti. Marinetti venne arrestato dopo l’attentato di Sarajevo per aver bruciato bandiere austriache in piazza Duomo a Milano, appena l’Italia entrò in guerra partì volontario.
I comandi militari avevano al proprio servizio pittori e disegnatori, oltre che fotografi; tutti costoro si recarono sui luoghi di battaglia e riportarono veri e propri documenti artistici e storici dei fatti che via via accadevano. Tra tutti costoro un nome importante è quello di Giulio Aristide Sartorio. Partito come volontario, viene ferito e fatto prigioniero. Liberato torna al fronte illustrando 27 episodi bellici ora alla Galleria d’Arte Moderna di Milano. Un posto a sé meritano i dipinti di guerra del pittore-soldato Italico Brass, inviato in zona di guerra per ritrarre gli aspetti più emozionanti e significativi del conflitto in corso.
Un altro artista importante morto nella guerra fu Antonio di Sant’Elia, architetto esponente del futurismo. I suoi disegni rappresentano edifici nei quali immaginava città composte di più edifici multilivello che si potevano connettere tra di loro. Si guadagnò una medaglia d’argento sul Monte Zebio, mentre guidava un assalto alla trincea nemica morì a quota 85 presso Monfalcone (10 ottobre 1916). Nello stesso luogo, il 6 agosto, era morto Enrico Toti.
Si schierarono contro la guerra Gaetano Previati, Ardengo Soffici e Plinio Nomellini.
UN DIARIO DI GUERRA
Sul finire del 2013 l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano[4] e il Gruppo L’Espresso hanno dato il via al progetto “La Grande Guerra, i diari raccontano”.
In esso alcune tra le più belle pagine autobiografiche di persone che hanno vissuto la guerra sono state raccolte, si sono ottenuti così 1.000 brani selezionati di 150 autori diversi. Si tratta di un campione emblematico dell’intero paese: diari, memorie ed epistolari provengono da tutte le regioni italiane, da tutti i ceti sociali, da tutti i gradi gerarchici dell’esercito, da tutti i fronti sui quali l’Italia ha combattuto: dal Carso, all’Isonzo, alla Macedonia, all’Albania, agli italiani nei territori soggetti all’Austria (terre irredente) schierati sul fronte Orientale, fino alla Legione Redenta schierata in Siberia.
Un gruppo di ricerca ha individuato un elenco di temi che hanno connotato la vita di militari e civili: la condizione di vita di militari nelle trinceee (la fame, il freddo), gli aspetti della sfera emotiva (paura, odio), gli aspetti dei combattimenti veri e propri. Ne risultano così alcune parole chiavi per estrapolare dai diari dei brani lunghi all’incirca un articolo di giornale, ognuno con un titolo e un sottotitolo come proprio negli articoli dei giornali. Infine i brani scelti sono stati arricchiti di fotografie in gran parte inedite.
Il tutto è visibile sul sito espressonline.it/grandeguerra/.
Dal diario di Pietro Tucci (Laterza TA 1879 – Roma 1965), coltivatore diretto del sud d’Italia, combattente della prima guerra mondiale sul Piave insieme ad altri sei fratelli maschi, trasferitosi a Roma nel 1939. Nel suo diario inedito racconta che “durante la notte avvenivano i trasferimenti della truppa. Una notte mi spostavo con il mio reparto nelle trincee, mentre un altro reparto camminava in senso opposto, si vennero così a formare due lunghe file di uomini che camminavano nelle opposte direzioni. Ad un tratto un ordine: - Alt! Uguale ordine ricevette la fila opposta: - Alt! Venni così ad urtare il commilitone della fila che procedeva in direzione opposta alla mia. In quel momento mi accorsi che quel soldato era mio fratello Ciccillo. Subito ci abbracciammo, il tempo di scambiare due parole: - Come stai? Che notizie hai della famiglia? Nuovamente venne dato l’ordine: - Avanti! E ancora per l’altra colonna: - Avanti! Ci salutammo, un altro abbraccio… ognuno per la sua strada. Ci saremmo rivisti?”. Tutti e sette i fratelli Tucci tornarono dalla guerra, sani e salvi.
“Durante i periodi di pausa dei combattimenti, che a volte duravano giorni interi, i soldati italiani venivano a contatto con gli austriaci. Loro offrivano alcolici e ci chiedevano il pane, così avvenivano degli scambi”.
Durante una licenza, che veniva data anche per assolvere ai lavori nei campi: “La corriera che mi portava nella piazza del paese passa sotto casa mia. Riconosco mia moglie con in braccio un piccolino di meno di un anno. Tra me e me penso:- Chi sarà quel bambino? Un attimo dopo: - Ma certo, quello è mio figlio, nato mentre io ero al fronte”. Si trattava del figlio Nicola nato il 29 luglio 1917.
IL CICLISMO DURANTE LA GRANDE GUERRA
Il 1914 è l’ultimo anno di gare prima della Grande Guerra. Il Giro di quell’anno è una delle massime espressioni del ciclismo epico e torturatore. Otto tappe di quasi 400 Km di media, già la prima Milano-Cuneo presenta la neve sul Sestriere, nella seconda una mareggiata in Liguria, nella terza Lucca-Roma di 430 Km fuga inutile di Lauro Bordin di 350 Km. Alla fine vince Calzolari con quasi due ore di vantaggio sul secondo Albini. Soltanto otto corridori concludono la gara. Per la prima volta la classifica è stata a tempi.
Al Tour si segnala il toscano Pratesi, quarto tra gli isolati. Il Tour è vinto dal belga Thys. Girardengo vince il campionato italiano e la Milano-Torino. La Sanremo è vinta da Ugo Agostoni, atleta che morirà prematuramente. In suo onore si corre la Coppa Agostoni nel mese di agosto, con arrivo a Lissone in Brianza.
Lo svizzero Egg si riprende (lo aveva superato Berthet) il record dell’ora con 44,247 a Parigi Bufalo, il primato verrà battuto solo nel 1933 da Richard.
BIBLIOGRAFIA
- AA.VV. Guida d’Italia, Roma, ed. Tci, 1993.
- AA.VV. Roma, libri per viaggiare, ed. Gallimard – Tci, 1994.
- AA.VV. I rioni e i quartieri di Roma, ed. Newton & Compton, 1989.
- AA.VV. Le strade di Roma, ed. Newton & Compton, 1990.
- Claudio Rendina (a cura di), Enciclopedia di Roma, ed. Newton & Compton, 2005.
- Sabrina Ramacci, 1001 cose da vedere a Roma almeno una volta nella vita, ed. Newton Compton, 09.
- Giorgio Spini, Disegno storico della civiltà, ed. Cremonese, 1963.
- Sandro Picchi, Mario Fossati, Alfredo Martini, Gian Paolo Ormezzano, La storia illustrata del Ciclismo, ed. La Casa dello Sport, 1987.
- Talamo e altri, Museo Centrale del Risorgimento, ed. Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 2001.
- Sergio Lambiase – Luisella Bolla, Storia Fotografica di Roma, vol. I e II, ed. Intra Moenia, 2002.
- Cinzia Caiazzo e altri, La Grande Storia del Novecento, Mondadori, 2006.
- Eva Paola Amendola, Storia fotografica del Partito Comunista Italiano, ed. Riuniti, 1981.
SITOGRAFIA
- Racconta.gelocal.it, per i diari di guerra.
- Marina.difesa.it, per il sacrario delle bandiere al Vittoriano.
- Monumentigrandeguerra.it per monumento al ferroviere.
- Esercitodifesa.it per i musei dei bersaglieri, fanteria e carabinieri di Roma.
- Sovraintendenzaroma.it per villa glori.
- Museodiroma.it per palazzo braschi.
- Anaroma.it per monumento all’alpino.
- Museocanonica.it per monumento all’alpino.
Tucci Piero
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
inbiciperoma.blogspot.com
[1] Maria Bergamas di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) 1867 – Aquileia 1952).
[2] Amleto Cataldi (Napoli 1882 – Roma 1930) frequentò l’Accademia di Roma dove conobbe Boccioni. Suo il monumento alla Guardia di Finanza in viale XXI Aprile, una delle Vittorie alate sul ponte Vittorio Emanuele, la statua di Leonardo da Vinci a Amboise, gruppi bronzei per lo Stadio Nazionale. Alla Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale in via Crispi si trova la statua Portatrice d’acqua del 1916. Omonima statua, ma di grandi dimensioni alla Gnam nel Caffè delle Arti.
[3] Arturo Dazzi. (Carrara 1881 - Pisa 1966) scultore di Carrara, suo l'Arco della Vittoria di Genova, fu anche pittore. Alla Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale si trova la sua scultura "Antonella". Alla Gnam "I costruttori" del 1907, una delle su prime opere. Suo l'obelisco (o stele) dell'EUR con i rilievi dedicati a Marconi. Il cinema Corso, ora spazio Etoile aveva una cupola apribile da lui decorata. Sue opere nella chiesa di Don Bosco a Roma. Realizzò un colosso marmoreo in piazza della Vittoria a Brescia, simbolo del fascismo, rimosso dopo la liberazione e ora nei depositi comunali.
[4] Pieve Santo Stefano comune in provincia di Arezzo di 3.200 ab. Vi è nato Amintore Fanfani.
[1] Ripercussioni economico sociali della Grande Guerra. La parte tra virgolette è presa da: Giorgio Spini, Disegno Storico della Civiltà, ed. Cremonese, vol.III, pag. 335/336, 1963.
INTRODUZIONE
L’Associazione sportiva Roma, o più semplicemente “la Roma”, è una società calcistica fondata nel 1927 che milita nella massima divisone del campionato di calcio, è una delle tre società di calcio quotate in borsa insieme a Juventus e Lazio.
Il suo stemma è giallo-rosso con la lupa capitolina al centro e la scritta 1927; la divisa per le partite giocate in casa è: maglia rossa con risvolti delle mezze maniche gialle, stemma in alto a sinistra, pantaloncini bianchi; la divisa per le partite fuori casa è maglia bianca con striscia diagonale giallo-rossa e stemma in alto a sinistra, pantaloncini bianchi. Il suo inno è “Roma, Roma” di Antonello Venditti.
Nella sua storia ha vinto 3 scudetti, 9 coppe Italia (primato condiviso con la Juventus fino a quest’anno quando la Juventus ha conquistato la decima Coppa battendo la Lazio all’Olimpico) e 2 Supercoppe italiane. In ambito europeo il miglior risultato è stato la finale di Coppa dei Campioni persa contro il Liverpool nel 1984 e una Coppa Uefa persa nel 1991 contro l’Inter.
Oggi il presidente è James Pallotta, l’allenatore è Rudi Garcia, gioca allo stadio Olimpico di Roma che può accogliere 70.634 spettatori.
Vip tifosi della Roma sono: Antonello Venditti, Massimo Wertmuller, Massimo Ghini, Matilde Brandi, Sabrina Ferilli, Pierfrancesco Favino, Alberto Sordi, Claudio Baglioni, Renato Zero, Francesco De Gregori, Alessandro Gassman, Claudio Amendola, Carlo Verdone, Lino Banfi, Gigi Proietti, Nino Manfredi, Luca Zingaretti, Manuela Arcuri, Giulio Andreotti, Fiorella Mannoia, Claudia Gerini, Maurizio Costanzo, Lando Fiorini, Renato Rascel, Anna Magnani, Totò, Riccardo Scamarcio, Ascanio Celestini, Claudio Amendola, Cristina Capotondi, Little Toni, Monica Bellucci, Massimo D’Alema.
STORIA DELLA ROMA
GLI INIZI
Alla fine degli anni Venti del Novecento si sente forte l’esigenza di creare a Roma una squadra di calcio competitiva per la creazione di un campionato a girone unico. Alba Roma, Fortitudo e Roman trovano quindi un accordo per fondersi in una sola società. Questi tre club erano riusciti a conquistare 7 dei 10 campionati laziali ma, nella finalissima, erano sempre state sconfitte da squadre del Nord Italia. Il massimo campionato era allora articolato su gironi a carattere regionale.
Il 22 luglio 1927, in via Uffici del Vicario 35, dalla fusione delle tre squadre nasce la Roma. Promotori di questa nascita sono Italo Foschi, segretario romano del Pnf, membro del Coni e dirigente della Fortitudo, e l’on. Ulisse Igliori, membro del direttorio nazionale del Pnf. Non esiste un vero e proprio atto fondativo, ma il 22 luglio viene redatto il primo ordine del giorno. Pochi giorni prima, il 16, i futuri calciatori giallorossi giocarono una partita con gli ungheresi del Ujpest al Motovelodromo Appio, vincono i giallorossi per 2 a 1, primo goal giallorosso segnato da Cappa. Il campionato inizia il 25 settembre e sorprendentemente le due squadre di Roma sono in due gironi diversi. Solo due anni più tardi, con l’avvento del girone unico, inizierà la rivalità Roma/Lazio.
La Roma è presieduta da Italo Foschi, quindi da Renato Sacerdoti, già presidente del Roman, ma nel 1935 viene allontanato per le sue origini ebraiche. Fin dai primi campionati la squadra occupa la parte alta della classifica e raggiunge la finale di Coppa Italia nel 1936/37. E’ questo il periodo del mitico campo di Testaccio, lo storico campo della Roma dove venne giocata la famosa partita Roma-Juventus finita 5 a 0 per i romanisti. Nel 1941-42 la Roma conquista il suo primo scudetto vincendo per due a zero l’ultima partita di campionato con il Modena.
DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI SESSANTA
Gli anni Quaranta vedono alcune stagioni travagliate finchè nel campionato 1950-51 la squadra perde dieci partite e cambia tre allenatori, così il 17 giugno 1951 viene retrocessa in serie B. Nel 1952 Sacerdoti viene richiamato alla presidenza della società e la squadra è affidata a Gipo Viani il quale subito ottine la promozione in serie A.
Negli anni Cinquanta la Roma ottiene buone prestazioni come il terzo posto nel campionato 1954-55 che riporta la squadra in Europa, in media si piazza al sesto posto in classifica.
Negli anni Sessanta la squadra ottiene notevoli affermazioni, nella stagione 1960-61 vince la Coppa delle Fiere imponendo in finale con il Birminghan City, conquista due Coppe Italia nel 1963-64 contro il Torino e nel 1968-69 contro il Cagliari. A contraltare di ciò la società attraversa una notevole crisi finanziaria per cui nel 1964 non viene pagato lo stipendio ai giocatori. Nel 1967 il presidente Franco Evangelisti completa il piano di risanamento economico della società e la trasforma in società per azioni.
Gli anni Settanta sono tra i peggiori della storia della Roma, al capitano Giacomo Losi non viene rinnovato il contratto, il presidente Marchini cede alla Juventus i tre gioielli: Luciano Spinosi, Fabio Capello e Fausto Landini. La squadra conclude i campionati nelle posizioni di media classifica ad eccezione del campionato 1974/75 quando arriva terza e 1978/79 quando ottine la salvezza dalla retrocessione in serie B solo alla penultima giornata.
A fine decennio la società viene rilevata da Dino Viola che affida la guida tecnica a Nils Liedholm, subito arrivano ottimi risultati, si vincono due Coppe Italia consecutive, in entrambi i casi si supera il Torino ai rigori, l’8 maggio 1983 allo stadio Luigi Ferraris di Genova nel quartiere Marassi, dopo un pareggio con il Genoa, la Roma vince il secondo scudetto della sua storia. Nel 1984 la Roma vince la sua quinta Coppa Italia e giunge in finale di Coppa dei Campioni che allora si gioca all’Olimpico contro il Liverpool. La partita si chiude sull’ 1-1, ai calci di rigore perde a causa degli errori di Bruno Conti e Francesco Graziani. Nella stagione 1985/86 la panchina della Roma viene assegnata a Sven-Goran Eriksson che conquista la sesta Coppa Italia e arriva seconda in campionato, dopo la Juventus.
Alla fine degli anni Ottanta e negli anni Novanta la squadra perde la capacità di porsi tra le prime squadre nazionali ma raggiunge un’altra finale di Coppa Uefa perdendo il titolo, questa volta, contro l’Inter. Nel 1993 la società viene acquistata da Franco Sensi, si alternano quattro allenatori non riuscendo ad ottenere risultati di rilievo. Il 28 marzo 1993 avviene l’esordio in serie A di Francesco Totti sedicenne, giocherà titolare dal 16 dicembre di quell’anno grazie alla stima di Vujadin Boskov. Dal 1998 Totti avrà la fascia di capitano
Nell’estate 1999 la dirigenza affida la panchina a Fabio Capello, viene fatta una campagna acquisti molto dispendiosa grazie a nuovi capitali derivati dall’ingresso della società in borsa, finalmente arriva il terzo scudetto (2000/2001 grazie al trio Batistuta, Montella e Totti) e della Supercoppa italiana (2001/2002).
Negli anni 2000 la Roma giunge sei volte seconda in campionato sotto la guida di Luciano Spalletti, due Coppe Italia consecutive e una Supercoppa italiana. Alla fine della stagione 2010-11 la società viene ceduta a un gruppo di imprenditori statunitensi guidato da Thomas Di Benedetto, subito dopo da James Pallotta. Nella stagione 2013-14 la Roma conquista il secondo posto in campionato dopo la Juventus. Attualmente (23.5.15) la Roma è seconda in classifica con 67 punti inseguita dalla Lazio, terza, con 66, mentre la Juventus, prima ha 83 punti.
LE SEDI DELL’AS ROMA
Via Uffici del Vicario, 35
Via Ripetta
Via Monterone, 2
Via del Tritone, 125
Via del Quirinale, 31
Viale Tiziano 3/5
Via Lucrezio Caro, 67
Via del Circo Massimo, 7
Via di Trigoria Km 3,6
ITINERARIO
VIA UFFICI DEL VICARIO 35
Qui il 22 luglio 1927, in un caldo pomeriggio estivo, venne fondata l’A.S. Roma, padroni di casa si fratelli Giorgio e Piero Crostarosa. Si brinda con lo spumante. Nasce dalla fusione di alcuni tra i maggiori club romani: Alba (giocava al quartiere Flaminio, di Ulisse Iglori), Fortitudo (giocava alla Madonna del Riposo, di Italo Foschi stesso) e Roman (Parioli di Vittorio Scialoja, senatore e ministro degli Esteri). Italo Foschi[1] sarà il primo presidente giallorosso. Eredita i giocatori migliori delle tre squadre, fra questi Attilio Ferraris[2] che sarà campione del mondo nel 1934. Il 23 luglio il Messaggero dà notizia ai lettori della nascita della nuova società affermando che “dovrà dare al calcio romano un nuovo assetto ed una nuova forza vivificatrice… la fusione delle tre squadre è quanto di più desiderabile nell’interesse dello sport romano, potevano augurarsi le folle sportive”.
Bisogna fare un passo indietro, a Roma esisteva dal 1900 la Lazio, nata quale società podistica, e tante altre piccole squadre, si ricordano: la Football Club Roma dal 1901, la Roman dal 1903, l’Alba dal 1907, la Fortitudo dal 1908 ed altre ancora.
Siamo vicinissimi a Montecitorio. Ci troviamo nel rione Colonna, anche se il primo isolato della strada, vicino a piazza di Campo Marzio appartiene al rione Campo Marzio. Il nome della strada ricorda gli uffici notarili di Curia che un tempo avevano sede qui prima di essere strasferita a via della Pigna. La via si chiamò anche dei Notari. Al n. 17 è la Casa della Missione, ora della Camera dei Deputati, costruita nel 1642 dalla duchessa d’Aiguillon per ospitarvi la congregazione dei Padri della Missione. Al n. 40 si trova il palazzo Cecchini-Lavaggi-Guglielmi, ricostruito nelle forme attuali nel 1830 da Antonio Sarti, sul cornicione gli stemmi dei Cecchini (l’edificio si affaccia anche su via della Maddalena e via della Guardiola).
MOTOVELODROMO APPIO
Si trovava nel quartiere Tuscolano, dove oggi è piazzale dei Castelli Romani, tra largo dei Colli Albani e l’attuale chiesa di San Gaspare del Bufalo, era in aperta campagna, le ultime case della città erano all’Alberone. Qui la Roma giocò nella stagione 1927/28 e 1928/29.
Costruito nel 1911 per il 50° dell’unità d’Italia, in sostituzione di un’analoga struttura nei prati di Tor di Quinto, ospitava gare ciclistiche su pista e l’arrivo di gare su strada. Aveva un tribuna coperta con sotto gli spogliatoi e gradinate che potevano ospitare forse 3 – 4.000 persone. Al centro vi era un campo di calcio, intorno la pista con curve molto ripide, “sembrava una ciotola lasciata sul prato”. Vicino vi era l’osteria di Scarpone con un campo di fave. I giovani venivano a sostenere gli atleti di Roma, i ciclisti Lazzaretti e Frascarelli. Gli anziani ricordano ancora quando nel dopoguerra arrivò Fausto Coppi, tale fu la ressa che il campionissimo dovette rifugiarsi nella salsamenteria Fiorucci posta all’angolo tra via Appia e via Santa Maria Ausiliatrice detta il “bottegone”. Sul campo di calcio negli anni ’20 si allenava la squadra di calcio Roma, poi andava a giocare le partite di campionato a Testaccio. Si allenarono qui anche squadre minori: la Stefer, la Mater (allenata da Fulvio Bernardini[3], giunse alla serie B nazionale), la Chinotto Neri. Prima delle Olimpiadi del 1960 la struttura fu abbattuta.
La chiesa è stata consacrata il 24 ottobre 1981 dal cardinale Poletti, la parrocchia esiste dal 1956. Il progetto è dell’arch. Pier Luigi Nervi. L’edificio è una costruzione ardita, ha la base circolare e si sviluppa in altezza quasi fosse una tenda. La copertura è eseguita con speciali guaine protettive, con pannelli di coibentazione e una copertura in rame pesante. Il campanile è staccato dal corpo principale e realizzato da sette pilastri in cemento armato che sorreggono le campane. Come ricorda una lapide all’interno la chiesa fu visitata da Giovanni Paolo II alcuni mesi dopo l’attentato che lo vide coinvolto in piazza San Pietro. L’interno si presenta con un piano di calpestio in leggera discesa verso l’altare e i banchi disposti a semicerchio. Fa da sfondo all’altare una grande struttura in ceramica, in essa è riprodotta l’immagine di San Gaspare del Bufalo, vi è inserito il tabernacolo. Di notevole è la Via Crucis opera bronzea del sacerdote francescano Andrea Martini le cui scene si susseguono senza interruzione lungo le pareti, i bozzetti in vetroresina sono nella chiesa di san Frumenzio ai Prati Fiscali. Secondo una fonte la via Crucis è in stile “maconde” proveniente dalla Tanzania.
“Si racconta che quando proposero all’architetto Nervi di pensare al progetto, questi prese un fazzoletto al centro, lo sollevò con due dita per una decina di centimetri e ne scaturì una specie di tenda: su questa concezione biblica lo studio avviò il progetto”.
San Gaspare del Bufalo (Roma 1786-1837) è stato un sacerdote italiano fondatore della congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, beatificato da Pio X nel 1904 e proclamato santo da Pio XII nel 1954. E’ sepolto nella chiesa di Santa Maria in Trivio presso la fontana di Trevi, la ricorrenza è il 28 dicembre. E’ ricordato come il predicatore dei briganti che cercò di convertire, operò nelle zone di confine tra Lazio e Campania. Si incontro con il brigante Antonio Gasbarrone di Sonnino che convinse a costituirsi.
STADIO DELLA RONDINELLA
Lo stadio della Rondinella, utilizzato dalla Lazio fin dal 1914, venne utilizzato anche dalla Roma per soli due incontri in attesa del trasferimento allo stadio Testaccio.
Lo stadio della Rondinella si trovava tra l’attuale stadio Flaminio e il Palazzetto dello Sport, venne costruito nel 1914, ricostruito nel 1924 e dotato di tribuna coperta in legno, spogliatoi, docce, abitazione del custode, spalti su tre lati, con una capienza di 15.000 spettatori. In attesa del trasferimento al campo Testaccio l’impianto ospita anche le partite della Roma, tra queste lo storico 9-0 contro la Cremonese vittoria casalinga con maggior reti di scarto nella storia del club giallorosso. Nel 1957 viene distrutto da un incendio, ciò che rimane viene abbattuto e trasformato in parcheggio.
CAMPO TESTACCIO
Questo è il campo storico nel quale la Roma giocò dal 3 novembre 1929 al 30 giugno 1940. Si trova lungo via Nicola Zabaglia presso la biblioteca Enzo Tortora del Comune di Roma (al civico 27). Venne costruito nel 1929 e prende il nome dal rione nel quale sorge, qui la Roma giocò 161 partite con 103 vittorie, 32 pareggi e 26 sconfitte.
L’impianto fu progettato dall’ingegner Silvio Sensi, padre di Franco (presidente del terzo scudetto della Roma), aveva quattro tribune in legno verniciate con i colori della squadra, aveva una capienza di 20.000 spettatori. L’impianto comprendeva l’abitazione dell’allenatore sul muro era dipinto un gigantesco stemma della squadra. Per vedere una partita si pagava dalle 30 alle 35 lire in tribuna coperta e via via a scalare fino ai popolari dove si pagava 5 o 6 lire, 50% di sconto alle donne. Era frequente vedere gruppi di spettatori sul Monte dei Cocci per vedere la partita dall’esterno senza pagare il biglietto. Lo stadio è rimasto nella memoria dei tifosi romanisti per la partita contro la Juventus del 15 marzo 1931 nella quale i romani vinsero 5-0, da qui è stato tratto anche un film “Cinque a zero”. Dopo la stagione 1939-40 lo stadio venne abbandonato perché la tribuna dei distinti cominciava a dare segni di cedimento, venne sostituita da una in cemento (i cui lavori durarono quasi un anno), ma nonostante ciò fu abbattuto il 21 ottobre 1940.
Il 27 novembre del 2000, alla presenza del sindaco Rutelli, del presidente Franco Sensi e di molti campioni del passato lo stadio è stato riedificato, di dimensioni ridotte ma dotato di un centro sportivo multifunzionale. I lavori di un parcheggio sotterraneo hanno comportato un decadimento della struttura, il problema a tutt’oggi non è risolto.
STADIO NAZIONALE
Qui la Roma gioca dal 1940/41, in quell’anno vinse il suo primo scudetto, fino al 1953.
Lo stadio nazionale venne costruito nel 1911, ristrutturato nel 1927 e ribattezzato Stadio del Partito Nazionale Fascista, dopo la guerra riprese il nome originario, dopo il disastro di Superga fu chiamato Stadio Torino, nel 1953 fu dismesso, nel 1957 demolito. Al suo posto venne costruito l’attuale Stadio Flaminio in previsione delle Olimpiadi di Roma del 1960.
Il progetto dello stadio si deve a Marcello Piacentini, sorse presso villa Flaminia, i campi ippici di villa Glori e ai monti Parioli. Piacentini richiamò i tratti classici dei modelli ellenici, aveva la forma di una U allungata, l’ingresso era formato da due enormi corpi laterali che reggevvano colossali statue sedute della Forza e della Civiltà, internamente si trovavano quattro colonne onorarie congiunte da nastri e festoni di bronzo e sovrastate da statue in bronzo. Misurava 220 metri di lunghezza e 120 di larghezza, era affiancato da due lunghe gradinate raccordate da un lato a semicerchio, un altro lato era aperto per il pubblico. All’interno si trovavano piste podistiche e ciclistiche, dentro numerosi locali su due piani per l’Istituto Nazionale di Educazione Fisica, palestre, bagni, refettori, uffici e dormitori per atleti. Non fu mai utilizzato per incontri di calcio. Fu abbandonato durante la Grande Guerra.
Lo stadio fu ristrutturato nel 1927 prendendo il nome di Stadio del Partito Nazionale Fascista, la tribuna centrale fu dotata di una tettoia a struttura in cemento armato per 7.000 posti. Sul lato di ingresso venne inserita una piscina all’aperto lunga 50 metri e larga 18, dotata di spalti. Internamente vi trovarono posto una vasca coperta, palestre, alloggi, uffici della direzione generale del Coni. Al centro venne realizzato un campo di calcio, la pista podistica venne trasformata in anulare. L’ingresso fu sostituito da una facciata classicheggiante con semicolonne e quattro sculture di Amleto Cataldi, oggi nei giardini del Villaggio Olimpico. Venne inaugurato ufficialmente il 25 marzo 1928 con una amichevole Italia – Ungheria, terminata 4-3. Il 24 maggio 1931 si ebbe la prima partita della Lazio, un derby finito in parità, seguito da una rissa che fu punita con la squalifica del campo di entrambe le squadre. Per i mondiali del 1934 venne eliminata la piscina e ampliato nella capienza. Dal 1940 anche la Roma iniziò a utilizzare questo stadio. Durante l’ultima guerra fu requisito dalle truppe alleate, Roma e Lazio usarono il Motovelodromo Appio e lo stadio della Rondinella. Nel 1953 lo stadio fu abbandonato da Roma e Lazio che preferirono il nuovo stadio Olimpico.
STADIO OLIMPICO
Qui la Roma e la Lazio vi giocano dal 1953/54 e tutt’ora. Si trova nel quartiere Delle Vittorie, all’interno del Foro Italico, in viale dello Stadio Olimpico. Siamo alle pendici di monte Mario.
Creato nel 1927 come stadio dei Cipressi su progetto di Enrico Del Debbio (autore del Foro Mussolini, Palazzo del Ministero degli Esteri con altri, la facoltà di Architettura a valle Giulia, la palestra di via Populonia), fu ricostruito nel 1937 da Luigi Moretti (autore dell’Accademia di Scherma, il Villaggio Olimpico e il quartiere di Decima). Durante la guerra venne usato come autoparco delle truppe alleate. Nel 1953 venne ampliato e parzialmento ricostruito da Annibale Vitellozzi (autore nuova stazione Termini, sede biblioteca nazionale), fu chiamato lo stadio dei Centomila, per la capienza. Lo stadio venne inaugurato con la partita Italia-Ungheria e con l’arrivo della tappa Napoli-Roma del Giro d’Italia. Con l’assegnazione a Roma delle Olimpiadi del 1960 fu ribattezzato stadio Olimpico nome che gli rimane tutt’ora. In occasione dei campionati del mondo del 1990, lo stadio è stato quasi completamente ricostruito (progetto di Vitellozzi e Clerici) e ricoperto da una tensostruttura bianca in acciao e teflon che causarono polemiche con gli ambientalisti (forte impatto visivo sulla collina di Monte Mario). Il costo previsto di 80 miliardi di lire salì fino a 200, causando una inchiesta giudiziaria. Da allora può ospitare al massimo 72.698 persone, che lo rendono il secondo stadio d’Italia dopo il Meazza. Qui venne giocata la finale di quei mondiali di calcio tra Germani Ovest e Argentina che videro la vittoria dei tedeschi. Ospita regolarmente competizioni ufficiali di atletica leggera come il Golden Gala dal 1980 e i campionati europei di atletica leggera nel 1974 e quelli mondiali del 1987.
Nel periodo estivo è utilizzato per i concerti.
VIA VETULONIA
Qui è nato ed è vissuto da ragazzo Francesco Totti, attuale capitano della Roma. Nella vicina scuola elementare Manzoni ha studiato. Nella strada al civico 27, ad angolo con via Populonia, si trova il ristorante pizzeria “Core de Roma” che è un luogo di ritrovo tutto dedicato ai sostenitori della squadra. Da marzo 2014 si chiama “Roma 1927”. Per tripadvisor si colloca al posto n. 3.281 su 8.769. E’ aperto di pomeriggio per vedere le partite della Roma. Foto, poster e maglie della Roma sulle pareti, prevalgono foto e maglie di Totti, anche un manichino del “Pupone”. E’ aperto da lunedì a venerdì pranzo e cena, sabato e domenica solo pranzo.
Francesco Totti è nato a Roma il 27 settembre 1976, centrocampista o attaccante è capitano della squadra, è stato campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, medaglia d’argento agli europei del 2000. Dotato di grande tecnica è considerato uno dei maggiori calciatori degli anni Novanta e Duemila, ha sempre militato nella Roma, per la quale è il maggior autore di gol della sua storia, il calciatore con più presenze sia in campionato che nelle coppe europee. A livello professionistico è il sesto calciatore italiano di tutti i tempi per numero di gol fatti (314[4]) insieme a Luca Toni, preceduto da Silvio Piola (390), Alessandro Del Piero, Giuseppe Meazza, Roberto Baggio e Filippo Inzaghi. E’ soprannominato “Er Pupone” o “L’ottavo Re di Roma”.
Per quanto riguarda la vita privata nel giugno 2005 ha sposato la showgirl Ilary Blasi[5] nella chiesa di Santa Maria in Aracoeli. La coppia ha due figli: Cristian (5.11.05) e Chanel (13.5.07).
VIA APULIA
Sulla parete esterna della scuola media Pascoli in via Sibari si trova un murales che raffigura Totti. Il mega murales dedicato a Francesco Totti affaccia sulla vicina via Apulia, è stato realizzato nel febbraio 2014, a firmare l’opera è lo street artist Lucamaleonte, fa parte del ciclo mitologia contemporanea, un progetto di artisti di strada del gruppo 999 (direzione artistica Stefano Antonelli) in collaborazione con Comune e VII Municipio.
CIRCO MASSIMO
E’ stato il teatro dei festeggiamenti popolari per il terzo scudetto della Roma, quello del 2001, in quell’occasione si sono esibiti Antonello Venditti e Sabrina Ferilli. Alcuni giorni prima, quando si profilava la vittoria della Roma l’attrice Sabrina Ferilli annunciò che se la squadra avesse vinto lo scudetto si sarebbe spogliata. A vittoria avvenuta, il parroco della vicina chiesa di Sant’Anastasia dichiarò alla stampa che sarebbe stato sconveniente uno spogliarello a poco distanza da una chiesa aperta 24 ore su 24 per l’adorazione del Santissimo.
In via del Circo Massimo 7 c’è stata la sede dell’A.S Roma negli anni Settanta.
RIONE MONTI
In un vicolo traversa di via della Madonna dei Monti, vicolo del Pozzuolo, nel 2001, è stato realizzato un murales che raffigura Totti esultante dopo un gol nella stagione 2000/2001, quella dello scudetto. Si nota la fascia di capitano della squadra. Autore del ritratto, maggiore del vero è l’architetto Tommaso Arcangioli, che lo ha realizzato in una sola notte. Il 28 novembre 2013 il murales è stato imbrattato, subito i sostenitori della Roma si sono mobilitati e in pochi giorni è stato restaurato.
TRIGORIA
Il centro di allenamento della Roma è a Trigoria (in alcune carte è indicata come Trigoria Bassa), nella via omonima al Km 3,600 (piazza Dino Viola 1), in campagna, in una zona vallonata fuori dal centro abitato di Trigoria. Venne acquistato nel 1977 dal presidente Anzalone e inaugurato il 23 luglio 1979. Il complesso ha un primo ampliamento nel 1984 quando era presidente Dino Viola, un altro ampliamento nel 1998 sotto la presidenza di Franco Sensi.
Il centro si estende su 20 ha e comprende diversi terreni di gioco, uno di questi è chiamato Campo Testaccio in onore dello storico campo dove ha giocato la Roma, un altro è intitolato ad Agostino Di Bartolomei (capitano della Roma, tra gli anni settanta e ottanta, di carattere schivo, morì suicida a dieci anni esatti dalla partita persa con il Liverpool per la Coppa Campioni), alcuni campi da tennis e una piscina scoperta. Vi trovano posto quattro edifici circondati da un ruscello artificiale, in essi si trovano gli alloggi per i calciatori, i locali medici, la palestra, il bagno turco, ristorante e bar, la sede della rista LaRoma, una sala stampa e una cappella dedicata a Giovanni Paolo II inaugurata in occasione del Giubileo del 2000.
In occasione dei mondiali del 1990, il centro ospitò la nazionale argentina.
APPENDICE
Primo inno della Roma: “Campo Testaccio”
Cor core acceso da na passione,
undici atleti Roma chiamò,
e sott’ar sole der Cuppolone,
na bella maja a du colori je portò.
Li du colori de Roma nostra,
oggi signora der futtebbal,
non più maestri ne professori,
mo so dolori perche Roma ce sa fa.
Co Masetti ch’è primo portiere;
De Micheli scrucchia chè ‘n piacere;
poi c’è quer torello de Bodini;
cor gran Furvio Bernardini,
che dà scola all’argentini.
Poi ce stà Ferraris er mediano,
granne nazionale e capitano;
Chini, Fasenelli e Costantino,
co Lombardi e co D’Aquino,
Vorche chen mago pe segnà!
Campo Testaccio ciai tanta gloria,
nessuna squadra ce passerà.
Ogni partia è na vittoria,
ogni romano è bon tifoso e sa strillà.
Petti d’acciaio, astuzia e core,
corpi de testa da fa incantà.
Passaggi ar volo co’ precisione,
e via er pallone che la rete va a trovà.
Quanno che ncomincia la partita,
ogni tifosetta se fa ardita,
strilla forza Roma a tutto spiano,
co la bandieretta in mano,
perché cià er core romano.
L’ala centra e Vorche tira e segna,
questo è er gioco e Roma ve lo nsegna!
Cari professori appatentati sete belli e liquidati,
perché Roma ce sa fa.
Semo giallorossi e lo sapranno
Tutti l’avversari de st’artranno.
Fin che Sacerdoti ce stà accanto,
porteremo sempre er vanto,
Roma nostra brillerà.
BIBLIOGRAFIA
- Francesco Valitutti, Breve storia della grande Roma, ed. Tascabili Newton, 1995.
- Francesco Campanella, Forza Roma, ed. Della Città, 1994
- le pagine di cronaca di Roma de: la Repubblica e il Messaggero.
- Per questo testo mi sono avvalso degli articoli scritti da Massimo Izzi, giornalista de “Il romanista”, storico della Roma, laureato con tesi sulla fondazione della Roma, autore di 12 libri sulla storia della squadra.
SITOGRAFIA
https://it.facebook.com/officialroma
Piero Tucci
23.05.15
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
inbiciperoma.blogspot.com
[1] Italo Foschi (Corropoli 1884 – Roma 1949) politico e dirigente sportivo. Stabilì un primo accordo per unire le tre società in via Forlì 16, il 7 giugno, che poi si concretizzò nell’ordine del giorno del 22 luglio. Fu tra i redattori della Carta di Viareggio che ridisegnò l’organizzazione del calcio, con un unico girone nazionale, introducendo il professionismo, il calciomercato e il blocco degli stranieri (dando origine al fenomeno degli oriundi).
[2] Attilio Ferraris (Roma 1904 – Montecatini Terme 1947) di ruolo mediano, proveniente dalla Fortitudo, nativo di Borgo, è conosciuto come Ferraris IV perché aveva tre fratelli più grandi anch’essi calciatori. Morì a Montecatini sul campo di calcio in una partita tra vecchie glorie. E’ sepolto al Verano dove è scritto “Attilio Ferraris, campione del mondo”.
[3] Fulvio Bernardini (Roma 1905 - 1984) dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore, prima portiere, poi centrocampista. Giocatore della Roma, della Lazio e dell’Inter, allenò Sampdoria, Firoentina, Bologna e Lazio. E’ stato commissario tecnino della Nazionale Italiana dal 1974 al 1977, succedendo a Ferruccio Valcareggi. Il campo sportivo di Trigoria gli è intitolato.
[4] Numero dei gol di Francesco Totti. Situazione aggiornata al 23.5.15.
[5] Ilary Blasi (Roma 28 aprile 1981) showgirl e conduttrice televisiva italiana. Deve il successo al ruolo di letterina nella trasmissione Passaparola di Gerry Scotti, nel 2001/2002. Dal 2003 affianca Fabio Fazio in “Che tempo che fa”. Nel 2006 ha affiancato Panariello nella conduzione del festival di Sanremo. Dal 2007 presenta Le Iene su Italia 1.
Il nome deriva dal latino Praedium Amaranthianus, cioè fondo di Amarantus, un liberto della famiglia Numisii Proculi del II secolo d.C. La torre si trovava a poca distanza dalla via Ardeatina ma oggi è scomparsa. Quella che si trova lungo la via omonima è in realtà la Torre delle Vigne o di San Tommaso, mentre in via delle Sette Chiese si trova il casale di Tor Marancia.
Alla fine degli anni Venti sorse la borgata composta di casette in muratura o in legname, altre furono realizzate dall’ICP e classificate case minime di una sola stanza, pavimento in terra battuta e senza servizi igienici. La borgata venne chiamata Shanghai. Tale borgata venne abbattuta a partire dal 1948 e vennero costruite le case attuali.
Il 9 marzo 2015 sono stati inaugurati dal sindaco Marino 20 murales di Street Art tra le case Ater di Tor Marancia, il progetto si chiama “Big city life” è stato ideato da “99Contemporary”, ci sono voluti 70 giorni di lavori, nei quali sono stati dipinti 2.500 mq di pareti esterne, sono serviti 756 litri di vernice, 974 bombolette spray, il tutto è stato finanziato da Fondazione Roma presieduta da Emanuele Emmanuele. I murales si trovano su undici palazzi, sono alti 14 metri. Vi hanno lavorato 18 artisti provenienti da 8 paesi del mondo: Diamond, Jaz, Moneyless, Baudelocque, Seth, Mr. Kleva e altri. I murales si trovano nel lotto di case Ater compreso tra viale di Tor Marancia, in via Annio Felice, via Santa Petronilla e via Valeria Rufina .
La street art è nata a Los Angeles e Miami negli anni Sessanta. Progetti simili sono stati realizzati a Ostiense, Quadraro, San Basilio (sempre finanziato dalla Fondazione Roma) e a Torpignattara. In via Galvani a Testaccio c’è un grande lupo simbolo della Roma, che si arrampica fino in cima al palazzo. Diverso ciò che è accaduto alla borgata del Trullo.
Roma è un punto di riferimento per questa “street art” dagli anni Ottanta, dal 2000 sono presenti a Roma artisti di fama mondiale. Il comune ha censito 350 opere nell’aprile 2015, Fondazione Roma è stata sponsor di questa arte non solo qui ma anche a San Basilio. Il Macro diventerà punto di riferimento per diffondere la conoscenza di questa arte. Roma è importante per la conoscenza del tecnica del collage e della pittura murale grazie a Sten & Lex attivi dal 2001 e considerati tra i pionieri degli stencil graffiti.
Durante l’inaugurazione il sindaco e il presidente del Municipio hanno incontrato gli abitanti delle case popolari che gli hanno prospettato il problema del parco della Torre che è chiuso, degli ascensori che non funzionano, delle infiltrazioni di umidità negli appartamenti, delle bottiglie di vetro vuote abbandonate alle fermate dei bus.
CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES
Si tratta della parrocchia di Tor Marancia, è stata eretta il 1° ottobre 1957 dal cardinale vicario Clemente Micara, è affidata alla Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, poi al clero diocesano. Dal 1936 esisteva una cappella dipendente dalla chiesa di San Sebastiano fuori le mura. Il progetto della chiesa si deve all’architetto Gino Cancellotti[1], ha una facciata in laterizio scandita in tre settori da fasce di cemento armato, è a pianta poligonale, sormontata da una lanterna e affiancata da alto campanile.
[1] Gino Cancellotti. (San Vincenzo 1896-Roma 1987) architetto razionalista, aderì al Miar e partecipò alle edizioni dell’Esposizione Italiana di Architettura Razionale a Roma e a Firenze. Collaborò con Eugenio Montuori, Luigi Piccinato. A lui si devono i piani regolatori di Foggia, Chianciano, Sabaudia con Montuori, Piccinato e Scalpelli nel 1933, il monumento equestre a Diaz a Napoli nel 1934, il piano regolatore di Guidonia nel 1938.