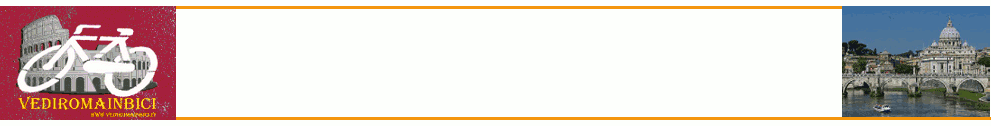Foto e Schede 2016
LE SORPRESE DELLA
VIA APPIA NUOVA
DALLO STATUARIO AL QUARTO MIGLIO
A SAN GIOVANNI, LA VIA APPIA RISERVA TANTE SORPRESE.
Percorriamo la via Appia Nuova al contrario, a partire dallo Statuario fino a porta San Giovanni; raggiungiamo la borgata romana dal parco degli Acquedotti.
LA VIA APPIA NUOVA
“Nella bella Campagna Romana a volte passavano i cavalieri in giacca rossa e le amazzoni della caccia alla volpe. Via Appia era molto romantica: la vista era aperta verso gli acquedotti e i Castelli Romani, nei campi fra le rovine pascolavano greggi”[1].
La strada venne delineandosi tra il XIV e il XV secolo in seguito al declino della via Appia Antica, alla fine del Cinquecento (1574) fu sistemata da papa Gregorio XIII[2], prese il nome di via Campana, anche papa Pio VI Braschi alla fine del Settecento fece importanti lavori di sistemazione; nel 1940 fu ampliata e portata alla larghezza attuale di 40 metri fino a ponte Lungo.
STATUARIO
Si trova lungo l’Appia Nuova, fa parte del VII Municipio. Il quartiere prende il nome dall’abbondanza di statue rinvenute nella zona per la vicinanza alla villa dei Quintili e della stessa via Appia Antica. Le statue venivano sciolte nelle calcarare per ottenere della nuova calce. Il suo nome è molto antico, compare per la prima volta in un atto di compravendita del 1393.
Nel 1940 vi furono costruite due borgate urbano-rurali chiamate Tempio della Salute e Roma Vecchia (entrambe nel parco degli Acquedotti). Nel 1941 sorse la borgata privata detta Caroni dal nome dell’ingegnere proprietario della zona. Nel 1948 cominciò la sistemazione urbanistica della zona con la costruzione di strade, scuole e della chiesa. Lo sviluppo edilizio della zona si deve anche alla linea tramviaria per Capannelle che collegava con la stazione Termini, è rimasta in servizio fino al 1978, di essa rimane in piedi la stazione Statuario sulla via Appia. Anche la vicinanza con l’ippodromo delle Capannelle per il galoppo (il trotto era a Tor di Valle) e la caserma dei Vigili del Fuoco (progettata nel 1939 e inaugurata il 4 agosto 1941) con la sua Scuola Centrale Antincendi che ha formato migliaia di giovani italiani e somali (all’interno anche il museo del Corpo dei Vigili del Fuoco con ingresso da piazza Scilla 2), sono tra le ragioni di sviluppo della borgata. Non è da sottovalutare la presenza della fonte Capannelle che i romani raggiungevano i bicicletta. La viabilità è rimasta essenzialmente la stessa, tutte le strade sono a senso unico, spesso senza marciapiedi. Le case sono basse, a due, massimo tre piani, anche per la vicinanza con l’aeroporto di Ciampino che impedisce costruzioni più alte. L’unica strada larga, via Polia, è sede di un piccolo mercato rionale.
Nel 1970 aprì il primo asilo nido comunale della zona, si trova in via del Calice. Le novità degli ultimi anni sono l’inaugurazione di un grande albergo, nel 2001, l’Hotel Capannelle, di via Siderno, un albergo a quattro stelle con 252 camere, con sala congressi, piscina scoperta e ristorante. Altra novità è l’attività di un comitato di quartiere che è riuscito a strappare al degrado l’unica area verde della zona ora chiamato “Uscita 23. Centro Civico Polivalente”.
Via Appia Nuova.
Edifici della borgata Caroni. Sarcofago romano. Torre dell’orologio. Lapide con la dicitura “Cantieri Caroni”. Obelisco con i nomi delle strade della borgata. Stazione Statuario del tram Termini – Capannelle.
Chiesa di Sant’Ignazio di Antiochia. Costruita fra il 7 ottobre 1956 e il 1957 su progetto dell’arch. Tullio Rossi[3], consacrata il 12 ottobre 1957. E’ sede parrocchiale dal 1952 (territorio desunto da San Tarcisio al Quarto Miglio). Fu visitata da Giovanni Paolo II il 16 marzo 1980. Sulla facciata la statua di Cristo Redentore, sulla destra massiccia torre campanaria. L’interno è a pianta longitudinale con abside e tre cappelle sulla sinistra. Nell’abside mosaico con la Vergine in trono con il Bambino e sant’Ignazio nelle vesti episcopali mentre un angelo gli consegna la palma del martirio. E’ opera di Gilda Nagni e Franco d’Urso. La Via Crucis è di Alessandro Monteleone[4].
Nei locali della parrocchia si riunisce la Statuario Band, orchestra di fiati di 40 elementi. Nasce dall’omonima associazione musicale senza fini di lucro.
Biblioteca Statuario.Via Squillace 3, nei locali della parrocchia Sant’Ignazio di Antiochia, basato sull’impegno volontario di un gruppo di persone qualificate. E’ inserita nel Servizio Bibliotecario Nazionale e quindi consente di effettuare ricerche bibliografiche in internet. Propone incontri con gli autori. Possiede 10.000 volumi e 3 postazioni anche in rete. Possiede anche un fondo antico con testi del Settecento e Ottocento. E’ aperta i giorni dispari di pomeriggio e la domenica mattina.
Via Bisignano. Sepolcro detto Tempio di Coriolano. L’edificio sorge lungo una deviazione della via Appia che conduceva a Castrimoenium, oggi Marino. Si tratta di un sepolcro a pianta quadrata, costituita da due camere sovrapposte, quella inferiore era la cella funeraria illuminata da strette finestrelle e coperta da volta a crociera di cui rimangono solo i pennacchi agli angoli delle pareti. La camera superiore, destinata ai riti funerari, era decorata da una nicchia per lato, contenenti i ritratti dei defunti. Anche questo ambiente era coperto da una volta a crociera di cui restano i pennacchi. L’esterno è in laterizi: mattoni gialli per la cortina e rossi per le decorazioni. E’ simile alla Sedia del Diavolo e al tempio del Dio Redicolo in Caffarella. Datato al II secolo d.C. Nel medioevo fu torre di guardia.
Piazza Mileto. Edicola votiva dedicata alla Madonna.
Uscita 23. Centro Civico Polivalente. Via Amantea. Prende il nome dall’uscita del Gra. La struttura risale al 2001, si deve alla Società Edilizia del Sole e del Mare Srl che ha dicharato fallimento, la proprietà è del municipio. Nel 2011 il presidente dell’allora decimo municipio Sandro Medici ha assegnato l’edificio a quattro associazioni del territorio. Sembra che l’edificio non ha mai avuto il collaudo. Un incendio lo ha danneggiato il 31 gennaio 2014.
Piazza Rosarno. Uno dei centri della borgata.
QUARTO MIGLIO
Il nome ufficiale del quartiere è Appio Pignatelli ma è conosciuto da tutti come QUARTO MIGLIO, fa riferimento al quarto miglio della via Appia Antica, indica la distanza dal Campidoglio. Fa parte del VII Municipio del Comune di Roma.
Alla fine del II secolo esisteva in questo tratto della via Appia Antica una vasta borgata che prese il nome “ad Quartum”. Ricordiamo che un miglio romano equivale a m 1482.
Nel medioevo la famiglia Caetani prese possesso della tomba di Cecilia Metella, la fortificò e impose un pedaggio. Questo fatto impose gradualmente un cambiamento negli itinerari dei viaggiatori, per cui molti deviarono su quella che poi è diventata la via Appia Nuova. Nel Settecento la via Appia Antica veniva definita “abbandonata e deserta nella desolazione della campagna malarica e spopolata”. A metà Ottocento la strada venne restaurata ad opera dei papi, tra i più impegnati Pio IX, e di grandi artisti.
Le rare abitazioni di campagna della zona facevano riferimento alla parrocchia di San Sebastiano affidata ai francescani, la parrocchia fu istituita nel 1826. Nel 1919 venne eretta la parrocchia di Ognissanti sulla via Appia Nuova, finalmente nel 1935 la parrocchia di San Tarcisio, sempre affidata ai francescani (Padre Leonardo Bello fu ministro generale dei frati minimi), il suo territorio si estendeva da via dell’Almone alle Capannelle di Marino. Il 10 aprile 1927 viene aperta al pubblico la chiesetta dedicata a San Tarcisio tra la via Palazzolo e via Galloro. I frati di via Merulana venivano a celebrarvi messa nei giorni di festa. Intorno a questa data risale la costruzione di baracche in legno adibite a scuole Elementari dall’Ente Scuole Rurali, sono ancora visibili in via Galloro. Nel 1930 la bonifica dell’Agro Romano interessò la zona come si può vedere nell’iscrizione sulla Casa Cantoniera in via Appia Pignatelli. Nel 1932 il Governatore di Roma denominava la località: Borgata di San Tarcisio. Scrive padre Bello nel 1935: “Dalla prima visita fatta alle famiglie della parrocchia, si può constatare che si tratta di famiglie di agricoltori e pastori provenienti dalla Bassa Italia, per coltivare e condusse le vaccherie dell’agro romano; vi sono famiglie pisare addette all’ippodromo delle Capannelle, del resto poveri e addetti ai depositi di materiali da costruzione. Le famiglie sono 349 e formano una popolazione di 1558 persone, l’igiene lascia a desiderare, l’educazione elementare quasi non esiste”. Nel 1939 viene consacrata la nuova chiesa – parrocchia.
Nel 1945 sorge il Comitato Parrocchiale, sotto la direzione del parroco, si occupa dei bisogni della borgata. Cucine per i poveri, case per i senza tetto e gli sfollati, assistenza sanitaria, strade, luce, acqua, scuola, tram. Nel 1946 Colonie estive nella pineta di viale Appio Claudio. Il 21 luglio 1948 in via Annia Regilla, presso la chiesa, il Comune installa una fontanella. Nel 1948 nuovo ponte in muratura su via di San Tarcisio, il precedente è pericolante. Nel 1948 arriva il telefono. Il 1° gennaio 1951 inizia il servizio di autobus STEFER Statuario – Quarto Miglio – San Giovanni, poi prolungato a piazza Vittorio, il servizio alleggerirà quello del tram su via Appia Nuova. Nel 1952 viene inaugurato il campo sportivo Gerini, un campo di calcio. Prime scuole Elementari in via Galloro nel dopoguerra, il 16 gennaio 1954 il sindaco Rebecchini inaugura la scuola posta all’angolo tra la via e il vicolo di San Tarcisio (presenti il prefetto Binna e assessori). Nel 1949 arriva il telefono. Il 19 marzo 1961 arriva il nuovo organo, costo 700.000 £. Nel 1963 visita di Giovanni XXIII. Nel 1974 nasce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Nel 1978 viene soppresso il tram per Capannelle.
VIA APPIA PIGNATELLI
Sistemata nel Settecento da papa Innocenzo XII Antonio Pignatelli. Una strada sterrata esisteva su questo tracciato e univa la via Ardeatina con la Latina.
CASTELLETTO O CASTELLO AL IV MIGLIO
Si trova in via Appia Pignatelli al civico 235, sulla sinistra della strada venendo dal centro, tra via San Tarcisio e via del Quarto Miglio. Sembra abitato da artisti, ma la notizia è da confermare.
CHIESA DI SAN TARCISIO
La parrocchia è stata creata nel 1933 e retta dai francescani di via Merulana diretti da padre Leonardo Bello a cui è dedicato un busto davanti alla attuale chiesa. L’edificio di culto, eretto su progetto dell’arch. Tullio Rossi, è stato consacrato il 13 giugno 1939. La chiesa è stata visitata da Giovanni XXIII nel 1963 e da Giovanni Paolo II nel 1985 per i 50 anni della parrocchia.
La facciata è a capanna, cioè l’altezza è minore della larghezza. Interno a due navate divise da colonne con soffitto a capriate.
Tarcisio è un giovinetto romano, martire, a cui papa Damaso[5] dedicò uno dei suoi carmi più belli nelle catacombe di San Callisto. E’ patrono del quartiere.
TOR FISCALE
Tor Fiscale è una magnifica costruzione del XIII secolo alta circa 30 metri, costruita proprio nel punto in cui si incrociavano gli acquedotti Marcio e Claudio in modo che si potesse rilevare maggiormente. Detta anche Torre Branca, dal nome del tesoriere (fiscale) proprietario delle vigne della zona nel secolo XVII, permetteva il controllo della via Latina e di un vasto tratto di campagna romana. La torre è situata all’incirca al IV miglio della via Latina. Anche a monte di Tor Fiscale gli acquedotti Marcio e Claudio si intersecano nuovamente tra loro, racchiudento uno spazio trapezoidale. Questo luogo così singolare porta ancora oggi il nome di Campo Barbarico perchè nell'assedio di Roma del 539 da parte dei Goti di Totila, questi, per controllare le vie di accesso alla città tenuta da Belisario, costruirono proprio qui un campo trincerato, utilizzando la particolare conformazione degli acquedotti e chiudendo con pietre e terra le luci. L’area era delimitata dall’acquedotto Marcio (oggi Felice) e da quello Claudio, i vertici erano Tor Fiscale e dove oggi passa via del Quadraro. All’interno passava la via Latina.
Nel Seicento la torre e la tenuta divennero proprietà del fiscale o tesoriere pontificio Filippo Foppi che nel 1650 chiese al Capitolo Lateranense che venisse deviata parte dell’Acqua Mariana per irrigare la sua vigna.
La torre venne realizzata con la tecnica a blocchetti che prevedeva l’uso di piccoli blocchi rettagnolari di peperino, alternati spesso a corsi di laterizi, ben rifiniti sulla fronte tanto da garantire un gradevole aspetto esteriore. L’interno era suddiviso in tre piani oggi non più conservati, si conserva la copertura originaria. La torre recintata all’esterno da un muro di cinta che in parte si conserva nell’angolo sud-ovest, lungo il sentiero che la fiancheggia, dove passava la marrana.
Tor Fiscale è una borgata nata con funzioni agricole poi popolata di immigrati dall'Italia meridionale e dalle campagne del Lazio. All'ultimo censimento vi abitano 2.174 persone. Tra il 1970 e il 1980 il Comune avviò alcune opere di urbanizzazione primaria: rete idrica, fognaria, illuminazione e gas metano), il 24 aprile 1976 venne perimetrata l’area di Tor Fiscale in funzione di un suo recupero urbanistico. Negli anni Novanta, a causa del calo demografico, la chiusura della scuola Media prima, e della scuola Elementare poi, tolsero un importante servizio al quartiere. In quegli anni, all’interno di un deposito Cotral dismesso, si stabilirono degli extracomunitari, che vivevano in gravissime condizioni igieniche, l’accampamento venne eliminato dal Comune di Roma dopo alcuni mesi.
A Tor Fiscale Madre Teresa di Calcutta[6] aprì nel 1968 un centro di accoglienza e sostegno ai poveri della zona. Le Missionarie della Carità avevano la loro sede in vicolo di Tor Fiscale 73, un refettorio, una cappellina e qualche servizio. Si conserva una stanza dove Madre Teresa soggiornava abitualmente quando veniva a Roma. Le suore Missionarie della Carità soggiornarono in questo luogo dal 1968 al 1973, a loro sono subentrati i Padri Missionari della Carità, la comunità di sacerdoti fondata da Madre Teresa di Calcutta.
Dalla via Appia si volta a sinistra su via Anicio, quindi a sinistra su via Monte d'Onorio fino a via del Campo Barbarico. All'incrocio di queste due ultime vie, sotto l'apparenza di un VECCHIO FIENILE si conserva in tutta l'altezza un sepolcro rettangolare laterizio di età antonina. Al suo interno si noterà sul fondo una grande nicchia tra due minori e superiormente un'abside con copertura a catino, sempre tra due minori a fondo piano e copertura ad arco ribasssato, sono visibili resti della decorazione a stucco.
“Si tratta di un colombario di ragguardevoli dimensioni… dell’ingresso antico non c’è più traccia, così come è andata del tutto distrutta la volta del primo piano allorquando il monumento fu trasformato in fienile. Il rivestimento interno conserva stucchi originari e delle decorazioni in cotto. Lo stato di conservazione generale è discreto”[7].
In questa via, ma ad angolo con via di Torre del Fiscale si trova il CASALE RAMPA e il suo borgo, il cuore della borgata, il casale era un'antica vaccheria (quest'ultima notizia da: comune.roma.it / municipio IX / parco di tor fiscale). “La cisterna, di cui rimangono solo alcuni tratti di muratura in opera reticolata, è inglobata nell’antico casale Rampa, nel mezzo di alcuni casali della stessa età. Lungo la strada che fiancheggia la costruzione e che ricalca sempre il tracciato della via Latina, si possono riconoscere alcuni blocchi di marmo romano e frammenti di materiale archeologico[8]”. Il casale Rampa è chiamato anche Vigna Silvestrelli in documenti di fine Ottocento (da Paolo Montanari, cit, pag. 138).
Nella stessa via si trova la CHIESA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE costruita nel 1955 prende il nome dal santo a cui è dedicata la basilica del V secolo voluta da Leone Magno nel vicino parco delle Tombe Latine. La chiesa fu visitata da papa Paolo VI il 10 aprile 1966 e da papa Giovanni Paolo II il 26 aprile 1998. E’ a pianta rettangolare, presenta sull’altare maggiore una statua in ceramica che raffigura colui che la Chiesa ritiene il primo martire della sua storia ucciso il giorno di Pentecoste, come raccontato negli Atti degli Apostoli. Sopra il portone d’ingresso il santo è raffigurato tra due palme che simboleggiano il martirio. Campanile a vela.
Via di Campo Barbarico ricalca il percorso della via Latina.
IL PARCO DELLE TOMBE LATINE
L’ingresso è ad angolo con via dell’Arco di Travertino. Nel parco è conservato un tratto della via Latina di 450 metri posta al III miglio, fiancheggiata da alcuni sepolcri, mansiones (stazione di sosta) e dai resti della chiesa di Santo Stefano. Gli scavi che hanno riportato alla luce i resti archeologici sono del 1857 – 58 e sono dovuti ad un privato, un insegnante di nome Fortunati, che ottenne dallo stato Pontificio l’autorizzazione ad effettuare le ricerche quando tutta l’area faceva parte della Tenuta del Corvo di circa 46 ha che apparteneva alla famiglia Barberini Lante della Rovere. Dopo il 1870 lo Stato italiano ha espropriato l’area. Gli scavi proseguirono sotto la direzione di Rodolfo Lanciani e destinata a parco pubblico dal ministro Baccelli ai primi del Novecento. Agli anni Ottanta risalgono gli scavi nell’abside della basilica. Con i fondi per il Giubileo del 2000 sono state condotte campagne di scavo intorno ai sepolcri principali. Negli anni 2011 e 2012 si è pianificata una risistemazione complessiva dell’area. Purtroppo ancora oggi una parte della villa di Demetriade è occultata da un campo di calcio della società Almas e non è visibile la basilica di Santo Stefano utilizzata come deposito dalla Soprintendenza.
CHIESA DI SAN GASPARE DEL BUFALO
Nella piazza omonima, presso via Mondragone, via Rocca di Papa. La chiesa è stata consacrata il 24 ottobre 1981 dal cardinale Poletti, la parrocchia esiste dal 1956. Il progetto è dell’arch. Pier Luigi Nervi[9]. L’edificio è una costruzione ardita, ha la base circolare e si sviluppa in altezza quasi fosse una tenda. La copertura è eseguita con speciali guaine protettive, con pannelli di coibentazione e una copertura in rame pesante. Il campanile è staccato dal corpo principale e realizzato da sette pilastri in cemento armato che sorreggono le campane. Come ricorda una lapide all’interno la chiesa fu visitata da Giovanni Paolo II alcuni mesi dopo l’attentato che lo vide coinvolto in piazza San Pietro. L’interno si presenta con un piano di calpestio in leggera discesa verso l’altare e i banchi disposti a semicerchio. Fa da sfondo all’altare una grande struttura in ceramica, in essa è riprodotta l’immagine di San Gaspare del Bufalo, vi è inserito il tabernacolo. Di notevole è la Via Crucis opera bronzea del sacerdote francescano Andrea Martini le cui scene si susseguono senza interruzione lungo le pareti, i bozzetti in vetroresina sono nella chiesa di san Frumenzio ai Prati Fiscali. Secondo una fonte la via Crucis è in stile “maconde” proveniente dalla Tanzania.
“Si racconta che quando proposero all’architetto Nervi di pensare al progetto, questi prese un fazzoletto al centro, lo sollevò con due dita per una decina di centimetri e ne scaturì una specie di tenda: su questa concezione biblica lo studio avviò il progetto”[10].
San Gaspare del Bufalo (Roma 1786-1837) è stato un sacerdote italiano fondatore della congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, beatificato da Pio X nel 1904 e proclamato santo da Pio XII nel 1954. E’ sepolto nella chiesa di Santa Maria in Trivio presso la fontana di Trevi, la ricorrenza è il 28 dicembre. E’ ricordato come il predicatore dei briganti che cercò di convertire, operò nelle zone di confine tra Lazio e Campania. Si incontrò con il brigante Antonio Gasbarrone di Sonnino che convinse a costituirsi.
VELODROMO APPIO
In piazzale dei Castelli Romani. Costruito nel 1911 per il 50° dell’unità d’Italia, in sostituzione di un’analoga struttura nei prati di Tor di Quinto, ospitava gare ciclistiche su pista e l’arrivo di gare su strada. Aveva un tribuna coperta con sotto gli spogliatoi e gradinate che potevano ospitare forse 3 – 4.000 persone. Al centro vi era un campo di calcio, intorno la pista con curve molto ripide, “sembrava una ciotola lasciata sul prato”. Vicino vi era l’osteria di Scarpone con un campo di fave. I giovani venivano a sostenere gli atleti di Roma, i ciclisti Lazzaretti e Frascarelli. Gli anziani ricordano ancora quando nel dopoguerra arrivò Fausto Coppi, tale fu la ressa che il campionissimo dovette rifugiarsi nella salsamenteria Fiorucci posta all’angolo tra via Appia e via S. Maria Aus. detta il “bottegone”. Sul campo di calcio negli anni ’20 si allenava la squadra di calcio Roma, poi andava a giocare le partite di campionato a Testaccio. La Roma giocò qui la sua prima partita il 16 luglio 1927 con gli ungheresi del Ujpest, alcuni giorni prima della nascita ufficiale della squadra il 22 luglio 1927 in via Uffici del Vicario. La Roma vinse 2 a 0. Il 25 settembre giocò la prima partita di campionato con il Livorno, di nuovo vittoria per 2 a 0. Si allenarono lì anche squadre minori: la Stefer, la Mater (allenata da Fulvio Bernardini, giunse alla serie B nazionale), la Chinotto Neri. Prima delle Olimpiadi del 1960 la struttura fu abbattuta[11].
VILLA LAZZARONI
Alla fine dell’Ottocento il barone Michele Lazzaroni acquistò l’area della Vigna Peromini per farne una villa suburbana della sua famiglia. Si tratta di una famiglia proveniente da Torino, finanzieri legati alle vicende della Banca Romana, che arrivarono rapidamente a grandi ricchezze sfruttando il bisogno di case e di edifici pubblici in una Roma che da poco aveva assunto le funzioni di capitale d’Italia.
La famiglia, per ostentare il livello sociale raggiunto, riuscì ad ottenere il titolo di baroni dal re Umberto I nell’aprile 1879. Possedevano il palazzo Grimaldi a largo de Lucchesi (Fontana di Trevi) e alcune tenute nella Campagna Romana, come quelle di Tor di Quinto (Ponte Milvio) e Leprignana. In questo contesto la vigna di Pontelungo doveva diventare una villa di delizie. La zona a Nord divenne un giardino con piante di ogni tipo e finti reperti archeologici, la zona a Sud e Ovest era divisa in vari settori ma comunque utilizzata a scopo agricolo.
Il prospetto settentrionale dell’edificio della villa, o casino, corrisponde al lato corto del rustico preesistente ai Lazzaroni. La facciata è disegnata in stile neoclassico con portico aggettante in tre aperture, sovrastato da un terrazzo cinto da balaustre. Gli spigoli del prospetto sono risaltati da finte bugnature angolari. Il corpo occidentale fu realizzato per dotare l’edificio di un grande salone da ballo e ricevimento, ed è caratterizzato da grandi finestroni ad arco. Una grotta decorata in stile rustico completava la decorazione. Nel parco si possono ancora riconoscere le fontane rustiche a scogliera di tufo, sistemate nei punti cruciali del sistema viario e l’area antistante il prospetto nobile e il salone dei ricevimenti. Verso via Fortifiocca vi era un’area a uliveto, oltre di questa si estendeva un’area coltivata a frumento che arrivava a via Latina e forse oltre. Un’entrata doveva esserci da questa via perché un doppio filare di cipressi giunge da quel lato fino alla piazzetta dell’attuale municipio. Alcuni cipressi sono sopravvissuti anche nel giardino della scuola Media al di là di via Fortifiocca. Tutti questi interventi di sistemazione della villa furono portati a compimento entro il 1893, anno in cui lo scandalo della Banca Romana travolse la famiglia visto che il barone Michele era l’amministratore.
Le vicende successive hanno alterato proporzioni e aspetto della villa. Nel 1908 la villa venne utilizzata come ricovero per gli orfani del terremoto di Messina da parte dell’orfanotrofio Pio Benedettino. Dopo l’ultima guerra fu acquistata dalle Suore Francescane Missionarie di Maria. Negli anni 1960-61 fu costruito un orfanotrofio poi diventato asilo e scuola, contemporaneamente una chiesa, alterando la pianta dell’edificio. Negli anni immediatamente successivi i due ettari di parco verso Nord sono ceduti al Comune mediante permuta e viene realizzato un muro divisorio. Il decadimento del giardino è immediato vista l’alta densità abitativa del quartiere.
Negli anni Settanta l’apertura di via Raffaele De Cesare determina l’arretramento del muro di cinta del parco e l’abbattimento del portale d’ingresso. Finalmente nel 1979[12], anche la parte ancora privata, viene acquisita dal Comune e viene aperta al pubblico nella sua totalità. La villa raggiunge un’estensione di 54.000 mq. Il palazzo principale viene adibito a sede del IX Municipio (dal 2013 è stato unito al X e prende il nome di VII Municipio con sede del consiglio municipale e del presidente in piazza di Cinecittà, qui restano gli uffici), le stalle e il fienile saranno sede dei Vigili Urbani, oggi sede dei gruppi consiliari.
Attualmente un edificio ospita il servizio giardini, la scuola continua la sua funzione, la chiesa è diventata teatro, è stato aggiunto un centro anziani, campi da bocce, una pista di pattinaggio e un parcheggio. La pista di pattinaggio è stata una delle prime di Roma aperte a tutti in una villa pubblica (testimonianza orale di Antonella Giuliani nella pagina facebook Sei dell’alberone se…). E’ intitolata alla memoria del carabiniere Otello Stefanini ucciso a Bologna il 4 gennaio del 1991 per opera della cosiddetta banda della Uno bianca. Otello abitava in via Furio Camillo dove un’altra lapide lo ricorda, era stato alunno della Cagliero.
La villa ha ospitato negli anni Sessanta e Settanta le feste dell’Unità e dell’Avanti. Attualmente vi si svolgono iniziative dell’Estate Romana (nel 2010: “Le arene di Roma”, ciclo di film a 6-4 €) e del Carnevale rivolte alle scuole e ai bambini.
Il 24 giugno 2010 il municipio ha presentato un progetto di riqualificazione e risistemazione della villa chiamando tutta la cittadinanza ad esprimere opinioni, idee, suggerimenti. Il 10 settembre 2011 è avvenuta l’inaugurazione del restauro della villa.
L’8 marzo 2009 si è tenuto nella villa un concerto di Franco Califano contestato dalle associazioni femminili e femministe per le affermazioni maschiliste dell’artista.
Dall’entrata principale di via Appia Nuova si giunge in breve alla Rotonda, luogo così chiamato per la presenza di un’aiuola circolare che ha all’interno una fontana purtroppo non attiva. All’interno dell’aiuola circolare piante di lagerstroemia. All’esterno alte palme, cedri, una magnolia. All’inizio della strada di destra l’albero di Giuda. Si continua nel viale centrale, ancora palme, una pianta di acacia sulla destra, un ligustro sulla sinistra, un tasso posizionato subito dopo la strada che va al teatro. Si giunge sul piazzale di quella che era la facciata principale della villa. Spiccano una araucaria, tante palme, un grande platano, siepi di alloro. Sul fianco sinistro un cipresso del Giappone. Giriamo intorno all’edificio per giungere finalmente alla piazzetta del municipio. Al centro c’era una giovane mimosa ma è stata sostiutita con un altro albero ornamentale, un grande eucalipto ombreggia l’entrata degli uffici. Ulivi e cipressi circondano il parcheggio. Si torna sulla piazzetta dove prospetta la facciata del Casino. Avanziamo di fronte a noi, incontriamo alcuni pini di Aleppo, quindi una piazzola circolare delimitata da alloro con al centro un mandorlo di oltre 130 anni. Tra la pista di pattinaggio e il campo di bocce ecco alcuni pioppi. Verso le uscite di via Fortifiocca ancora molti ulivi. Tornando sui nostri passi, procediamo verso la giostra e la nuova uscita di via Appia Nuova ecco il gincko. Quest’ultima è una pianta originaria della Cina, il nome è stato attribuito dal famoso botanico Carlo Linneo nel 1771. E’ un albero le cui origini risalgono a 250 milioni di anni fa (Permino) per questo è detto “il fossile vivente”. E’ anche chiamato albero di capelvenere. Sembra che sia sopravvissuto all’esplosione atomica di Hiroscima.
Questa è la poesia che gli ha dedicato Goethe.
Le foglie di quest’albero
Dall’Oriente venuto
A ornare il mio giardino
Celano un senso arcano
Che il saggio sa capire.
C’è in esso una creatura
Che da sola si spezza?
O son due che per la scelta voglion
Esser una sola?
Per chiarire il mistero
Ho trovato la chiave:
non senti nel mio canto ch’io
pur essendo uno anche duplice sono?
PIAZZA DELL’ALBERONE
che ha questo nome per la presenza di una quercia, questa ha dato il nome al quartiere. Nel 1988 la vecchia quercia è seccata ed è stata ripiantata a cura di un vivaio dell’Umbria, recentemente è stata rivalutata con un muretto-sedile, per cui è tornata punto di incontro per gli abitanti del quartiere. Il 7 novembre 2014 una bomba d’acqua si è abbattuta su Roma e l’alberone è crollato alle 7 di mattina. Il 20 novembre 2014 è stato ripiantato e il giorno successivo inaugurato alla presenza degli alunni delle scuole e del sindaco Ignazio Marino. Si tratta di un leccio di 150 anni, alto 10 metri e con il diametro di m 1,60. A luglio del 2015 l’albero era secco. Il 28 ottobre è stato ripiantato ma nell’operazione di spostamento dal camion al terreno il tronco si è squarciato. Un nuovo albero, l’ultimo è stato piantato il 30 ottobre 2015 alle ore 12 (è un alberello di 6 m). Negli anni Venti la città arrivava fin qui, sotto l’Alberone stazionava un barbiere con una sedia, una valigetta e tutto l’occorrente per barba e capelli, vivere qui era come trovarsi in un piccolo paese. Ai primi del Novecento intorno all’Alberone è sorto un MERCATO per il semplice motivo che la cinta daziaria coincideva con il vallo ferroviario, era quindi il punto naturale di incontro tra le merci che arrivavano dai Castelli e i romani della zona. Aveva banchi e carretti di legno privi di ancoraggi al suolo, sempre più grande, negli anni Sessanta si estendeva anche per via Paolo Paruta, ricordo un venditore di lumache, le teneva in una grande cesta, ogni tanto le rimetteva dentro perché gli animaletti tendevano ad uscire. Sul lato sud della piazza, al civico15-17 di via Gino Capponi, aprì il suo primo negozio di salumeria-pizzicheria il fondatore dell’azienda Innocenzo FIORUCCI. La sua famiglia, proveniente da Norcia, negli anni Venti gestiva solo quell’esercizio nella Capitale[13]. Oggi l’azienda Fiorucci ha sede a Pomezia, ha 4.000 dipendenti e un fatturato di 300 milioni di euro (2010). Fino al gennaio 2016 i locali a piano terra erano usati come rimessa dei banchi del mercato. La bella palazzina ad angolo con via Carlo Sigonio è stata per tanti anni sede della DC. La quercia, o meglio il leccio, ha dato il nome alla sezione del Pci che si trovava nelle vicinanze, ora Pd, nei giorni successivi alla liberazione la sezione era in circonvallazione Appia dove fino a pochi anni fa è stata una condotta medica (ora una copisteria). Durante i nove mesi di occupazione tedesca di Roma, uno dei partigiani più attivi della zona, Antonio Lalli, venne arrestato e torturato a via Tasso, quindi venne portato dai nazisti sotto l’alberone, quasi cieco e lasciato apparentemente solo, la speranza era che qualcuno lo riconoscesse per poter arrivare ai complici. Nessuno lo riconobbe. Dopo la liberazione la sorella raccontò che in un colloquio, al momento dell’abbraccio disse che aveva riconosciuto due compagni di lotta ma di non averli chiamati per non coinvolgerli nella repressione. Antonio Lalli è stato fucilato a Forte Bravetta il 4 marzo 1944.
Sulla PIAZZA DELL’ALBERONE si trova, al civico 15, un PALAZZO ICP PONTE LUNGO del 1927, dell’arch. Camillo Palmerini[14]. Sul portone vi sono due volute, al termine delle volute due balconcini. Sulla verticale dell’entrata si trova un cerchio incorniciato che dà origine ad una semisfera scavata. Ai lati dell’entrata principale due grandi arcate trasformate in negozi. Nella parte centrale alta, si trovano tre finestre ad arco con colonnette, ai lati elementi decorativi detti “a fontanella”. Sono gli stilemi tipici del tardo barocchetto romano. Ad angolo con via Veturia si trova la gelateria Petrini, una delle più apprezzate di Roma, prima era sempre su via Appia Nuova ma ad angolo con via Orazio Coclite.
Dalla piazza inizia, a destra, via Gino Capponi con lo storico mercato dell’Alberone, all’inizio della via si trova la pizzeria DAL BERSAGLIERE riconosciuto locale storico dal Comune di Roma, esisteva anche prima dell’ultima guerra. All’interno si trova una pittura murale del quadro di Michele Cammarano “La presa di Porta Pia” che si trova al museo di Capodimonte. In un quadro è esposto un ritaglio di giornale nel quale Francesco Totti dice di frequentare tale pizzeria con Ilary Blasi (negli anni in cui erano fidanzati); Totti era di Porta Metronia, non lontano da qui.
CHIESA DI OGNISSANTI
Una delle prime chiese di Roma sorta fuori le mura su terreni della ex villa Colonna[15], già appartenenti alla famiglia del sindaco Prospero Colonna. La prima chiesa costruita fuori le mura Aureliane fu la chiesa di San Gioacchino in Prati, in via Pompeo Magno, nel 1898, ma siamo sempre in un rione. La prima chiesa costruita nei quartieri fuori le mura fu Santa Teresa d’Avila a corso Italia nel quartiere Pinciano nel 1902.
Questa chiesa è opera dell’arch. Costantino Sneider (autore anche della chiesa dell’Immacolata a San Lorenzo), la posa della prima pietra avvenne il 29 giugno 1914, i lavori furono interrotti per la guerra mondiale, la chiesa fu ultimata nel 1920, secondo modelli di ispirazione romanica con elementi bramanteschi. La parrocchia si estendeva dalle mura Aureliane a Capannelle, fino ai confini con la diocesi di Albano. Le cinque campane furono consacrate ed issate sul campanile il 29 giugno 1927. La facciata presenta dei rilievi nelle lunette, al centro “Gloria della Madonna”. All’interno la chiesa è divisa in tre navate da pilastri alternati a colonne di granito. Il tetto presenta la copertura a volte a crociera. Una serie di finestre, nella navata centrale, hanno le vetrate con santi, tra questi Don Bosco. In questa chiesa papa Paolo VI celebrò la prima messa in lingua italiana (7 marzo 1965) dopo la riforma del Concilio Vaticano II.[16]
Una piccola cappella esisteva in zona già dal 1908 affidata da Pio X a Don Luigi Orione[17] come ricorda una lapide posta su via Appia Nuova dopo via don Orione. Si racconta che quando don Orione chiese al Papa di aprire una missione in Sud America, egli, riferendosi ai prati fuori porta San Giovanni gli disse: “Quella è la tua Patagonia. Là c’è tutto da fare”.
PIAZZA RE DI ROMA
uno dei centri del quartiere e uno dei luoghi più conosciuti della città. Al centro ha dei giardini che sono stati intitolati a Fernando Masone, prefetto della Repubblica, capo della Polizia dal 1994 al 2000. I giardini sono stati riqualificati nel febbraio 2013. Un tempo la strada tagliava a metà il giardino, vi erano giostre e d’estate una bancarella vendeva cocomeri. E’ una delle poche piazze a pianta stellare volute dal piano regolatore del 1909. Al centro passava la tramvia dei Castelli per Albano e Genzano, il tram diretto a Cinecittà (che proseguiva seguendo la via Anagnina fino a Grottaferrata) e quello diretto a Capannelle (lo gestiva la società STFER, tramvie e ferrovie elettriche di Roma; poi STEFER). La linea tramviaria fu realizzata nel 1903 e arrivava fino a via delle Cave. Tra il 1909 e il 1916 la linea venne completata. Nel film “Intervista” (1987) Federico Fellini raccontò il suo primo viaggio verso Cinecittà con il tram. “Seduto sul tranvetto, Fellini ha visto cascate, palazzi, radure, indiani. Più si avvicinava alla Mecca del cinema, più il viaggio diventava stupefacente. Il tram era la diligenza di Ombre Rosse, la nave degli Argonauti, l’Orient Express, era Ronzinante e Pegaso, era un piccolo razzo sparato verso la meraviglia, era il destino. Fellini ci spiegava che non ha importanza quanto lungo sia il viaggio che dobbiamo fare, quanto lontano ci porta, ciò che conta davvero è la nostra disposizione alla sorpresa: ogni tragitto, anche il più breve, può essere uno spaesamento, un’avventura straordinaria”[18]. Sul lato destro della piazza si trova il supermercato Sma, uno dei primi supermercati di Roma. Oggi al di sotto si trova la fermata della metro A Re di Roma.
PIAZZALE APPIO CON
PORTA SAN GIOVANNI
Di fronte a porta San Giovanni si apre la via Appia Nuova, a destra via Magna Grecia e ancora a destra, ma lungo le mura, via Sannio (queste fanno parte del quartiere Appio Latino). Sulla sinistra si apre largo Brindisi da cui si dipartono via Taranto e via La Spezia, ancor più a sinistra, lungo le mura è viale Castrense. Il palazzo tra le ultime due strade conserva sul terrazzo la sirena metallica per l’allarme antiaereo dell’ultima guerra mondiale, è a forma di cono rovesciato con tagli orizzontali. Questo palazzo ha un celebre negozio per le mamme e i neonati, si chiama Cicogna, prima di questa costruzione vi era un forno e un’ostreria detta Vanicore, dal nome del proprietario.
In quest’area, il 24 giugno, si tenevano i festeggiamenti per la FESTA DI SAN GIOVANNI, una delle feste religiose e profane più sentite nella città. La festa iniziava la notte della vigilia, la cosiddetta “Notte delle streghe” durante la quale la tradizione voleva che le streghe andassero in giro a catturare le anime. Al lume di torce o lanterne la gente arrivava a San Giovanni, pregava il santo, cenava nelle osterie e nelle baracche improvvisate a base di lumache affogate nel sugo pepato perché le corna rappresentavano discordie e preoccupazioni, mangiarle voleva dire distruggere le avversità, la cena avveniva tra profumi di spighetta e suoni di campanacci. Durante e dopo si ballava il Saltarello[19]. Si faceva rumore con campanacci, tamburelli, trombette e petardi per impaurire le streghe. Si metteva l’aglio sulle porte e le finestre di casa per tenerle lontano. La festa si concludeva all’alba con l’arrivo del Papa per celebrare la messa e impartire la benedizione dalla loggia della basilica. Nell’antica Roma, il 24 giugno, si festeggiava la dea Fortuna, della casualità, che non poteva essere adorata se non in questa data. La religione cattolica, conscia dell’importanza del solstizio d’estate e dei festeggiamenti ad esso associati, sovrastò con le proprie celebrazioni. Così il solstizio d’Estate è diventato la festa di San Giovanni il Battista, nato sei mesi prima di Cristo.
Nel 1891 iniziò il Festival della Canzone Romana, il proprietario dell’osteria Facciafresca aveva fatto allestire un palco con l’orchestrina, ma tale fu la ressa che il palco crollò inghiottendo cantante e orchestrali. La manifestazione fu spostata al teatro Grande Orfeo sotto la Galleria Regina Margherita in quella che oggi è via Depretis, vinse “Le streghe” cantata da Leopoldo Fregoli in procinto di diventare il trasformista per eccellenza.. Da allora ogni anno si tenne il festival, qualche volta si spostò al teatro Morgana ora Brancaccio o al cinema teatro Massimo dove oggi è Coin. Quante canzoni nacquero in questa occasione? Affacciate Nunziata (considerata una delle più belle canzoni di fine secolo), Nina si voi dormite, Appresso alla reale, Casetta de Trastevere, Vecchia Roma, Serenata Celeste… Il festival ha perso via via importanza come la stessa festa di San Giovanni. Dal 1991 è rinato sotto la direzione artistica di Edoardo Vianello, nel 2013 è giunto alla XXIII edizione, si svolge al teatro Olimpico[20].
Al di sotto del piazzale Appio si trova la stazione San Giovanni della metro A.
METRO A ANAGNINA-BATTISTINI
E’ la linea arancione, è stata inaugurata il 16 ottobre 1980 dal sindaco Luigi Petroselli (tratto Ottaviano – Cinecittà, pochi mesi dopo giunse ad Anagnina l’attuale capolinea), oggi è lunga Km 18,4 con 27 stazioni (m 682 in media tra una stazione e l’altra), trasporta 450.000 viaggiatori al giorno, 164 milioni l’anno. La frequenza nelle ore di punta è di 2 minuti che scende a 10/15 nelle altre.
Fu costruita parte a cielo aperto, parte con il sistema della talpa che non creava problemi alla viabilità. Nel 1959 venne decisa la sua costruzione, i lavori iniziarono nel 1964 dalla Tuscolana e comportarono la deviazione della linea tranviaria Stefer. I ritrovamenti archeologici, soprattutto nella zona tra Termini e Repubblica richiesero la progettazione di alcune varianti, di questi diede una memorabile rappresentazione Federico Fellini nel film “Roma” (1972 con Anna Magnani e Fellini stesso). Fu prolungata tra il 1999 e il 2000 fino a Battistini. La sua inaugurazione venne salutata dai romani come la prima vera metropolitana cittadina, visto che la B era poco utilizzata e di superficie. Contestualmente venne chiusa la linea tramviaria Termini Cinecittà. Nel mese di agosto 2011 si rese necessario interrompere la metro per i lavori di consolidamento del terreno sotto la stazione San Giovanni dove era in costruzione la metro C.
All’apertura dell’esercizio sono stati impiegati i convogli MA100 della Breda Costruzioni Ferroviarie. Dal gennaio 2005 hanno iniziato a circolare i treni S/300 dotati di impianto di aria condizionata, tutte le vetture sono intercomunicanti e più spaziose delle precedenti per la mancanza di alcuni posti a sedere. Questi attuali convogli sono stati costruiti dalla spagnola CAF e denominati MA300. Da allora i convogli MA100 sono stati progressivamenti trasferiti sulla Roma-Ostia.
Il deposito della linea A si trova ad Osteria del Curato, negli anni Settanta aveva una estensione di 67.000 mq, serviva al ricovero e alla manutenzione dei rotabili. La superficie coperta era di 9.200 mq. Per l’aumento dei passeggeri (da 150.000 a 450.000) si rese necessaria la riqualificazione del deposito stesso, tali lavori terminarono nel 2004 che portarono l’estensione a 78.000 mq, di cui 15.000 coperti.
Dal giugno 2013 tutta la linea è coperta dal segnale GSM e UMTS/HSPA.
E’ allo studio un prolungamento da Battistini a Casal Selce di quasi 7 Km con 5 stazioni. Verso sud è allo studio un prolungamento, tramite metropolitana leggera, fino alla stazione Torre Angela della metro C con 10 fermate. Un altro progetto prevede il collegamento con l’aeroporto di Ciampino e il paese stesso[21].
Il piazzale ha sulla destra il palazzo di Coin del 1973 che sostituisce una bassa costruzione con cinema Massimo di terza visione. In viale Castrense, appoggiate alle mura due lapidi ricordano i caduti nella guerra di liberazione dal nazifascismo del quartiere e i caduti della guerra 1915-18 del quartiere. Poco più oltre si conserva un edificio industriale con tetto a tegole, era una filanda.
TRAMVIA DEI CASTELLI
In questa piazza si attestava la tramvia per i Castelli realizzata dalla Stfer e inaugurata l’8 novembre 1903 fino a via delle Cave. Nel 1905 il capolinea fu spostato in piazza di porta San Giovanni aprendo un nuovo fornice nelle mura Aureliane, in seguito fu portato in via Principe Umberto oggi Giovanni Amendola, (presso la stazione Termini). Nel 1906 la linea fu prolungata fino Grottaferrata con diramazione per Frascati. Nello stesso anno aprì la linea Grottaferrata – Genzano con diramazione per Valle Oscura, da qui una funicolare conduceva a Rocca di Papa. Visto il successo del collegamento nel 1912 fu realizzata la linea tramviaria che seguiva l’Appia fino ad Albano (4 marzo 1912), prolungandola poi per Genzano e Velletri (12 settembre 1913). Nel 1916 fu realizzata una diramazione per Lanuvio. Nel 1928 la Stfer diventò una società a capitale pubblico passando sotto il controllo del Governatorato di Roma e cambiando la sua denominazione in Stefer. Negli anni Trenta venne raddoppiato il binario tra Roma e Capannelle visto l’incremento demografico della zona. Fra il 1943 e il 1944 il traffico fu sospeso su tutta la linea. Nel 1953 viene raddoppiato il binario tra via delle Cave e Cinecittà. Nel 1954 chiude la linea nel tratto tra Velletri e Genzano. Il 15 dicembre 1963 chiude la Cinecittà Grottaferrata. Il 3 gennaio 1965 si effettua l’ultima corsa tra Roma e Genzano. Nello stesso anno le linee Stefer conoscono una deviazione a causa della costruzione della metro A. Viene abbandonato il binario tra San Giovanni e piazza Re di Roma, sostituito da via di Santa Croce in Gerusalemme e via Monza. Nel 1970 la linea tramviaria viene spostata dalla Tuscolana a viale dei Consoli sempre per i lavori della metro A. Nel 1976 la Stefer viene assorbita dall’Acotral (Azienda Consortile Trasporti Laziali). Il 30 giugno 1978 viene chiusa la linea per Capannelle e il 15 febbraio 1980 si effettua l’ultima corsa per Cinecittà, perché apre la pubblico la metro A. A ricordo di questa rete tramviaria, nella stazione Anagnina si trova una motrice extraurbana Stefer n. 82.
Secondo il ricordo di un anziano del quartiere “negli anni Trenta e Quaranta, dopo piazza Re di Roma, il tram andava… andava” nel senso che andava veloce per la mancanza di abitazioni.
METRO C PANTANO-CLODIO
E’ la linea verde di Roma. Una delle più avanzate al mondo, senza conducente, vetture climatizzate, La metro taglierà la città da Est a Ovest per una lunghezza di 25 Km circa con 30 stazioni passando per il centro storico, si incontrerà con la metro A a San Giovanni e ad Ottaviano, con la B a Colosseo. I convogli sono senza conducente. Il costo (3 miliardi circa) è sostenuto al 70% dallo Stato, al 18% dal Comune e al 12% dalla Regione. La costruzione di questa è iniziata nel 2006 (con indagini archeologiche, nel 2007 i lavori veri e propri), nel luglio del 2011 è finita la costruzione delle gallerie da Giardinetti a San Giovanni. Il pre-esercizio è iniziato dal 15 dicembre 2013, il tratto Pantano Centocelle doveva aprire nel giugno del 2014, doveva arrivare a piazza Lodi ad agosto 2014 e a San Giovanni nell’agosto 2015[22]. Invece il tratto Pantano – Centocelle ha aperto il 9 novembre 2014, è di Km 13 di cui 4 interrati con 15 stazioni. Ogni treno ha sei vagoni con 204 posti a sedere e 1.200 posti totali. Seconda e quinta carrozza per bici (come nelle altre metro dalle 5,30 alle 7 e dalle 10 alle 12) e disabili, per ora passaggi ogni 12 minuti, chiude alle ore 18,30. Il deposito e la dirigenza centrale operativa è a Graniti sulla via Casilina, ha un’estensione di 217.000 mq. Si parla di un prolungamento verso Est fino alla Farnesina e addirittura sulla Cassia; verso Ovest si pensa ad una deviazione da Teano (incrocio stazione Togliatti) fino a Ponte Mammolo.
La stazione San Giovanni dovrebbe aprire nell’autunno 2016.
Durante i sondaggi del terreno fatti dalla soprintendenza, prima dell’avvio del cantiere della metro C, in via La Spezia, angolo via Altamura, è stata trovata un’ampia rete di canalizzazioni ad uso agricolo. Alcuni elementi fanno pensare ad un frutteto con alberi di pesche attivo tra l’età repubblicana e il III secolo, nonché resti di una ruota dell’acqua per il sollevamento dell’acqua stessa.
BIBLIOGRAFIA
- AA.VV. Guida d’Italia, Roma, ed. Tci, 1993.
- AA.VV. Roma, libri per viaggiare, ed. Gallimard – Tci, 1994.
- AA.VV. I rioni e i quartieri di Roma, ed. Newton & Compton, 1989.
- AA.VV. Le strade di Roma, ed. Newton & Compton, 1990.
- Claudio Rendina (a cura di), Enciclopedia di Roma, ed. Newton & Compton, 2005.
- Stefania Quilici Gigli, Roma fuori le mura, ed. Newton, 1986.
SITOGRAFIA
www.comune.roma.it
www.archeoroma.beniculturali.it
www.sovraintendenzaroma.it
www.romasegreta.it
www.romasparita.eu
Per lo Statuario:
it.wikipedia.org alla voce Appio Claudio
signaziodiantiochia.wordpress.com
vicariatusurbis.com
Per il Quarto Miglio:
it.wikipedia.org alla voce Appio Pignatelli
biblioteorema.wordpress.com
santarcisio.org
vicariatusurbis.com
[1] Via Appia primi del Novecento. Descrizione di Giuseppina Pignatelli Della Leonessa, in AA. VV. I nonni di Roma raccontano la storia, ed. Comune di Roma, 2006, pag. 41.
[2]Gregorio XIII (Ugo Boncompagni) papa dal 1572 al 1585. Nello stemma c'è un drago. Studente e poi docente all'Università di Bologna, fu maestro di Alessandro Farnese, Reginaldo Pole e Carlo Borromeo. Venne ordinato sacerdote a 40 anni. Riformò il calendario decidendo il salto dal 4 al 15 ottobre 1582. A Roma promosse la costruzione del Quirinale, della cappella Gregoriana in San Pietro,
terminò la chiesa del Gesù. Adattò alcuni ambienti delle terme di Diocleziano a granaio. Ha fondato la Pontificia Università Gregoriana erede del Collegio Romano. Permise la nascita del Conservatorio di Roma. Istituì la Congregazione Romana dell'Indice organo slegato dalla biblioteca Vaticana. La sua tomba è in san Pietro, navata destra, terzo passaggio a destra. Il medico di questo Papa rese celebre la fonte dell'Acqua Santa.
[3] Tullio Rossi. (Roma 1903 – Milano 1997) Dopo la laurea in architettura lavorò nello studio di Busiri Vici, collaborò nel restauro di villa Spada, progettò ville a Forte dei Marmi, a Cortina, il comprensorio di Calamoresca a Porto Santo Stefano. Vinse il concorso per il restauro di Ponte Vecchio a Firenze. Redasse il piano paesistico dell’Olgiata e numerose ville in quel comprensorio tra il 1960 e il 1963. Realizzò circa 50 chiese a Roma come architetto della Pontificia Opera Nuove Chiese, tra queste la Natività di via Gallia, San Tarcisio al Quarto Miglio nel 1939, San Giovanni Battista de Rossi nel 1940, Santa Maria della Fiducia a Finocchio nel 1940, Santa Maria delle Grazie a via Angelo Emo, San Francesco e Santa Caterina da Siena patroni d'Italia alla circonvallazione Gianicolense, Regina Pacis a Monteverde Vecchio, Santa Galla alla circonvallazione Ostiense, Sant'Emerenziana al quartiere Trieste, di Santa Maria Assunta in via Capraia al Tufello ma è anche la parrocchia del complesso Icp Vigne Nuove, la chiesa di Santa Maria Causa Nostra Letiziae in piazza Siderera al Villaggio Breda, sulla Casilina, altezza Grotte Celoni (da Irene de Guttry, cit. e casa della architettura.it). Di ben diverso tenore è la chiesa di Santa Maria Goretti nella via omonima al quartiere Trieste del 1956.
[4] Alessandro Monteleone. (Taurianova, Reggio Calabria 1897 - Roma 1967) principalmente scultore, titolare della cattedra di scultura all'Accademia di Roma. Con Nagni ha realizzato una delle porte di San Pietro. Ha lavorato nella chiesa di Don Bosco a Roma oltre che in questa di Sant’Ignazio di Antiochia.
[5]Damaso.San Damaso (366-384), portoghese, reliquie in san Lorenzo in Damaso. Nel 381 si tiene il concilio di Costantinopoli per condannare l’Arianesimo. Fu un papa molto colto che ricercò le tracce dei primi cristiani anche nelle catacombe.
[6] Madre Teresa di Calcutta. Skopie 1910 – Calcutta 1997. Anieze Gonxhe Bojaxhiu, religiosa albanese di fede cattolica, fondatrice della congregazione religiosa delle Missionarie della Carità. Per il suo lavoro tra le vittime della fame a Calcutta, l’ha resa una delle persone più famose al mondo. Ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1979 è stata proclamata beata da Giovanni Paolo II nel 2003.
[7] Fienile di Tor Fiscale. Questo paragrafo è tratto da: Maria Letizia Sementilli, Il patrimonio archeologico della IX Circoscrizione, Comune di Roma, 1988, pag.75.
[8] Casale Rampa. Il paragrafo tra virgolette è preso da: Sementilli, Il patrimonio archeologico della IX Circoscrizione, Comune di Roma, 1988, pag. 76.
[9]Pier Luigi Nervi. (Sondrio 1891-Roma 1979) ingegnere italiano socio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, autore di alcune grandi opere. Ha collaborato con architetti di fama internazionale come Le Corbusier e Louis Kahn.
Laureatosi in ingegneria all'Università di Bologna nel 1913, lavorò per una società di costruzioni, durante la prima guerra mondiale fu nel genio. Nel 1923 fondò la sua impresa di costruzioni, l'anno dopo sposò Irene Calosi da cui ebbe quattro figli, tre di loro lo affiancarono nel lavoro. La sua prima opera fu il ponte sul fiume Cecina presso Pomarance (PI) nel 1920 (demolito nel 2001 dall'ANAS), ma il primo lavoro a destare interesse internazionale fu lo stadio di Firenze Campo di Marte oggi Artemio Franchi con le particolari scale elicoidali e la torre (1930). Realizzò degli hangar in legno e metallo a Pantelleria (unico rimasto), Orbetello, Marsala e Orvieto. Con una struttura geodedica riduceva i punti di appoggio aumentando le luci interne. Nel dopoguerra, insieme a Bruno Zevi, Luigi Piccinato e Mario Ridolfi, fondò l'Associazione per l'Architettura Organica (1945). Nel 1950 realizzò lo stabilimento Kursaal ad Castel Fusano. Tra il 1953 e il 58 realizzò la sede dell'UNESCO a Parigi. Tra il 1945 e il 1962 fu professore incaricato di Tecnica delle Costruzioni nella facoltà di architettura della Sapienza. Tra il 1956 e il 1961 collaborò alla realizzazione del grattacielo Pirelli a Milano e per le Olimpiadi di Roma del 1960 lavorò al Palazzetto dello Sport, allo stadio Flaminio, il viadotto di corso Francia e al Palazzo dello Sport all'Eur. Nel 1961 progettò il Palazzo del Lavoro a Torino (disegno architettonico di Giò Ponti) per l'Esposizione del centenario dell'unità d'Italia. Nel 1962 progettò la stazione ferroviaria di Savona. Nel 1964 progettò l'Aula delle Udienze in Vaticano (realizzata tra il 1966 e il 1971), oggi aula Paolo VI, ma nota a tutti come Aula Nervi (con la Resurrezione di Pericle Fazzini). Nel 1967 il palazzo della Banca d'Italia in via Tuscolana. Nel 1976 progettò l'ambasciata italiana a Brasilia.
[10] Il progetto di Nervi. Questo episodio da: AA.VV. Il patrimonio culturale del IX Municipio.
[11] Velodromo Appio. Tutte le notizie da: Trentagiorni, n. 15 articolo a firma di Ottavio Bigiaretti. Interviste a Nicola Tucci e Americo Raoli. Secondo altre fonti il Motovelodromo Appio fu costruito nel 1921. Ma anche it.wikipedia.org alla voce Motovelodromo Appio afferma che risale al 1910, era anche conosciuto con il nome “Cessati Spiriti”.
[12] 1979. Sindaco Giulio Carlo Argan.
[13] Mercato dell’Alberone. La notizia della nascita del mercato collegata alla cinta daziaria e quella di Fiorucci è tratta dal libro di Paolo Montanari, Appio Latino Tuscolano, ed. Europa, 2015, pag. 52. Secondo Roberto Bruschi, in data 13.2.16, il negozio di Fiorucci quello alla sua destra, era dove oggi è l’Acqua e Sapone. Il sig. Bruschi sostiene che anche la palazzina dell’Acqua e Sapone come quella ad angolo di via Carlo Sigonio, già sede della DC, sono tutt’ora proprietà dei Fiorucci
[14] Camillo Palmerini. (Roma 1893 - 1967) Ha progettato le case Icp a Ostia in corso Duca di Genova nel 1929, di fronte alla scuola Fratelli Garrone di Ignazio Guidi. Da: De Guttry.
Per il testo "Archivio storico iconografico dell'IACP" ha progettato le case popolari a Testaccio con fronte su via Vespucci tra gli anni 10 e 20; la Borgata Giardino Garbatella, lotto XII, fabbricato 5 in via F. Passino; lotto XIII tipo T, fabbricato 4 di via F. Vettor; Progetto Appio I in piazza Tuscolo, via Soana, via Astura; Progetto Appio II in via La Spezia; Progetto Ponte Lungo II, lotto I B fabbricato 1 in piazza dell'Alberone.
[15] Villa Colonna. Nella carta di Roma del 1911 consultata alla biblioteca Appia oggi Mandela di via La Spezia la villa risulta con il nome di Corvisieri.
[16]Chiesa di Ognissanti. “Dal manoscritto che sto ultimando su "I Ragazzi di Via Cerveteri". Ognissanti è stata la mia parrocchia.. Di seguito ho scritto anche della prima messa in italiano di Paolo VI. Era stato Papa Pio X Sarto ad affidare al sacerdote Luigi Orione dei Figli della Divina Provvidenza la cura spirituale del nuovo quartiere. Era il dicembre del 1908 quando il Pontefice inviò don Orione fuori Porta San Giovanni, tra le baraccopoli sorte a ridosso delle mura Aureliane. Il sacerdote iniziò la sua attività in un modesto oratorio di Via Alba da ove iniziò a raccogliere tra i fedeli i fondi, per la nuova chiesa. Anche il Papa partecipò alle donazioni. Egli non si limitò alla costruzione del luogo di culto ma creò anche strutture d’incontro come una sala teatro e un campo da gioco. E’ qui che saranno ospitati alcuni degli orfani vittime del terremoto della Marsica” del gennaio 1915 che causò 30.519 morti. Scritto da Felice Cipriani sulla pagina facebook “Sei dell’Alberone se…” il 18.12.15.
[17] Don Luigi Orione (Pontecurone presso Tortona AL 1872 – San Remo 1940) di padre selciatore di strade, allievo dell’oratorio di Valdocco di Torino fu notato da Don Bosco. Ordinato sacerdote nel 1895, aprì nuove case a Noto, a San Remoe Roma. Nel 1903 il vescovo di Tortona riconobbe canonicamente la Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza. Accorse a soccorrere i terremotati di Reggio Calabria e Messina per il terremoto del 1908 che fece 90.000 morti. Nel 1913 inviò una missione in Brasile. Soccorse i terremotati della Marsica nel 1915. Dopo la prima guerra mondiale si moltiplicarono scuole, collegi, colonie agricole e opere assistenziali. Nelle periferie fece sorgere i Piccoli Cottolenghi. Fondò il Santuario della Madonna della Guardia a Tortona dove è sepolto. Morì a San Remo il 12 marzo 1940. Nel 1980 Giovanni Paolo II lo iscrisse tra i Beati. Proclamato santo dallo stesso Papa nel 2004. “Il suo motto era: Ave Maria e avanti”. Da pagina facebook Sei dell’Alberone se… “Una rimessa di cavalli venne trasformata in chiesuola. Come fare per portarvi le persone? Don Orione percorse le strade del quartiere scuotendo un grosso campanello e facendo cadere ogni tanto qualche caramella e qualche soldino fino a che una piccola folla iniziò a seguirlo. Don Orione li portò in chiesa”. Da: Angelo Bertuzzo in Sei dell’Alberone se…
[18] Tram di cinecittà. La frase tra virgolette è riportata da: “Marco Lodoli, Quel viaggio fantastico sul tranvetto di Fellini” in la Repubblica, cronaca di Roma, del 25.5.14.
[19] Saltarello. Ballo tipico dell’Italia Centrale, si presenta come danza di coppia. E’ di origine rinascimentale, nel Seicento si diffuse negli ambienti popolari. E’ stato ripreso nell’ultimo movimento della Sinfonia opera 90 di Felix Mendelsshon (compositore tedesco dell’Ottocento).
[20] Festival della Canzone Romana. Al primo concorso del 1891 vinse il motivo che Ilario Calzelli aveva dedicato alle streghe: “Si tutte le streghe so’ come sei te, nun ho più pavura le voijo vedè…” interpretata da un giovanotto del rione Trevi Leopoldo Fregoli. Il cinema Massimo sarà in funzione fino al 1962, rappresenterà un punto di riferimento e di incontro per gli artisti che cercavano lavoro in un contesto territoriale già popolare nel mondo del cinema per la presenza degli stabilimenti Cines di via Veio, quelli di Virginia Genesi in via Marruvio, la SAFA di via Mondovì, la Boschi di via Saluzzo 16, la Caesar Film poi Scalera, poi Titanus in circonvallazione Appia e la Tecnostampa oggi Fono Roma in via Ceneda 8. Tra i film girati nel quartiere ricordiamo “Sotto il sole di Roma” di R. Castellani del 1945 e “Un amore a Roma” di Dino Risi nel 1960, girato proprio negli interni del cinema Massimo. Nella Safa di via Mondovì venne girato “Ladri di biciclette”.
[21] Metro A. Tutte le notizie da it.wikipedia.org e la Repubblica, cronaca di Roma.
[22] Metro C. Tutte le notizie da: La Repubblica, cronaca di Roma, alle date del7.7.06, 7.7.10, 3.7.11, 13.7.13, 31.8.13, 21.11.13.
Piero Tucci
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
LEGGENDE E RACCONTI
POPOLARI DI ROMA
ROMA E' UNA CITTA' RICCA DI STORIA
MA ANCHE DI LEGGENDE E TRADIZIONI POPOLARI
SCOPRIAMO ALCUNE
INTRODUZIONE
Il termine folclore deriva dall'inglese folk = popolo e lore = sapere e si riferisce all'insieme delle tradizioni arcaiche provenienti dal popolo, tramandate oralmente e riguardanti usi, costumi, leggende, proverbi, musica, canto, danza, riferiti ad un popolo di una determinata area geografica.
Lo studio delle tradizioni popolari e dunque del folclore ha inizio con l'invasione napoleonica dell'Italia, nel neonato regno d'Italia viene avviata una inchiesta su questo insieme di aspetti con lo scopo di estirpare i pregiudizi e le superstizioni che esistevano soprattutto nelle campagne. Gli atti di questa inchiesta e le relative illustrazioni sono custoditi nel castello Sforzesco di Milano.
La prima opera di rilievo, che anticipa di cinquant'anni il metodo scientifico sullo studio del folclore si deve a Michele Placucci, questi nel 1818 pubblica a Forlì "Usi e pregiudizi dei contadini romagnoli", ad esempio si racconta che i contadini romagnoli mangiavano fave nell'anniversario dei morti (2 novembre) perchè si riteneva che questa pianta avesse il potere di rafforzare la memoria e così nessuno dimenticava i propri morti.
L'intellettuale che ha dato poi origine allo studio sistematico, su base scientifica del folclore è stato il medico palermitano Giuseppe Pitrè (1814-1916) che ha condotto una ricerca inusperabile sulle tradizioni popolari siciliane prima e su quelle italiane nel 1894. A lui si deve una rivista che venne pubblicata per 27 anni fino al 1909.
Durante il fascismo questo tipo di studi venne utilizzato dalla propaganda per creare il mito romantico del popolo e per creare una idea di popolo compatta unita sotto i suoi capi.
Dopo la seconda guerra mondiale ebbe grande impatto la pubblicazione dei Quaderni del Carcere di Antonio Gramsci per il quale la conoscenza e lo studio delle tradizioni popolari sono elemento fondante per dare coscienza di classe al popolo ancora lontano dall'istruzione. Scrive Gramsci: "il folclore è la visione del mondo delle classi subalterne, non consideratelo una bizzaria, una stranezza, un elemento pittoresco, ma una cosa molto seria, da prendere sul serio".
A Roma esiste il museo delle Arti e Tradizioni Popolari, è un luogo meraviglioso dove portare i bambini, ma non solo, per conoscere come vivevano i nostri nonni e le ultime generazioni che ci hanno preceduto. Vi sono raccolti gli strumenti del lavoro agricolo e pastorale, i mezzi di trasporto precedenti al motore a scoppio, i manichini con le maschere di Carnevale delle varie regioni e città italiane, le marionette e i pupi siciliani, i manichini con i vestiti tipici delle varie regioni italiane. Vere e proprie opere d'arte sono i presepi napoletani del Settecento. Il museo si trova all'EUR in piazzale Marconi 8.
Oggi lo studio del folclore è materia di studio universitaria sotto il nome di antropologia culturale.
LA LEGGENDA DELLA PAPESSA GIOVANNA
via di San Giovanni in Laterano
rione I Monti e rione XIX Celio
Nel nord Europa viveva una volta un principe che aveva tre figlie. Un giorno in cui era molto triste chiese alla figlia più grande: "Quanto mi vuoi bene?" ed ella "Quanto è grande il mare", poi chiese alla seconda: "Quanto mi vuoi bene?" e la seconda: "Quanto è grande il cielo", infine fece chiamare la più piccola, di nome Giovanna, a cui rivolse sempre la stessa domanda e questa rispose: "Ti voglio bene come al sale". Il padre rimase stupito e irritato, "Ma che risposta è mai questa...", davanti alla ostinazione di Giovanna la cacciò di casa.
Ormai sola e senza nessun aiuto si tagliò i capelli, si sporcò il volto di fuliggine e decise di presentarsi a tutti come un ragazzo. Chiese aiuto ad un convento, qui fu accolta, studiò tanto che in poco tempo divenne il novizio più colto della comunità. Giovanna, ormai per tutti Giovanni, girò per le migliori università d'Europa lasciando meravigliati tutti coloro che la ascoltavano per la sua cultura e la sua saggezza. Un giorno il vescovo di Magonza le chiese: "Qual è per te il dono più prezioso che lo spirito santo può dare ad un uomo?", "E' il sal sapientiae, il sale della sapienza, o Eminentissima Eccellenza" rispose subito Giovanna, ed ebbe subito l'approvazione del vescovo. Così in poco tempo fu nominato vescovo e poi anche cardinale.
Alla morte del papa il Conclave non riusciva a trovare un degno successore di Pietro, stremati da lotte intestine i cardinali deciso di scegliere un uomo di grande dottina, un saggio, quindi il nostro Giovanni-Giovanna.
Una volta entrata in possesso dei suoi poteri, si stabilì in Laterano, si dedicò ai suoi amati studi, licenziò gran parte della sfarzosa corte papale ma tenne presso di se un cameriere giovane e bello a cui faceva leggere le Sacre Scritture quando non voleva stancarsi gli occhi. Questo cameriere si chiamava Montersino. I due entrarono in grande confidenza, al giovane cameriere il Papa sembrava una donna, i suoi sospetti erano iniziati dal momento che appena eletto aveva fatto una legge per cui il Sommo Pontefice si doveva vestire da solo.
I sospetti aumentavano sempre di più finchè un giorno decise di rivolgersi ad un eremita che aveva fama di santità e saggezza. Questi gli disse: "Se vuoi sapere se una persona è uomo o donna, portala in una sala d'armi. Se tira dritto è una donna, se si ferma a maneggiarle è un uomo". E così qualche giorno dopo Montersino disse al papa che i Mori incombevano a largo di Anzio, bisognava controllare l'armeria. Anche qui il Papa si comportò da vero uomo, controllando con attenzione e competenza tutte le armi.
Una sera dopo cena il Papa volle che Montesino gli leggesse un pezzo della Bibbia dove si parla di Giacobbe che lotta con l'angelo ai piedi della scala. Il Papa disse: "L'angelo era femmina sicuramente, poichè ognuno di noi ha un angelo guida di sesso diverso", il cameriere rimase interdetto a tanta sapienza, poi il papa continuò "Il mio angelo sei tu, ad esempio".
Dopo tanto tempo Montersino aveva scoperto la verità, la papessa e il cameriere si amarono a lungo nella stanza segreta del Papa compiendo un sacrilegio e insieme portando a compimento un destino.
Un giorno, durante la processione del Corpus Domini tra San Pietro e San Giovanni, il corpo del Papa cominciò a contorcersi sotto la violenza dei dolori del parto e, proprio sullo stradone di San Giovanni, dove ora c'è una cappelletta, il Papa dette alla luce un papetto, sotto gli occhi sbarrati di ecclesiastici e popolo. Era il colmo della vergogna! La gente pareva impazzita, i sediari abbandonarono la sedia papale, tra le grida e il sangue la papessa Giovanna e il figlio furono linciati sul posto.
Di questa leggenda che si tramanda da secoli vi sono ovviamente varie versioni, anche perchè tutte queste si sono tramandate per via orale. Alcune versioni sono meno truculenti, alcuni narrano che nel finale sconvolgente, in mezzo a tanta confusione la papessa Giovanna, il suo innamorato e il bambino riuscirono a fuggire per non si sa dove.
Un'altra versione dice che si trattava di una bella ragazza inglese e che si era travestita da uomo per amore di un monaco benedettino. La stessa versione dice di essere stata il successore di papa Leone X (papa della famiglia Medici vissuto nel Cinquecento, per la storia il successore fu Adriano VI Florenz) e che una volta eletta prese il nome di Giovanni VII (è un papa dell'VIII secolo, di famiglia di funzionari imperiali).
Sembra che la leggenda sia sorta intorno alla metà del Duecento, nel Quattrocento si credeva che il corteo papale di intronizzazione - cioè la presa di possesso della cattedrale di Roma da parte del nuovo Papa - deviasse per via dei Santi Quattro Coronati per non passare nel punto dello scandaloso avvenimento. La leggenda è accreditata da uno storico Bartolomeo Platina[1] che scrisse: "Fu sepolta senza onori", anche Boccaccio e Lawrence Durrel la raccontarono e fu sfruttata dai protestanti per screditare il romano pontefice. Qualcuno collocò questa papessa Giovanna tra Leone IV (quello che fece costruire le mura intorno al Vaticano dette ancor oggi "Leonine") e Benedetto III.
La cappellina che ricorda il luogo dove avvenne il fatto incredibile e scandaloso si trova vicinissimo a via di San Giovanni in Laterano, esattamente in via dei Querceti angolo via dei Santi Quattro. La cappellina attuale risale al Settecento ed è dedicata alla Madonna.
Via dei Querceti si trova nel rione XIX Celio, prende il nome dall'aspetto arboreo che la zona aveva quando era chiamata Querquetulana. Venne chiamata anche vicus Papisse in onore di una donna della famiglia Papa che aveva delle proprietà nell'area, tale donna condusse una vita esemplare.
La via di San Giovanni in Laterano - per i romani lo "Stradone di san Giovanni" - era originariamente una strada stretta e tortuosa e fino alla fine del 1300 praticamente desolata. Costituiva l'ultimo tratto di quella via Papalis o Papae, ovvero il tratto percorso dal corteo pontificio per la "presa di possesso" che il nuovo Pontefice compiva di San Giovanni in Laterano. Venne ampliata e selciata da papa Sisto V che volle aprire una grande arteria di collegamento tra il Colosseo e il Laterano e poi di lì proseguire fino a San Pietro costruendo un nuovo ponte sul Tevere davanti ai Fiorentini.
SILVESTRO II IL PAPA MAGO
piazza San Silvestro
rione III Colonna
Il monaco Silvestro voleva ad ogni costo conoscere tutta la sapienza del mondo e dell'aldilà. Per questo giunse a Roma, città dove si trovano le reliquie più importanti della cristianità. Per raggiungere il sapere era disposto anche ad un patto con il demonio.
Un giorno passeggiava per Campo Marzio, assorto nei suoi pensieri, pensava alla sua terra, al freddo settentrione, un paese circondato da foreste e pianure sconfinate. Si ricordò di un uomo vecchissimo che viveva come un eremita, era sacerdote di una religione dimenticata, adorava la luna. A lui aveva confidato il suo grande cruccio, questi era rimasto a lungo in silenzio, poi gli aveva detto: "L'ombra ti svelerà il segreto. Cerca l'ombra". Il monaco chiese cosa voleva dire, ma l'eremita ripetè tre volte la stessa frase.
Quello stesso giorno, mentre passeggiava per Campo Marzio, il monaco fu molto colpito da una statua che si alzava in una piccola piazza. Rappresentava un guerriero o un giudice, era difficile dirlo, aveva il braccio destro proteso in avanti e il dito indice puntato a terra. Sull'elmo erano due parole latine: "Percuoti qui". Molti avevano colpito l'elmo, con le mani, con dei sassi, ma niente era successo. Notò che l'ombra del dito a terra era netta e precisa. Fece un segno in quel punto, lasciò passare il giorno e quando si fece notte, quando tutti erano andati a dormine e le strade erano vuote tornò in quella piazzetta. Si era munito di una pala, nel punto dove aveva fatto il segno, iniziò a scavare.
Ma al primo colpo di pala si aprì una voragine stretta e profonda, da essa partiva una scala di cui non si vedeva la fine. Senza alcun timore iniziò a scendere e si trovò in una grande e ricca sala. Al centro di essa sedevano su due troni un re con la maschera d'oro e una regina con la maschera d'argento. Il monaco rimase di sasso. Il re si alzò e disse: "Qui è sepolto il tesoro dell'imperatore Ottaviano. Il sapere che tu cerchi è tutto racchiuso in questo libro nero. Ma tu non puoi toccarlo. Io manderò con te un mio servo Nadir che ti leggerà quelle pagine meno oscure che anche tu, povero umano, puoi capire".
Nadir era vestito da saraceno, aveva un occhio storto, ma per il resto era una persona gradevole.
Poi si alzò la regina che gli diede un anello, era intrecciato d'oro, d'argento e di rame con sopra una stella fatta da due triangoli sovrapposti. Subito il monaco capì che era l'anello di re Salomone, con esso poteva capire il linguaggio degli animali.
Uscito dalla profondità della terra la voragine scomparve. Iniziò la vita del monaco con il servo Nadir. Quando il monaco rivolgeva delle domande a Nadir, questo apriva il libro nero e leggeva alcuni passi che la maggior parte delle volte rimanevano oscure. Ogni volta lo stesso copione: domande sensate e risposte insensate, o almeno così sembrava al monaco.
Un giorno in un giardino dell'Aventino udì alcuni uccelli parlare tra loro: "Silvestro non può rubare il libro nero perchè Nadir lo inseguirebbe ovunque", "Conosce il cammino nelle stelle, nessun essere che cammina per terra o nuota sull'acqua può sfuggirli, Nadir lo ritrova subito".
Silvestro si logorava al pensiero di non poter leggere il libro. Una notte prese una decisione estrema, rubò il libro e fuggì via. Nadir lo inseguì quasi subito, cerca e cerca, non riusciva a trovarlo, cercò ancora e niente. Il monaco si era aggrappato con le mani sotto le arcate di ponte Milvio, in modo da non stare nè sulla terra, nè sull'acqua, pendeva a mezz'aria. Nadir non trovandolo tornò nella reggia sotterranea, dal suo re.
Silvestro si mise a studiare il libro giorno e notte, molti aspetti gli erano oscuri, vi erano profezie incomprensibili, ma c'era scritto come fare per diventare ricchi, come essere validi consiglieri dei potenti, come vedere il passato e prevedere il futuro, come diventare Papa.
Così il monaco si fece eleggere Papa, assunse il nome di Silvestro II. Attraverso il libro nero adesso conosceva le leggi della fisica, quelle che regolano il movimento degli astri, ma aveva perso la sua anima.
A volte aveva delle orribili visioni. Adesso che papa Silvestro, il papa mago, possedeva il sapere, stava peggio di prima, conosceva tutte le brutture del mondo e queste gli pesavano addosso.
Allora decise di pentirsi, implorò pietà. Cominciò a pregare come gli aveva insegnato la madre da bambino. Capì che il bene e il male sono inestricabilmente confusi e che spetta all'anima del singolo distinguerli e fare una scelta.
Quando sentì giungere la sua ultima ora, papa Silvestro II, ormai semplice e buono come un bambino ordinò che appena morto il suo corpo fosse messo su un carro trainato da buoi, là dove il carro non guidato da umani si sarebbe fermato, lì doveva essere sepolto. Il carrò uscì da san Pietro e iniziò a fare il percorso che giunge a san Giovanni, lo stesso della incoronazione del Papa. Quando il carro giunse davanti alla chiesa di San Giovanni improvvisamente si fermò. Il papa mago fu sepolto in quella chiesa in segno perenne del perdono divino.
Nella navata intermedia destra della basilica di San Giovanni si può vedere il cenotafio di papa Silvestro II, opera del 1909. Ne fa parte un'antica iscrizione, si narra che quando si avvicina la morte di un Papa questa trasuda acqua e dal sepolcro si sente uno scricchiolar d'ossa. E' notizia storica che nel 1648, in occasione di lavori di restauro, l'arca venne aperta e il corpo del Papa venne trovato intatto con la tiara in testa e le vesti pontificali, a contatto con l'aria il corpo si dissolse in pochissimo tempo.
Secondo una versione di questa leggenda si narra che un diavolo suo amico gli annunciò che sarebbe morto quando avrebbe detto messa a Gerusalemme. Annullò così il pellegrinaggio in Terra Santa. Ma, avendo interpretato male la profezia, un giorno andò a dire messa in Santa Croce in Gerusalemme edificata sulla terra che proviene dalla Palestina. Segnò così la sua fine, si sentì mancare, fece in tempo a chiedere perdono, la sua fine è quella della versione precedente.
La piazza prende il nome dalla chiesa, eretta sulle rovine del tempio del Sole dell’imperatore Aureliano, da Stefano II e chiamata inter duos hortos perché era circodata da orti o in capite perché vi è conservata la reliquia della testa di San Giovanni Battista. L’aspetto attuale risale al 1595-1601, a Franceso da Volterra e Carlo Maderno. Domenico De Rossi è autore della facciata nel 1703. Il campanile è del 1210. La chiesa è officiata dai cattolici inglesi.
Il palazzo delle Poste centrali che vi affaccia sul lato Nord era già convento annesso alla chiesa di San Silvestro in Capite, adattato dall’arch. Malvezzi, con nuova facciata di gusto eclettico, ispirata a forme quattro cinquecentesche, di Luigi Rosso (1878). La facciata è ornata di eccellenti finestre bifore sovrastate da sei tondi in marmo con i membri di casa Savoia.
Al centro della piazza venne collocata la statua di Metastasio del Gallori, poi spostata ai primi del Novecento in piazza della Chiesa Nuova per motivi di traffico. La piazza è oggi tutt’uno con piazza San Claudio, ma fino agli anni Trenta vi erano dei palazzi che la separavano e furono abbattuti con i lavori di ampliamento del Corso.
Il Comune di Roma, in accordo con Atac, ha realizzato la pedonalizzazione della piazza con lo spostamento dei capolinea ad aprile 2012. Il restyling ha comportato nuovi lampioni in ghisa, sampietrini e panchine. Il costo è stato di 2 milioni di €, il tempo dei lavori – dalla consegna del cantiere – doveva essere di 10 mesi e la piazza doveva essere pronta per il concerto del 31 dicembre ma i tempi si sono dilatati a causa delle polemiche sul progetto stesso di ristrutturazione. La nuova piazza San Silvestro è stata progettata dall'architetto Paolo Portoghesi, autore della moschea di Roma nel 1974, del restauro del borgo di Calcata nella valle del Treja e della reggia di Amman in Giordania. La piazza è pavimentata con sampietrini, mentre al centro in direzione nord-sud c'è un passaggio in pietra serena. Il lato est della piazza presenta dei lunghi sedili in marmo che formano un ovale interrotto in quattro punti. Il lato ovest presenta dei lunghi sedili che formano un rettangolo anch'esso spezzato. L'architetto avrebbe voluto una fontana che è tipica delle piazze di Roma, mentre non sono previsti alberi, e questo è un fatto negativo perchè nelle caldissime giornate estive i sedili e la piazza sono impossibili da vivere. E' rimasto un corridoio per le macchine tra via della Mercede e il Corso, un'altro davanti a piazza San Claudio.
ARTEMISIA
piazza Capo di Ferro rione VII Regola
Viveva tanto tempo fa a Roma una giovane molto bella di nome Artemisia, era la figlia di un famoso pittore, Orazio, che era stato amico e seguace del Caravaggio. In quei tempi il padre era impegnato ad affrescare le sale del palazzo Borghese.
Artemisia crebbe in via della Croce, passava intere giornate nello studio del padre, era la sua modella preferita e posava spesso per lui nelle vesti di angelo. Un giorno quando il padre era uscito si accorse che aveva lasciato sul cavalletto una natura morta interrotta giorni prima: una melagrana che lasciava intravedere i semi vermigli, un liuto appena accennato si appoggiava a un libro aperto. Del quadro c'era solo l'impronta, quasi in trance Artemisia lo completò, nelle pagine aperte scrisse: "Sic transit gloria mundi". Quando il lavoro fu finito Artemisia si chiese cosa avrebbe detto il padre, quel padre burbero, di poche parole, capace di passare anche un giorno senza parlare. L'avrebbe punita? Non c'era la mamma a proteggerla, era morta quando lei aveva cinque anni e i fratelli erano troppo piccoli. Si nascose in un sottoscala, fece buio, il padre non arrivava. Finalmente sentì aprire e chiudere la porta, poi una esclamazione che non prometteva nulla di buono: "Accidenti! Artemisia! Artemisia! Sei stata tu! Dove ti sei cacciata? Vieni fuori!". Si fece coraggio, uscì dal nascondiglio, andò verso il padre e disse: "Sono qui padre, perdonatemi! Non volevo!| Non volevo!". Ma il padre la prese tra le braccia, la baciò, la carezzò e le disse: "Sei un'artista nata! Non dovrai più posare per me, io ti insegnerò tutti i segreti della pittura, hai fatto una meraviglia, io stesso non avrei saputo fare meglio".
Da allora Artemisia divenne l'allieva migliore di Orazio. A quel punto il padre, desideroso di perfezionare la preparazione artistica della figlia, chiamò Agostino Tassi, detto lo Smargiasso, per insegnare la prospettiva alla giovane figlia. Artemisia aveva allora diciassette anni e dell'amore conosceva solo i sogni. Dipingeva le eroine della Bibbia e immaginava di essere una di queste. A volte immaginava di essere la regina di Saba che cerca di carpire, con sorrisi e carezze, al re Salomone i segreti della Divina Saggezza. Altre volte sognava di essere Rachele al pozzo di Charan, dove incontrò Giacobbe per la prima volta e subito lo baciò e non smise di amarlo fino alla fine dei suoi giorni. Giacobbe per poterla sposare fece il servo del suocero per sette anni, ma gli sembrarono sette giorni. Ma la storia che più le piaceva era quella di Ester, la bella figlia di Sion che andò sposa al Re dei Re Assuero. Nonostante il divieto Ester entrò nella sala del trono, quando vide Assuero cadde svenuta. Questi la raccolse da terra, la prese tra le braccia, le baciò gli occhi e la risvegliò con tenere parole.
Quando Agostino Tassi entrò nello studio del padre, fece un triplice inchino e subito ella sentì un brivido. Velocemente imparò la prospettiva. Un giorno Agostino le chiese di dipingere senza un modello, a lei sembrò impossibile, ma lui gli spiegò che sempre quando si dipinge si ritraggono le immagini che la propria mente produce. Pensò che era quello che lei stessa aveva fatto quando aveva completato il melograno.
Una notte Artemisia non riusciva a prendere sonno così decise di uscire di casa per fare quattro passi per via della Croce. Vide avvicinarsi verso di lei un uomo ubriaco, mal vestito, con tre donne di strada. Riconobbe in quell'uomo Agostino. Il giorno dopo Artemisia gli chiese perchè passava le notti in quel modo. Rispose che non c'è differenza tra le donne, una donna onesta è solo una donna che alza il prezzo, per una donna si paga sempre. Allora lui le chiese perchè non si era sposata, le rispose che il padre non voleva. Lui sostenne che il padre era innamorato di lei. A quel punto Artemisia si infuriò dicendo che il padre era onesto, e lui "questo è il suo prezzo".
Ormai Artemisia non dormiva più. Agostino, sempre gentile aspettava, finchè un giorno si gettò ai suoi piedi e le giurò eterno amore. Artemisia era giovane e si innamorò di lui, passarono una notte insieme. Purtroppo presto venne a sapere che il suo amante era sposato con figli, la sua famiglia era a Livorno. Caccio Agostino e nei suoi sogni cominciò a immaginarsi come la Maddalena, la donna perduta che si era pentita. Agostino invece desiderava come un matto la giovane, anzi ora che lei lo aveva cacciato la desiderava ancora di più. Pagò due sicari che per un migliaio di scudi promisero di uccidere la moglie.
Un giorno Artemisia stava ritoccando un quadro in cui si vedeva Susanna al bagno, le teneva compagnia la vicina, sora Tuzia, quando entrò di corsa Agostino Tassi annunciando alla vicina che il figlio maggiore aveva avuto un brutto incidente sul lavoro, era in pericolo di vita, aveva bisogno di lei. Subito sora Tuzia uscì di casa. Così il brutto ceffo ebbe campo libero, afferrò Artemisia, la spinse in camera da letto, le tappò la bocca. Artemisia gli graffiò il viso, gli strappò i capelli, lo morse fino a fargli uscire il sangue, ma non ci fu nulla da fare, con la violenza ebbe ragione di lei. Appena si fu liberata corse in cucina, prese un coltello di grandi dimensioni e si avventò sull'uomo, a tanto lui si aprì la camicia e disse: "Eccomi qua! Colpisci pure! Io ti amo veramente, tu sei solo mia!". Lo colpì di striscio ma non ebbe il coraggio di infierire. Artemisia piangeva perchè non riusciva a distinguere la verità dalla menzogna.
Da allora ogni notte Artemisia sognò di essere Giuditta che taglia la testa di Oloforne per salvare il suo popolo, gli ebrei. Ancora oggi si può vedere una splendida tela a Firenze, negli Uffizi, che rappresenta Oloferne sdraiato nel letto colto nel momento in cui Giuditta gli mozza il capo volto verso gli spettatori. Secondo la tradizione il volto di Oloferne è quello di Agostino Tassi, l'uomo che aveva fatto violenza a Artemisia Gentileschi.
Artemisia Gentileschi (Roma 1597 - Napoli 1652 circa) allieva del padre Orazio, lavorò tra Firenze e Roma e Venezia. Dopo il 1630 fu a Napoli dove ebbe influenza sullo sviluppo della pittura napoletana, soprattutto nella formazione di Stanzioni e Cavallino. Per qualche tempo lavorò a Londra. Fu ottima ritrattista, dipinse quadri religiosi o di soggetto biblico come la Giuditta di cui parla la leggenda oggi agli Uffizi, a Firenze. Una replica del quadro al museo di Capodimonte a Napoli.
Per la sua costante preziosità, il colore della pittrice è più intenso di quello del padre, più vivace il contrasto chiaroscurale come nel "Miracolo di San Gennaro" nel duomo di Pozzuoli. Tra le sue opere più importanti "La nascita del Battista" al Prado, Madrid, "Giuditta con la sua ancella" a palazzo Pitti a Firenze, "Susanna e i vecchioni" a Schonborn, l'"Autoritratto come allegoria della pittura" nella Royal Collection di Windsor.
Negli anni Settanta del Novecento diventò un simbolo del femminismo internazionale a partire dalla notorietà assunta dal processo per stupro da essa intentato, numerosi circoli le furono intitolati. Divenne simbolo di una donna impegnata a perseguire la propria indipendenza e la propria affermazione professionale contro i pregiudizi del proprio tempo.
A Roma nella galleria Spada, nel palazzo omonimo è conservata la tela "Madonna con Bambino" della pittrice. Un'altra sua opera è in palazzo Pallavicini Rospigliosi (sul Quirinale), un suo autoritratto è conservato in palazzo Barberini sede della Galleria Nazionale d'Arte Antica.
Nella piazzetta, compresa tra piazza della Quercia[2] e via Capo di Ferro si trova palazzo Spada. Fatto costruire dal cardinale Capodiferro al tempo di Paolo III da Giulio Mazzoni che ha riempito la facciata di stucchi: statue di personaggi romani, medaglioni, cartigli, armi gentilizie, la lotta tra centauri e lapiti, dei romani, dei marini, rendono questa facciata una delle più pittoresche di Roma. Nella cosiddetta sala del Trono si trova una colossale statua di Pompeo ritenuta quella ai cui piedi venne pugnalato Cesare, ritrovata in via dei Leutari, sugli stalli che sono simili a quelli del parlamento sabaudo di Torino, siedono i consiglieri di Stato perchè questa è la sede del Consiglio di Stato. Il palazzo fu venduto ai Mignanelli quindi agli Spada che nel 1632 lo fecero restaurare da Borromini che vi realizzò la galleria prospettica di poco più di otto metri con in fondo una statua di Marte di soli 60 cm ma sembra un colosso.
LA LEGGENDA DEL PAPA EBREO
via del Portico d'Ottavia
rione XI Sant'Angelo
Ancora oggi nelle case e nei vicoli del ghetto ebraico si racconta la leggenda del papa Ebreo. Tanto tempo fa in Germania, in una famiglia ebraica nacque Yeshuà, figlio di Samuel e di Lia. Era un bambino prodigio, a quattro mesi parlava, a due anni leggeva e scriveva e a tre anni giocava a scacchi con il padre che dopo qualche tempo gli insegnò la "mossa Samuel" inventata da lui stesso, formata da una combinazione di mosse del Cavallo sostenuto dalla Torre. Ma il bambino era veramente un prodigio negli studi, conosceva benissimo la Torah, il Talmud, i Commentari e la Misha. Anche in questo il suo maestro fu il padre, in questi studi molto presto lo superò, perchè gli bastava dare un'occhiata per imparare un lungo brano a memoria.
Sempre intento agli studi per molte ore al giorno, pian piano si accorse che la piccola comunità nella quale viveva non gli bastava più, era diventata troppo piccola per lui. Non c'era più nessuno che lo poteva battere nel gioco degli scacchi, nessuno poteva superarlo nel commentare la Bibbia. I suoi orizzonti erano troppo limitati se continuava a vivere in quel piccolo paese freddo del Nord della Germania. Pian piano il demone della vanità lo assalì, un uomo della sua cultura, della sua intelligenza se fosse stato tra i cristiani lo avrebbero fatto cardinale e forse anche Papa.
Improvvisamente, un giorno, abbandonò la casa del padre senza dire nulla a nessuno. Andò in una grande abbazia dove stava un teologo famoso e disse che si voleva convertire. Aveva da tempo studiato la Vulgata e quindi era in grado di seguire il catechismo, a volte si sostituiva al teologo nel dare spiegazioni dotte. Yeshuà venne ordinato sacerdote, quindi vescovo, infine cardinale. Erano tempi oscuri per la Chiesa, i papi venivano eletti tra i membri delle principali famiglie nobili e una volta assunta la carica pensavano solo agli interessi della propria famiglia. Giunse quindi il giorno che tutti i cardinali si riunirono in Conclave per eleggere un nuovo Papa, ai più sembrò giunto il momento di eleggere quello strano cardinale tedesco sempre dedito agli studi e alle discussioni teologiche.
Diventato Papa il nostro Yeshuà si mise all'opera per mettere ordine nella Curia romana, eliminò i parassiti e gli incapaci, chiamò intorno a se le persone meritevoli e oneste quindi iniziò a governare la Chiesa secondo verità e giustizia.
Giunto a questo punto della sua vita si accorse che lui, abituato a concentrarsi su problemi di estrema difficoltà teorica, era circondato da persone che si dedicavano soprattutto a problemi di politica e diplomazia. Sentì un grande senso di vuoto. Gli mancava tanto non poter disporre di un valido avversario nel gioco degli scacchi, gli mancavano i piatti che gli cucinava la madre, donna umile e buona, gli mancava Rachel, la ragazza che avrebbe dovuto sposare nel suo lontano paese e pensava che forse ora era diventata la moglie del fornaio che tanto la corteggiava, forse avrà avuto dei figli con lui, sarà felice!
Un giorno giunse alle orecchie del Papa che si trovava a Roma un pellegrino tedesco, non cristiano, bensì ebreo, era un rinomato giocatore di scacchi, girava il mondo alla ricerca del figlio. Il Papa volle riceverlo e giocare con lui una partita. Nella sua strategia di gioco mise in atto la "mossa Samuel", ma nel punto decisivo il pellegrino mise in atto la contromossa, con gli occhi sbarrati dalla meraviglia il Papa perse la partita. Subito si abbracciarono, quel misterioso giocatore di scacchi era il padre. Tra le lacrime Ueshuà disse: "Padre, perdonami, vengo via con te, torniamo al nostro piccolo e caro paese". Ma il padre: "No figlio mio, resta! Che importanza hanno le parole e gli abiti? Sono apparenza, la voce di Dio parla alla tua anima al di là del frastuono delle parole e delle stesse preghiere". Il figlio capì che doveva rimanere nel suo ruolo, così avrebbe meglio onorato Dio e provveduto al meglio per i bisogni dell'umanità. Padre e figlio si abbracciarono, si salutarono e il vecchio padre tornò nel suo paese dove poco dopo si spense serenamente.
In effetti ci fu a Roma un papa di origine ebraica, era Anacleto II (1130-1138) della famiglia Pierleoni, il cui antenato Baruch, era venuto a Roma verso l'anno 1000. La famiglia dei Pierleoni hanno le loro case in piazza della Bocca della Verità e una torre all'angolo tra via del Teatro di Marcello e vico Jugario.
Via del Portico d'Ottavia inizia da piazza Costaguti e arriva a lungotevere de' Cenci anche se da pochi anni l'ultimo tratto è diventato largo 16 ottobre 1943 e ancor più vicino al lungotevere piazza Gerusalemme. E' stato per secoli e lo è ancora oggi il cuore del ghetto ebraico di Roma. Prende il nome dal grandioso portico fatto costuire da Augusto come accesso al teatro di Marcello e dedicato alla sorella Ottavia. Nel medioevo vi si teneva il mercato del pesce per cui si chiamava via di Sant'Angelo in Pescheria. Nel 1926 venne alla luce la trecentesca casa che ora è sede della Ripartizione alle Antichità durante i lavori per liberare il teatro di Marcello dalle costruzioni accomulatesi nei tempi.
Il Portico d'Ottavia era un doppio colonnato rettangolare che presentava al centro un'area aperta con due templi: Giunone e di Giove, nel lato di fondo si trovava un edificio absidato detto Curia Ottavia con biblioteca. Sotto il portico ben 34 statue equestri di bronzo di Lisippo, raffiguranti Alessandro Magno e i suoi ufficiali morti nella battaglia di Grafico, inoltre c'era la statua di Cornelia, la madre dei Gracchi, la cui base è ora ai Capitolini. Nel Medioevo, sulle rovine del portico, furono edificati un grande mercato del pesce ed una chiesa, Sant'Angelo in Pescheria. La chiesa fu edificata da Teodoro, zio di papa Adriano I Colonna, come rivela un'iscrizione conservata al suo interno. Inizialmente intitolata a san Paolo, dopo il miracolo dell'apparizione dell'arcangelo Gabriele sul monte Gargano Bonifacio II la intitolò all'angelo. Da questa chiesa mosse Cola di Rienzo per la conquista del Campidoglio il giorno di Pentecoste del 1347, qui gli ebrei erano costretti a frequentare la predica dei gesuiti. Celebre la lapide che impone di consegnare la testa dei pesci maggiori di una certa lunghezza ai Conservatori.
IL MARCHESE DEL GRILLO
piazzetta del Grillo
rione I Monti
Il marchese Onofrio del Grillo è una figura storica realmente esistita nell'Ottocento, un bulone ai limiti della legalità, sordo ad ogni senso di giustizia, prevaricatore verso gli ebrei che, alla fine si ravvide di tutti i mali combinati per dare ascolto alla sua coscienza. Oggi la sua popolarità è dovuta al celebre film con Alberto Sordi del 1981 dal titolo: "Il marchese del grillo"[3].
Nato a Fabriano nel 1714 si trasferì a Roma dove divenne ricchissimo per una eredità, così entrò nella Corte Pontificia e vi divenne celebre per il suo carattere eccentrico. La fama dei suoi colossali scherzi si diffuse in tutta Roma e fu ampliata dalla voce popolare che probabilmente fuse episodi appertenuti a personaggi diversi. Ritiratosi nella villa di famiglia a Fabriano (che tutt'ora esiste), vi trascorse gli ultimi anni della sua vita, si spense nel 1787, riposa in San Giovanni dei Fiorentini. Resta quindi un divario tra la figura storica che ha occupato tutto il Settencento e quella leggendaria a cui si è ispirato il film di Mario Monicelli che invece è riferita all'Ottocento, precisamente al periodo dell'occupazione napoleonica di Roma.
Nei racconti popolari ci appare come un uomo di mezza età annoiato da una vita di lussi tra il soglio papale chiaramente decadente e una plebe povera e senza speranza di emancipazione. Non perde mai l'occasione di tirare qualche brutto scherzo alla plebe che essendo in una posizione inferiore nulla può contro la nobiltà. Getta monete a due povere zingare, ma queste sono state rese incandescenti sul fuoco. Si rifiuta di pagare il falegname ebreo, chiamato in giudizio corrompe i giudici e il povero falegname è condannato, allora fa suonare a morto tutte le campane delle chiese di Roma, la gente pensa che sia morto il Papa, mandato a chiamare da Pio VII Chiaramonti gli rivela lo scherzo, "la giustizia è morta". Tira un brutto scherzo al carbonaio Gasperino, suo sosia, lo mette al suo posto, viene catturato dai gendarmi per alto tradimento, ma all'ultimo può beneficiare dell'amnistia e torna al suo posto.
La famiglia del Grillo risiede tutt'ora nello storico palazzo seicentesco collegato con un sovrappasso a una torre medioevale. Il palazzo è costituito da una facciata e due avancorpi laterali: quello di sinistra collegato tramite un sovrappasso ad arco detto "dei Conti". Presenta cinque piani ed ingloba l'antica torre medioevale, mentre il palazzo di destra ha tre piani. La torre detta anche della Miliziola per distinguerla dalla più grande torre delle Milizie, fu edificata nel 1223 come proprietà dei Carboni, poi dei Conti, finchè nel 1675 fu acquistata dai del Grillo che la ristrutturarono nel contesto del palazzo aggiungendovi l'originale coronamento a beccatelli come indica l'epigrafe commemorativa "Ex marchione de Grillis" Le finestre presentano sia decorazioni con volute e fregi, sia teste di leone, sia conchiglie. Un magnifico portale barocco al civico 5 è decorato da una doppia conchiglia sovrastata da una protome leonina dalla quale dipartono due festoni. Uno scalone porta ad un piccolo giardino ricco di fontane e ninfei di stucco. Nel giardino un altro portale con quattro colonne affiancate dalle statue di Minerva e Mercurio. Nel secondo dopoguerra ha ospitato lo studio e l'abitazione del pittore neorealista Renato Guttuso che vi è morto nel 1987.
Sul lato opposto della piazza si trova la Casa dei Cavalieri di Rodi che insiste sul Foro di Augusto, è opera quattrocentesca voluta dal cardinale Marco Barbo nipote di Paolo II. Dalla piazzetta si intravede una grandiosa muraglia bugnata di blocchi di peperino alternati a fascioni in travertino, era la cinta del foro e rappresentava una barriera antifuoco per gli incendi che spesso scoppiavano in questa parte della città antica detta Suburra.
STORNELLATA
rione XIII Trastevere
cerca un vicolo o una piazzetta di Trastevere
dove ambientare questo stornello
Fino all'invenzione della radio era difficile sentire per le strade di Roma la musica, ma vicoli e piazzette risuonavano delle voci delle persone che gridavano, si chiamavano, cantavano. C'erano i venditori ambulanti che richiamavano l'attenzione delle donne vantando i pregi delle loro merci, il vociare dei bambini che giocavano, il rumore dei carri sul selciato, le donne che cantavano le ninne nanne o ripetevano a mente le filastrocche, c'erano i ragazzi che corteggiavano le ragazze.
E a proposito di corteggiamento non era raro imbattersi in una stornellata che un ragazzo rivolgeva alla propria amata. Qualche semplice strumento musicale accompagnava il canto dello spasimante, più raramente c'era un cantante "professionista".
In omaggio a questo tempo andato immaginiamo di trovarci di fronte ad un duetto a cui alla voce maschile risponde una femminile. Questa stornellata tramandata a voce è stata trascritta da Gigi Zanazzo[4] e da Mario Menghini[5].
Uomo
E io de li stornelli ne so tanti,
Ce n'ho da caricà ttre bastimenti,
Chi ne sa più de me se faccia avanti
Donna
Io de li stornelli che ne so' 'n zacchetto,
Se me li metto in collo nun li porto
Se mi li metto a ddì nun ciarizzecco.
Uomo
E ppe cantà ce vo' la rigolizzia;
Pe' ffa l'amore ce vole la grazzia
Masticata con 'n po' de malizzia.
Donna
Chi ccanta per amore e cchi pe' rabbia;
a mme me fa cantane la superbia,
C'ho cento capi come la vitarba.
Uomo
Bbella, che tte piaceno li canti,
Ffaccet'a la fenestra si ce senti
E nun avè paura de toni e llampi.
Donna
L'ucello in gabbia:
Si ccanta la matina co' la nebbia
Nun canta per amor, ccanta pe' rabbia.
De canzoncine io ne so un sacco,
Si me le metto al collo nu' le porto,
Ne fo un fagottello sott'er braccio.
Uomo conclude
E vvoi che ssete mastra de stornelli
Ve voijo regalà du' portogalli[6]
Famo la conta a chi li sa più bbelli.
E cchi nun vvò sentì questa mi' voce
S'attureno l'orecchie co' la pece,
Fino ch'arriva er prete co' la croce.
Santa Maria Maggiore è tutta d'oro,
Tu ccanti le canzone e io l'imparo
Tu butti li sospiri e io m'accoro.
BIBLIOGRAFIA
- AA.VV. Guida d’Italia, Roma, ed. Tci, 1993.
- AA.VV. Roma, libri per viaggiare, ed. Gallimard – Tci, 1994.
- AA.VV. I rioni e i quartieri di Roma, ed. Newton & Compton, 1989.
- AA.VV. Le strade di Roma, ed. Newton & Compton, 1990.
- Claudio Rendina (a cura di), Enciclopedia di Roma, ed. Newton & Compton, 2005.
- Giorgio Carpaneto, I palazzi di Roma, ed. Newton & Compton, 1991.
- Mariano Armellini, Le chiese di Roma, ed. Pasquino, 1982.
- Carlo Zaccagnini, Le ville di Roma, ed. Newton Compton, 1991.
- Willy Pocino, Le fontane di Roma, Newton & Compton, 1996.
- Giuliano Malizia, Gli archi di Roma, ed. Newton Compton, 1994.
- Giuliano Malizia, Le statue di Roma. Storia, aneddotti, curiosità, ed. Newton Compton, 1996.
- Mauro Quercioli, Le mura e le porte di Roma, ed. Newton Compton, 1993.
- Sergio Delli, I ponti di Roma, ed. Newton Compton, 1992.
- Carlo Villa, Le strade consolari di Roma, ed. Newton Compton, 1995.
- Alessandro Tagliolini, I giardini di Roma, ed. Newton Compton, 1992.
- Mario Spagnol e Giovenale Santi, Guida ai misteri e segreti di Roma, ed. Sugarco, 1992.
- AA.VV. Enciclopedia Universale, ed. Garzanti, 2003.
- AA.VV. Enciclopedia dell’Arte, ed. Garzanti, 2002.
- Roma ieri, oggi e domani, ed. Newton Compton.
- Forma Urbis, ed. Service Sistem.
- Capitolium, ed.
- AA.VV. Stradaroma, ed. Lozzi, 2005.
- AA.VV. Tutto Città, 2011/2012, ed. Seat.
SITOGRAFIA
www.comune.roma.it
www.archeoroma.beniculturali.it
www.museiincomune.roma.it
www.romasegreta.it
www.laboratorioroma.it
www.romasparita.eu
www.info.roma.it
www.abcroma.com
www.romanoimpero.com
www.archeoroma.com
www.amicidiroma.it
www.andreapollett.com
www.palazzidiroma.it
www.villediroma.com
www.romaspqr.it
www.tesoridiroma.net
www.iloveroma.it
www.romasotterranea.it
www.sotterraneidiroma.it
www.medioevo.roma.it
www.artemisiagentileschi.net
www.romanesco.it
www.vicariatusurbis.org
www.romanesco.it
www.repubblica.it
www.corriere.it
www.ilmessaggero.it
www.romatoday.it
www.ansa.it
www.viamichelin.it
www.tuttocittà.it
[1] Bartolomeo Platina (Piadena, Cremona, in latino Platina 1421 - Roma 1481) umanista e prefetto della biblioteca Vaticana. Celebre il quadro alla Pinacoteca Vaticana di Melozzo da Forlì "Sisto IV nomina il Platina prefetto della biblioteca". Ci ha lasciato un libro di biografie di papi, testi di filosofia e un curioso trattato di arte culinaria.
[2] Piazza della Quercia prende nome dalla chiesa di Santa Maria della Quercia voluta da Giulio II per ricordare l'omonimo santuario di Viterbo. Era sede della confraternita dei macellari.
[3] Film "Il marchese del Grillo" anno 1981, regia Mario Monicelli, Riccardo Billi è l'ebanista Piperno, Paolo Stoppa è il pontefice Pio VII, Flavio Bucci è il capo brigante don Bastiano, Cochi Ponzoni è il cognato conte Rambaldo,
[4] Gigi Zanazzo Luigi Antonio Gioacchino Zanazzo (Roma 1860-1911) poeta commediografo, antropologo e bibliotecario. Studioso delle tradizioni popolari romane e poeta romanesco è considerato con Francesco Sabatini il padre fondatore della romanistica. Alla sua scuola mossero i primi passi Trilussa e altri poeti della Roma di inizio Novecento. Una lapide con busto lo ricorda in via dei Delfini dove era la sua casa natale.
[5] Mario Menghini (Urbino 1865 - Roma 1945) storico ed erudito italiano, studiò il Risorgimento e la figura del Mazzini di cui curò l'edizione nazionale degli scritti con 60 volumi di epistolario. Diresse la sezione di storia contemporanea nell'Enciclopedia Treccani.
[6] Portogallo arancio, da: romanesco.it
Piero Tucci
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ROMA GLORIA E VERGOGNA
Il 21 aprile 2016 è stata inaugurata l’opera di William Kentridge “Triumphs and Laments”, uno spettacolare fregio lungo m 550 tra ponte Sisto e ponte Mazzini, sulla sponda destra del Tevere, là dove passa la pista ciclabile, una ottantina di figure alte fino a 10 metri. La tecnica di realizzazione dei graffiti o disegni è quella definita “per via di lavaggio”, si creano dei bianchi lavando la superficie dei muraglioni. Al massimo tra quattro anni scomparirà per l’azione dei batteri, per il trascorrere del tempo.
Per l’inaugurazione si è tenuta una performance con musiche originali composte da Philip Miller e Thuthuka Sibisi, una danza di ombre e due processioni musicali che ha visto coinvolti 40 musicisti e vocalisti.
Contemporaneamente al MACRO sono esposti 80 lavori preparatori, disegni e studi per questo grande lavoro. L’artista vi ha lavorato da circa un mese, l’idea è partita dall’associazione Tevereterno nel 2002, ci sono voluti 4 anni per ottenere i permessi e un anno e mezzo per realizzare i disegni preparatori. L’opera è stata realizzata con contributi privati.
L’opera si vede meglio dalla riva opposta del Tevere, si tratta di una sequenza di trionfi e tragedie dell’Urbe, non in modo cronologico: il corpo di Pasolini ucciso all’Idroscalo di Ostia, la Lupa capitolina, i rilievi della colonna Traiana, Giorgiana Masi, Giordano Bruno, la figura del Duce a cavallo, Remo primo martire di Roma, la Vespa di Vacanze romane, la scena chiave della Dolce Vita di Fellini ambientata in una vasca da bagno, il corpo di Aldo Moro nella Renault 4. E poi ancora imperatori e papi, Anita Garibaldi e Anna Magnani in Roma città aperta, le figure dell’Arco di Tito, il sarcofago Ludovisi (a palazzo Altemps), l’estasi di Santa Teresa.
E’ il più importante progetto di arte urbana realizzato in questi anni in Europa.
Piero Tucci
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
24.4.16
Bicincittà della Liberazione
PARCO CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943
Ci troviamo a San Lorenzo, lungo la via Tiburtina, in uno dei quartieri popolari di Roma per eccellenza, sorto a partire dal 1878 a sud della Tiburtina con destinazione popolare. Le case ripropongono in modo più dimesso l'eclettismo che caratterizzava i quartieri borghesi del tempo (Esquilino, Prati), mentre all'interno le esigenze di sfruttamento intensivo imposero in alcuni casi l'adozione della tipologia a ballatoio rara per Roma.
Il 19 luglio 1943 alle undici del mattino il quartiere fu colpito dal famoso bombardamento alleato, in varie ondate arrivarono 662 bombarieri e 268 caccia dalla Tunisia, Algeria e Libia. L’unica breve relazione italiana parla di 3.000 bombe sganciate e di oltre 2.000 morti e 2.000 feriti, in realtà si è accertato successivamente che i morti furono non meno di 3.000 (la metà di questi nel solo quartiere di San Lorenzo) e i feriti tra gli 11.000 e i 12.000. Le bombe avevano un peso complessivo di 1.060 t, vennero sganciate da un’altezza di 6.000 metri, impiegarono a toccare terra 1’10”. Si verificò immediatamente un massiccio esodo degli abitanti anche con il ritorno ai paesi di origine (in genere paesi dell’Italia centrale), il quartiere restò quasi deserto e le infrastrutture distrutte. La ricostruzione eliminò gli ultimi spazi non costruiti e fu accompagnata da una spinta di immigrazione proveniente dal Sud Italia. L'effetto sulla popolazione romana fu devastante, era chiaro a tutti che dopo lo sbarco delle truppe anglo americane in Sicilia (10 luglio) e questo bombardamento al quale nulla era stato opposto, la guerra era ormai chiaramente persa. Il 25 luglio la riunione del Gran Consiglio del Fascismo vide la messa in minoranza di Mussolini con l'ordine del giorno Grandi. Nello stesso giorno Mussolini fu arrestato, era la caduta del fascismo, il re affidava il governo al generale Badoglio. A questo bombardamento ne seguirono 51, il 13 agosto Roma fu vittima di un secondo bombardamento. Il 14 agosto Badoglio dichiarò che Roma era una città aperta, cioè si impegnava a trasferire i comandi militari dalla capitale e a non usare le infrastrutture cittadine per spostare uomini, mezzi e armamenti.
Il parco 19 luglio 1943, presenta un semplicissimo ma commovente monumento in ricordo dei morti di quel bombardamento, su una lastra di cristallo lunga 70 metri – che circonda l’aiuola centrale, scorrono i nomi di 1.492 morti. Spicca la famiglia De Angelis con 11 nomi. Il primo nome è Crescenzo Carroccia, l’ultimo Luigia Grettele. La sera si illumina. Il monumento è stato inaugurato il 19 luglio 2003 alla presenza del presidente della Repubblica Ciampi e del sindaco di Roma Veltroni. Il progetto del monumento di Luca Zevi è stato scelto da una commissione presieduta dal preside di architettura Roberto Palumbo perchè “nella sua essenzialità è anti retorico”. Una canzone di Francesco De Gregori dal titolo San Lorenzo inserita nell’album Titanic (1982) racconta di questo tragico bombardamento (da wikipedia.org).
Foto del bombardamento in Pafi Benvenuti, Roma in guerra, ed. Oberon, 1985, pag. 6 e 7.
Fino al 30 giugno 1931 qui era il capolinea della ferrovia per Tivoli inaugurata il 17 giugno 1879 su progetto pontificio. Inizialmente dotata di locomotive a vapore, fu elettrificata agli inizi del Novecento. Si effettuavano cinque corse al giorno, impiegava un’ora e mezzo circa, la prima partenza da Tivoli era alle 5,43 e l’ultima partenza da Roma alle 18,05. Dette un non lieve contributo allo sviluppo del quartiere (da I rioni e i quartieri di Roma, ed. Newton, 1990, pag. 1666, anche in Muscolino, Appunti immagini curiosità sui tram di Roma e del Lazio, ed. Filopress, 2004; alle pag. 11 e 12 manifesti con orario e bel dipinto del treno presso ponte Lucano con l’Aniene, pag. 22 e 23 foto del treno con terrazza panoramica posteriore, pag. 87 bus per Tivoli a via Gaeta del 1941 e bus articolato del 1961).
VIALE GIULIO CESARE / VIA C.A. DALLA CHIESA episodio di Teresa Gullace, nata Talotta; è la figura a cui si è ispirato Roberto Rossellini nel film "Roma città aperta" affidandone il ruolo ad Anna Magnani/Pina. Il 3 marzo 1944 alle ore 10,30 un folto gruppo di donne si erano radunate per chiedere la liberazione dei loro uomini arrestati nel corso di un rastrellamento (qui vi era il comando dell'81° fanteria). Teresa era una donna di 37 anni, madre di cinque figli ed in attesa di un sesto. Abitava a porta Cavalleggeri. Quando Teresa, con il figlio Umberto di 12 anni per mano, scorse il marito Girolamo da una finestra, cercò di avvicinarsi ad esso, forse per dargli del cibo o semplicemente per parlargli, partì un colpo di pistola, colpì Teresa che morì sul posto. Carla Capponi estrasse la pistola e venne bloccata dai militari, per fortuna Marisa Musu fu svelta a infilargli una tessera del Pnf in una tasca, quella tessera gli salvò la vita. Le donne improvvisarono una camera ardente in strada.
I suoi funerali videro la partecipazione di molte donne. Il liceo scientifico a lei intitolato a piazza Cavalieri del Lavoro ospita un busto opera di Ugo Attardi. Dal 1977 è medaglia d’oro al merito civile.
PALAZZO CESI GADDI IN VIA DELLA MASCHERA D’ORO. Il palazzo è sede della Procura Generale Militare, qui negli scantinati, nel 1994, il procuratore generale militare presso la corte di cassazione Antonio Intelisano, scoprì il cosiddetto “Armadio della Vergogna”. Fu un giornalista dell’Espresso, Franco Giustolisi, a denuciarene per primo l’esistenza. All’interno erano stati nascosti seicentonovantacinque fascicoli sui crimini commessi dai nazifascisti tra il 1943 e il 1945: Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, Fivizzano, Civitella Val di Chiana e tante altre stragi.
Pagine della nostra storia ricostruite grazie alle testimonianze dei sopravvissuti e al lavoro di carabineri e soldati americani o inglesi che registrarono quelle voci a ridosso degli accadimenti. Un capitolo archiviato nel 1960. La ragione era sostanzialmente quella di mantenere buoni rapporti con la Germania. Finalmente nel 2003 venne istituita una commissione parlamentare d’inchiesta. Ora in rete il loro lavoro. Tra le novità emerse: dieci istituti religiosi romani dove trovarono rifugio i gerarchi nazisti: la cosiddetta via dei conventi. Tra questi: il convento dei Salvatoriani in via della Conciliazione, dei Pallattini in via dei Pettinari, dei Frati Cappuccini in via Veneto dove fu nascosto Adolf Eichmann (organizzatore dei campi di concentramento, sfuggito al processo di Norimberga, catturato in Argentina dai servizi segreti israeliani). Al centro della tela il vescovo austriaco Alois Hudal che era nazista convinto. Tutte le notizie da: la Repubblica del 17.2.16, “Ecco i segreti nascosti nell’armadio della vergogna” a firma di Simonetta Fiori e Concetto Vecchio, pag.46 e 47.
Secondo wikipedia, alla voce Palazzo Cesi Gaddi, l’armadio della vergogna venne scoperto dal procuratore generale militare presso la corte di cassazione Antonio Intelisano nel 1994. Il palazzo è sede della Consiglio della Magistratura Militare. Nel palazzo, nel 1603, venne fondata l’Accademia dei Lincei, la più antica accademia scientifica del mondo, di essa fu ospite Galileo Galilei.
Via della Maschera d’oro si chiama così per la maschera dorata effigiata sulla facciata del palazzo Milesi che è in questa via al civico 9. Questo palazzo risale agli inizi del Cinquecento fu decorato a graffiti da Polidoro di Caravaggio e Maturino prima del 1527 con scene di vita romana, la favola di Niobe e al centro una maschera dorata circondata da putti che finì col dare il nome alla strada.
VIA DEGLI ZINGARI lapide a ricordo degli zingari perseguitati dai nazisti e deceduti nei campi di concentramento.
Il regime nazista aveva dichirato che gli zingari erano una “razza inferiore”. I rom, sinti e camminanti vennero sottoposti all’internamento, ai lavori forzati e al termine del loro sfruttamento venivano sterminati. Molti vennero uccisi in Serbia (stime tra 1.000 e 12.000) con la collaborazione dei governi fattoccio che appoggiavano il regime nazista, altri in Unione Sovietica (negli stati baltici almeno 30.000), migliaia nei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau (dove esisteva un settore riservato agli zingari), Chelmo, Belzec, Sobibor e Treblinka. La polizia francese internò almeno 3.000 rom, ma il numero di quelli inviati in Germania fu minore. La Romania, paese alleato della Germania, non procedette all’eliminazione dei rom, ma circa 26.000 furono deportati in Transnistria, una regione dell’Ucraina amministrata dalla Romania. In Croazia, paese alleato della Germania e governato dagli Ustascia, le autorità trucidarono l’intera popolazione roma, circa 25.000 persone. Non si hanno notizie precise di quanti zingari siano stati uccisi, si calcola il 25% di quelli che vivevano in Europa, cioè almeno 220.000. Solo alla fine del 1979 la Repubblica Federale di Germania riconobbe che la persecuzione dei Rom ad opera dei nazisti fosse motivata da pregiudizio razziale ed aprì la strada ai risarcimenti.
Dopo il crollo del muro di Berlino, nella capitale tedesca è stato creato un monumento in ricordo dello sterminio degli zingari, questo si trova a pochi passi dal Reichstag, il parlamento tedesco. Si compone di una fontana circolare larga 12 metri dal fondale nero con un triangolo vuoto nel centro, intorno ha dei massi con i nomi dei campi di concentramento dove sono stati uccisi uomini, donne e bambini zingari. Ai margini sono incisi i versi del componimento “Auschwitz” del poeta italiano di etnia roma Santino Spinelli. Il monumento è opera di un artista israeliano Dani Karavan. Nelle vicinanze si trova il memoriale in ricordo degli omosessuali uccisi nei campi di concentramento.
La strada ha questo nome perché le carovane di zingari che affluivano a Roma nel Seicento, venivano concentrate in questa zona, detta allora del Pozzo. Il toponimo è rimasto nel vicolo del Pozzuolo, dietro alla Madonna dei Monti. Il muro su cui si trova la lapide, fa parte dell’Angelo Mai una scuola gestita da religiosi per alunni maschi intitolata al cardinale Angelo Mai vissuto nell’Ottocento. Si tratta di una figura importante dal punto di vista culturale perché scoprì l’epistolario dello scrittore latino Frontone, opera fondamentale per conoscere la vita degli imperatori Marco Aurelio, Lucio Vero e Antonino Pio; inoltre a lui si deve la scoperta di frammenti di importanti opere politiche di Cicerone come il De Repubblica. Nel gennaio del 1920 Leopardi gli dedicò un’ode intitolata appunto “Ad Angelo Mai”. Il palazzo dopo anni di abbandono fu occupato da un centro sociale, dal 2006 trasferito in viale delle Terme di Caracalla.
Piero Tucci
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
25.4.16
VILLE RESTAURATE DI ROMA
IN OCCASIONE DEL 21 APRILE, NATALE DI ROMA,
IL COMUNE HA RESTAURATO ALCUNE VILLE
E GIARDINI DI PREGIO NEL CENTRO DELLA CITTA’
ANDIAMO A SCOPRIRLI.
PARCO DI COLLE OPPIO
Il parco ha un ingresso dal Colosseo, uno da via delle Terme di Traiano e un altro da via delle Terme di Tito (attraverso quest’ultimo si entra in viale del Monte Oppio).
Il colle Oppio, insieme al Fagutale (oltre via Cavour- Monti) e al Cispio (dove si trova Santa Maria Maggiore) fa parte del colle Esquilino, il più alto ed esteso tra i sette colli di Roma.
Fu sede di uno dei villaggi che diede origine a Roma, in età neroniana fu occupata dalla Domus Aurea, su di essa sorsero le terme di Tito e quelle di Traiano. Nel medioevo, la zona rimase disabitata sorsero le chiese di San Pietro in Vincoli e San Martino ai Monti. Subito dopo il 1870 l’area venne destinata a giardini pubblici e fu più tardi inserita nel grandioso progetto di tutela della zona monumentale. Il primo nucleo del parco fu realizzato tra il 1928 e il 1932 dall’arch. Raffaele De Vico[1]. Il giardino si impernia sull’incrocio di due grandi assi viari: viale Mizzi[2] e viale della Domus Aurea dotati di ingressi monumentali arricchiti da una serie di fontane, tra queste il grande ninfeo con decorazioni in tufo realizzate da Giorgiutti e le due fontane affacciate sul via Labicana. La più importante è la fontana delle anfore. Nei viali si trova la statua di Alfredo Oriani[3], opera di Ercole Drei[4] del 1935. La sistemazione del settore superiore del colle, comprendente i resti delle terme di Traiano, si deve a Antonio Munoz[5] e venne realizzata tra il 1935 e il 1936.
Era un luogo di ritrovo per le manifestazioni operaie prima dell’avvento del fascismo. Qui nel 1922 si tenne l’ultima manifestazione del Primo Maggio, prima che il fascismo ne vietasse la celebrazione.
E’ stato restaurato nel marzo del 2016 nell’arco degli interventi per impermeabilizzare la Domus Aurea. Da allora si è deciso di chiudere di notte i cancelli di Colle Oppio, un modo per tutelare il parco di 11 ettari[6] con vista Colosseo e sottrarlo al degrado. Il provvedimento dopo la riqualificazione da 309.000 €. Sono stati restaurati i viali, i lampioni, le fontane e i nasoni, sono stati effettuatei degli interventi di ingegneria ambientale per evitare il dilavamento delle colline verso il Colosseo, è stato ripristinato il roseto e sistemato il pozzo per l’irrigazione dei giardini.
GIARDINO DEGLI ARANCI
Si trova in piazza Pietro d’Illiria. Cinto dalle mura del castello dei Savelli del sec. XIII (costruito a sua volta su un castello dei Crescenzi del sec. X) per cui è chiamato anche parco Savello. E’ stato realizzato da Raffaele De Vico nel 1932, là dove era l’orto dei domenicani della vicina chiesa di Santa Sabina, presenta uno dei panorami più belli e conosciuti di Roma. Ha una estensione di mq 7.800. Il giardino è piantato ad aranci con riferimento all’arancio piantato da San Domenico, fondatore dell’ordine, conservato nel vicino chiostro di Santa Sabina e visibile tramite un foro nel muro perimetrale del chiostro. E’ un giardino simmetrico, il viale centrale – che porta al belvedere – è stato intitolato a Nino Manfredi (Castro dei Volsci 1921 – Roma 2004), ciociaro di origine ma romano di adozione. Nella parte destra (per chi entra) vi era la fontana di piazza Montanara di Giacomo della Porta, collocata nel 1973 in piazza San Simeone ai Coronari. La piazza centrale è stata intitolata a Fiorenzo Fiorentini, un attore romano che ha recitato per più stagioni in questo luogo. L’ingresso principale del giardino fu arricchito, nel 1937 con portale di villa Balestra sulla Flaminia. D’estate vi si tengono spettacoli teatrali all’aperto, in particolare di teatro romano classico o romanesco.
A sinistra dell’entrata si trova una fontana (vasca termale romana) con mascherone, formata con materiale di spoglio, proviene dal Campo Vaccino.
Restaurato grazie al gruppo Fondazione Sorgente Group e riaperto per il Natale di Roma il 21 aprile 2016. Spesi 250 mila euro, lavori per 5 mesi. Il giardino degli Aranci, ha nuove panchine in travertino e ghisa e nuovi cestini, sistemati gli arbusti, le aiuole e il brecciolino. Nuovo l’impianto di irrigazione. La fondazione si occuperà anche della manutenzione. Sembra che un cartello vieti l’ingresso alle bici.
VILLA ALDOBRANDINI
L’ingresso è da via Mazzarino 11, dal 1926 è proprietà dello Stato italiano. E’ un giardino pensile racchiuso da muraglioni. Nel Novecento il palazzo e parte del giardino furono assegnati all’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato.
La storia di questa villa inizia nel 1566 quando monsignor Giulio Vitelli, originario di città di castello, acquistò una vigna in località monte Magnanapoli. Secondo una schema diffuso nel Cinquecento la villa comprendeva: il casino, il giardino segreto e un parco che arrivava fino a palazzo Pallavicini Rospigliosi (ancora non esistente). L’architetto Carlo Lambardi[7] vi fece lavori di restauro e abbellimento come il portone d’ingresso ad angolo con via Panisperna. Nei primissimi anni del Seicento la villa fu acquistata da papa Clemente VIII per donarla al nipote Pietro Aldobrandini. Giacomo della Porta[8] dotò il palazzo di scale e logge e di una facciata sul giardino. Il giardino stesso fu arricchito con alberi di alto fusto in parte ancora esistenti, statue, vasi, cippi, sedili, alcune fontane e una peschiera oggi non più esistente.
Ai piani superiori era ospitata una ricchissima collezione di opere d’arte lasciate in eredità da Lucrezia d’Este duchessa d’Urbino. Vi erano quadri di Giovanni Bellini, Tiziano, Dosso Dossi, della scuola veneta e ferrarese, oltre a Raffaello e ambiente romano. “Le nozze aldobrandini”, pittura romana ad affresco, di epoca augustea, venute alla luce all’Esquilino nel 1601 sono ora ai musei vaticani. La villa passò ai Pamphili e ai Borghese che spostarono la collezione nelle proprie gallerie.
Tra il 1811 e il 1814 la villa fu sede del governatore francese di Roma, con la restaurazione tornò agli Aldobrandini che la tennero fino al 1926 quando passò allo Stato ormai ridotta per l’apertura di via Nazionale. Negli anni Trenta Piacentini aggiunse un corpo neocinquecentesco su via Panisperna. La scalinata di ingresso su via Mazzarino si deve a Cesare Valle (1938).
E’ stata restituita alla cittadinanza, il 21 aprile 2016 in occasione del Natale di Roma, era chiusa dal 2013. Grazie ai fondi Arcus, la società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo. L’Arcus ha ripristinato l’impianto idrico delle fontane fermo da anni, recuperato specie botaniche in via di estinsione, rinnovato gli arredi, restaurato la pavimentazione e messo a norma gli affacci. La sovrintendenza è interventua su marmi antichi, statue e fontane ora totalmente riqualificate.
Esiste una imponente villa Aldobrandini a Frascati voluta sempre da Clemente VIII per il nipote Pietro Aldobrandini. Anch’essa si deve a Giacomo della Porta a cui subentrarono Carlo Maderno e Giovanni Fontana. Nella villa affreschi del Domenichino, Zuccari e Cavalier d’Arpino.
GIARDINO DI PIAZZA CAIROLI
Si trova lungo via Arenula, ha una superficie di mq 1.600. Il giardino è stato realizzato su disegno dell’arch. paesaggista francese Edouard Andrè e donata ai cittadini romani dal barone Huffer (anche la contessa Sforza Cesarini di Santa Fiora donò £ 50.000 per la realizzazione della piazza-giardino). La piazza risulta dagli sventramenti tardo ottocenteschi riunendo due piazze Branca e San Carlo ai Catinari. La piazza, ombreggiata dai platani è ornata da una fontana e da una statua bronzea. La recinzione del giardino riprende quella rimossa nel 1937 per fornire ferro alla patria. Nel 2000, nel quadro delle opere del Giubileo, l’area è stata riqualificata, in quell’occasione fatte le nuove inferriate.
La fontana fu realizzata nel 1888 da Andrè come si legge inciso in un angolo dello zoccolo. Essa è costituita da una vasca di granito di Baveno di forma quadrangolare con – al centro – un pilastro la cui decorazione (delfini in bronzo vicino a un tridente) è andata perduta. Il pilastro sostiene un catino circolare proveniente da scavi del 1887 nella vicina piazza Cenci. Al di sopra si trova un secondo pilastro che sostiene un catino da cui fuoriesce l’acqua.
Il monumento a Domenico Seismit-Doda[9], patriota, ministro delle Finanze, del Tesoro, deputato, scomparso nel 1893. L’opera è dello scultore Eugenio Maccagnani[10], collaboratore di Sacconi al Vittoriano, terminata nel 1906, collocata nel 1919 e nottetempo perché noto irredentista.
Il giardino è stato restaurato per il Natale di Roma del 2016.
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
- AA.VV. Guida d’Italia, Roma, ed. Tci, 1993.
- AA.VV. Roma, libri per viaggiare, ed. Gallimard – Tci, 1994.
- AA.VV. I rioni e i quartieri di Roma, ed. Newton & Compton, 1989.
- AA.VV. Le strade di Roma, ed. Newton & Compton, 1990.
- Claudio Rendina (a cura di), Enciclopedia di Roma, ed. Newton & Compton, 2005.
- Sabrina Ramacci, 1001 cose da vedere a Roma almeno una volta nella vita, ed. Newton Compton, 09.
- Carlo Zaccagnini, Le ville di Roma, ed. Newton Compton, 1991.
- Alessandro Tagliolini, I giardini di Roma, ed. Newton Compton, 1992.
- AA.VV. Stradaroma, ed. Lozzi, 2005.
- AA.VV. Tutto Città, 2011/2012, ed. Seat.
www.comune.roma.it
www.archeoroma.beniculturali.it
www.sovraintendenzaroma.it
www.romasegreta.it www.romasparita.eu
www.info.roma.it www.it.wikipedia.org www.maps.google.it www.viamichelin.it
Piero Tucci 01.05.16
[1] Raffaele de Vico. Parco di Villa Glori nel 1924, giardino di piazza Mazzini nel 1925, monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale al Verano nel 1926, il serbatoio dell'Acqua a Porta Maggiore nel 1927, ingresso di Colle Oppio, serbatoio dell'acqua dello zoo, sistemazione ampliamento dello zoo, parco Nemorense in piazza Crati nel 1930, parco Savello all'Aventino nel 1932, uccelliera dello zoo nel 1935, sistemazione arborea dei giardini del laghetto dell'Eur nel 1960.
[2] Fortunato Mizzi (1844-1905) Uomo politico maltese, strenuo sostenitore dell’italianità di Malta. Avvocato, fondò il giornale Malta. Malta è indipendente dal 1964.
[3] Alfredo Oriani. Scrittore, storico e poeta nato a Faenza nel 1852, morto a Casola Valsenio nel 1909. La sua fama di scrittore si deve ai trattati di storia e politica come “Fino a Dogali” del 1889, in questa e nelle altre affermò la sua idea di stato forte che regola la vita sociale con ampi poteri. Tra le opere letterarie: Gelosia del 1894 e Vortice del 1899. Uno dei suoi ultimi lavori Bicicletta del 1902, una raccolta di novelle. Lasua opera fu apprezzata da Benedetto Croce, il fascismo vide in lui un precursore. Mussolini curò l’edizione completa delle sue opere. A Roma gli era dedicato un istituto magistrale con sede a piazza Indipendenza 7 oggi Liceo Macchiavelli, esiste un Istituto Comprensivo e una piazza a Monteverde Vecchio.
[4] Ercole Drei. (Faenza 1886 - Roma1973) Soprattutto scultore ma anche pittore e disegnatore. Studiò all'Accademia di Firenze dove insegnava Fattori. Dal 1913 a Roma, ha abitato a villa Strohl Fern dal 1921 alla morte. Prende parte alla Secessione Romana e alle Biennali di Venezia. Dopo la prima guerra mondiale rielabora alcuni soggetti in base ai canoni classici dell'essenzialità formale e dell'equilibrio compositivo. Bassorilievi per il ponte Duca d'Aosta a Roma, la stele per il lavoro nei campi nel giardino dell'Eur, il Seminatore alla Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale. Presente alla Quadriennale romana. Sue opere nella chiesa di Don Bosco a Roma, per la facciata della galleria Colonna.
[5] Antonio Munoz (1884-1960) architetto e storico dell'arte, fu sovrintentendente alle antichità del Lazio, a lui si deve la sistemazione di diverse zone del centro storico durante gli sventramenti del fascismo: via dell'Impero, via dei Trionfi, largo Argentina, mausoleo di Augusto. La sua opera più importante fu il restauro di Santa Sabina. Fu primo direttore del museo di Roma a via dei Cerchi. Restaurò molte chiese di Roma.
[6] Un ettaro = 10.000 mq.
[7] Carlo Lambardi o Lombardi autore della facciata di Santa Francesca Romana, di palazzo Costaguti in piazza Mattei (dove si trova la fontana delle Tartarughe) e di villa Aldobrandini.
[8] Giacomo della Porta (Genova 1533 - Roma 1602), architetto e scultore, allievo e aiuto del Vignola, costruì la chiesa del Gesù a Roma, la chiesa di Santa Maria ai Monti, la fontana di piazza Colonna, la fontana del Tritone, la fontana delle Tartarughe in piazza Mattei, le fontane minori in piazza Navona. E’ passato alla storia per aver realizzato la cupola di Michelangelo in San Pietro dopo la morte del grande artista, sua la facciata di palazzo Altemps.
[9] Seismit Doda (Ragusa di Dalmazia 1825 – Roma 1893) patriota e politico. Partecipà alla prima guerra d’indipendenza e alla difesa della Repubblica romana. Ministro con la Sinistra storica di Cairoli, fu contrario alla Triplice Alleanza e costretto a lasciare la carica di ministro. Per non contrariare gli austriaci il monumento fu collocato solo dopo la fine della prima guerra modiale.
[10] Eugenio Maccagnani. (Lecce 1852-Roma 1930). Autore del monumento a Garibaldi a Buenos Aires in plaza Italia. Frequentò l’Accademia di San Luca. Partecipò all’esposizione universale di Parigi del 1878. La parte più nota della sua attività è la collaborazione con Sacconi per il Vittoriano. Sue opere alla Gnam e al Santuario di Loreto.
Pagina 2 di 2