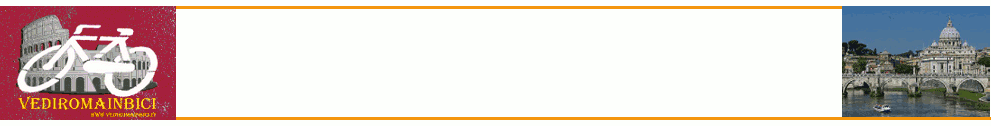Foto e Schede 2017
VIA MARGUTTA 97 abitazione e studio di Bruno Ferrari, pittore, figlio del famoso scultore Ettore Ferrari autore della statua di Giordano Bruno in Campo de’ Fiori. Diplomatosi all’Accademia di Belle Arti di Roma, fece parte del gruppo dei “Venticinque della Campagna Romana”, la vita agreste intorno a Roma fu il suo soggetto preferito. Si arruolò volontario nella prima guerra mondiale, dal 1928 al 1938 fu segretario tecnico dell’Enciclopedia Treccani per la parte figurativa. Giordano Bruno Ferrari aderì al partito d’Azione e presso di lui agivano i membri del gruppo Vassalli legato a Bandiera Rossa. Con la radio trasmetteva informazioni agli Alleati sullo spostamento delle truppe tedesche, dove erano localizzati i depositi di carburante e gli effetti dei bombardamenti. La mattina del 24 maggio venne fatto uscire dalla cella del carcere di Regina Coeli per essere trasferiti di braccio, al che lui rispose: “Sappiamo benissimo che ci porterete dinanzi al plotone d’esecuzione, e non abbiamo bisogno delle vostre pietose menzogne: nessuno di noi a paura di morire”. Venne fucilato con altri compagni di lotta a Forte Bravetta.
PIAZZA DELLA LIBERTA' / VIA VALADIER la lapide ricorda Massimo Gizzio che in questo luogo conduceva una manifestazione di studenti, al sopraggiungere di una squadra fascista chiamata dal preside del classico Dante Alighieri di via Marcantonio Colonna furono esplosi dei colpi che ferirono gravemente Massimo. Dopo tre giorni di agonia al Santo Spirito morì. La sua memoria fu tenuta viva dalla sorella Marisa, che in diverse occasioni ha detto: “Massimo non era un eroe, non ascoltate coloro che vorrebbero farvelo credere. Era un giovane che aveva tutto per essere amato e per amare la vita, che quotidianamente sceglieva la vita, non la morte, non cercava il rischio, il pericolo”. Studente universitario, era stato arrestato e torturato per la sua propaganda antifascista, anche avviato al manicomio criminale. Nel 1943 aderì al PCI. Liberato il 25 luglio, entrò in contatto con Carlo Lizzani, Vincenzo Lapiccirella e Gioacchino Gesmundo, riprese la lotta guidando il Comitato studentesco di agitazione. In quei mesi fece propaganda per chiudere scuole superiori e università in quanto luoghi nei quali i giovani potevano facilmente essere individuati, riuniti e deportati in Germania. Il 29 gennaio il comitato studentesco proclamò lo sciopero di tutte le scuole medie superiori di Roma, i manifestanti diretti a piazza della Libertà distribuirono volantini inneggianti la pace (il 22 erano sbarcati gli americani ad Anzio). Nel dopoguerra indagini della magistratura individuarono gli autori degli spari, Massimo Uffreduzzi uccise Massimo con un colpo di rivoltella sparato di spalle, ma tutti furono assolti per "amnistia".
Un’altra lapide ricorda il luogo nel quale, il 9 settembre 1943 si riunirono i partiti antifascisti per dare vita al Comitato di Liberazione Nazionale che fu presieduto da Ivanoe Bonomi (socialista riformista, sarà poi capo del governo italiano dopo Badoglio, già capo del governo tra il 1921 e il 1922, deputato alla costituente, presidente del Senato tra il 1948 e il 1951).
Nel giugno 2015 i giardini sono stati intitolati a Ettore Troilo comandante partigiano della Brigata Maiella.
VIA LUCULLO 6 altra sede del tribunale militare germanico. Oggi sede nazionale della Uil. Il 6 marzo 1987 è stato inaugurato all'ingresso il monumento dello scultore Ugo Attardi, realizzato dalla Zecca di Stato. Rappresenta un partigiano morente nella sua cella dopo essere stato torturato. Opera del 1986 per il XL della Repubblica italiana, titolo “Per la libertà”, dimensioni del bassorilievo: m 4,50 x 3,10. Dietro il monumento, in corrispondenza della finestra della stanza usata come luogo di torture, c’è una lapide che recita: “In questo edificio il tribunale di guerra nazista durante l’infausta occupazione vanamente tentò di soffocare nel sangue l’anelito di libertà del popolo romano”. Nella strada, alla base del palazzo dell’Ambasciata Americana, resti degli Horti Sallustiani.
VIA MANIN 72 liceo intitolato a Pilo Albertelli, statua e lapide, altra lapide in via Sambucuccio d'Alando (piazza Bologna). Dopo la laurea in filosofia si dedicò all’insegnamento portando in esso un senso elevato di apostolato. Fu amato dai suoi allievi che appresero da lui non solo la filosofia ma la conoscenza di se stessi. Già nel 1928 era stato arrestato per le sue idee e condannato a cinque anni di confino, commutati in tre di libertà vigilata. Dopo l’8 settembre abbandonò gli affetti familiari, l’insegnamento, per dedicarsi interamente alla lotta clandestina. Ebbe incarichi rischiosissimi per il gruppo militare di Giustizia e Libertà, trasportò armi ed esplosivi, tenne contatti con molte persone anche di altri gruppi politici, partecipò alla prima azione militare a Roma dopo l’8 settembre, il giorno 20 collocò una bomba alla caserma della milizia fascista ai Parioli. Tradito da tale Priori, venne arrestato il 1° marzo 1944 dalla banda Koch e portato alla pensione Oltremare di via Principe Amedeo dove venne torturato, ai carnefici rispose: “Adoperate pure le vostre armi e i vostri mezzi, io uso l’arma che mi è rimasta: il silenzio”. Tentò il suicidio due volte. La moglie Lia lo vide il 21 marzo ridotto “all’ombra di se stesso”, tre giorni dopo venne portato alle Fosse Ardeatine e lì ucciso. Nel 1947 gli fu conferita la medaglia d’oro al valor militare. Il 24 marzo 1954 Ugo La Malfa commemorò il compagno caduto, inaugurò il monumento all’interno del liceo che dal quel giorno porta il suo nome.
Altri alunni celebri del liceo furono: il premio Nobel Enrico Fermi, lo scrittore Carlo Cassola, l’economista Massimo D’Antona, i partigiani Arrigo Paladini, Carlo Salinari (storico della letteratura) e Giorgio Marincola, il regista Ettore Scola, lo scrittore Ugo Ojetti
VIA URBANA 2 casa di Don Pietro Pappagallo. Pugliese di Terlizzi, concittadino e amico di Gioacchino Gesmundo, venne a Roma come gestore di un convitto per gli operai della Snia Viscosa, chierico di Santa Maria Maggiore, divenne cappellano del convento del Bambin Gesù in via Urbana, dove risiedeva. Ospitò ebrei, militari italiani e soldati fuggiti dai campi di concentramento, partigiani. Qualche giorno prima del suo arresto aveva ospitato un ufficiale che si era dichiarato disertore, era il delatore Giacomo Cherubini. Il 29 gennaio alle ore 12,30 don Pappagallo andò ad aprire alla porta, erano i nazisti che prima di portarlo a via Tasso, aspettarono la sera, per poter arrestare altre persone che si sarebbero recate da lui per documenti falsi. Fu rinchiuso nella cella n. 13 al terzo piano insieme ad altri detenuti. “Il suo arrivo fu quello di un padre” ricorda Oscar Caggegi. Lo stesso ha raccontato che la mattina del 24 don Pietro si svegliò raccontandogli di averlo sognato uscire illeso da una fornace. Il disertore austriaco Josef Reider, presente all’eccidio delle Ardeatine, dichiarò che poco prima della morte don Pappagallo riuscì a liberarsi i polsi, con le mani impartì la benedizione ai presenti. A strage avvenuta si seppe che Kappler aveva deciso di far morire don Pappagallo “così quelli delle Ardeatine avranno anche un prete”. La sua figura, insieme a quella di don Morosini, ispirò a Roberto Rossellini la figura del prete (don Pietro) interpretata da Aldo Fabrizi nel film “Roma città aperta”.
E’ medaglia d’oro al valor civile, Giovanni Paolo II ha incluso don Pappagallo tra i martiri della Chiesa. La Rai ha trasmesso un film in due puntate a lui dedicato, nel 2006, dal titolo “La buona battaglia” nel quale don Pappagallo è interpretato da Flavio Insinna, la sua perpetua Paola Tiziana Cruciani, per la regia di Gianfranco Albano.
Piero Tucci
25.04.17
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
BIBLIOTECHE DI ROMA
Una fantastica passeggiata tra i libri.
Andiamo a scoprire dove si conserva il sapere dell’umanità.
Biblioteca: dal latino (a sua volta derivato dal greco) = raccolta di libri.
STORIA DELLE BIBLIOTECHE
Le più antiche biblioteche del mondo sorsero a Tell al Amarna in Egitto, a Marni e Ebla in Siria
erano più che altro archivi in cui venivano conservati conservati documenti e lettere. Le prime vere e proprie biblioteche furono quella di Assurbanipal nel VII sec. a.C. a Ninive in Mesopotamia e di Pisistrato ad Atene nel VI sec a.C. In età ellenistica sorse la più celebre biblioteca dell'antichità ad Alessandria d'Egitto per opera dei Tolomei che fu anche scrittorio di papiri, giunse a contenere 700.000 volumi quando fu in parte distrutta da un incendio nel 47 a.C. Famosa fu anche la biblioteca di Attalo I a Pergamo in Asia Minore sorta nel III sec. a.C.
A Roma la prima biblioteca pubblica fu fondata da Asinio Pollione sull'Aventino nel 39 a.C dal bottino della sua guerra vittoriosa contro i Dalmati. In età imperiale sorsero biblioteche per volere di Augusto (la Palatina), Tiberio, Vespasiano e Traiano (quella nella basilica Ulpia nel Foro di Traiano visse fino al V secolo). All'epoca di Costantino Roma contava 28 biblioteche pubbliche.
Nel Medioevo sono i monasteri benedettini a creare grandi biblioteche nelle quali si copiano i manoscritti antichi e permettono la trasmissione della cultura greco-romana altrimenti dispersa. Tra le biblioteche più importanti sono quella dell’abbazia di Montecassino, del cenobio di Bobbio e del monastero di Citeaux. Un altro incremento delle biblioteche si ebbe nel XII secolo con la nascita delle prime università: Bologna e Parigi per prime.
Nel rinascimento nascono le prime biblioteche laiche ad opera di vari signori, come la Maltestiana a Cesena, la Estense a Ferrara poi trasferita a Modena, la Gonzaghesca a Mantova, la Laurenziana a Firenze, la Marciana a Venezia (che nasce da quella del cardinal Bessarione). Accanto a queste sorsero anche biblioteche ecclesiastiche, prima fra tutte la Biblioteca Apostolica Vaticana fondata da Sisto IV nel 1475. Determinante fu l’invenzione della stampa che alla fine del Quattrocento moltiplicò il numero e la disponibilità dei volumi. Fuori d’Italia è importante la biblioteca Palatina di Heidelberg.
Nel Cinquecento nascono le prime case editrici a Venezia, ad Amsterdam, a Lione, a Lipsia. Nel Seicento nascono le prime grandi biblioteche pubbliche: la Angelica di roma, la Ambrosiana di Milano, la Bodleiana di Oxford e quella di Cambridge. Dal 1660 nascono le grandi biblioteche nazionali: a Berlino nel 1661, a Parigi nel 1692, a Vienna nel 1722, ed altre.
Nell’Ottocento c’è un grande sviluppo numerico di biblioteche e incremento delle dotazioni librarie di ognuna.
A partire dal XX secolo nasce la scienza biblioteconomica con la classificazione delle opere grazie agli studi di Melvil Dewey. Si assiste alla diversificazione delle attività bibliotecarie mediante la diversificazione dei servizi offerti agli utenti, l’organizzazione di mostre, incontri di lettura e conferenze. Con l’istituzione delle Regioni (anno 1970) vengono trasferiti ad esse le competenze sulle biblioteche locali. Dagli anni Ottanta si assiste al crescente sviluppo dell’utilizzo del computer per l’informatizzazione dei cataloghi. Dagli anni Novanta si arriva alla biblioteca digitale. Il Codice dei Beni Culturali del 2004 definisce “biblioteca, una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio”.
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
viale Castro Pretorio 105
Fondata nel 1877 con il materiale della biblioteca dei Gesuiti del Collegio Romano al quale si aggiunsero altre 70 biblioteche claustrali, da allora è stata continuamente accresciuta. E' di carattere generale con pregevoli fondi speciali come topografia romana, riproduzione di codici, libri arabi, cinesi e giapponesi, opere relative alla storia della Compagnia di Gesù, raccolte di quotidiani, riviste, atti ufficiali e accademici italiani e stranieri. Possiede circa 1.500.000 libri, 5.670 manoscritti, 1.877 icunaboli[1], circa 5.000 periodici, 27.154 autografi.
L'edificio che ospita la biblioteca è stato costruito tra il 1959 e il 1969 da Castellazzi, Vitellozzi e D'Andrea e rientra nella tipologia dello "stile internazionale", o "scatole di vetro". E’ stata inaugurata il 31 gennaio 1975 dall’allora ministro dei Beni Culturali Giovanni Spadolini.
Dal 1990 il suo catalogo è on line. E' sede espositiva, vi si svolgono convegni e presentazioni di libri. E’ aperta al pubblico una mostra permanente per i 40 anni della biblioteca stessa. Attualmente il direttore è Osvaldo Avallone.
La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19, il sabato fino alle 13,30[2].
BIBLIOTECA CENTRALE DEI RAGAZZI
via di San Paolo alla Regola 15-18
La biblioteca è specializzata nella letteratura per ragazzi, favole, fiabe, fumetti, libri illustrati, offre laboratori di educazione alla lettura, libri dedicati alla multiculturalità, una raccolta storica dagli anni Ottanta di letteratura giovanile e dei periodici per ragazzi. Tra gli obiettivi primari c'è la valorizzazione di autori e illustratori italiani di libri per bambini, da Bruno Munari a Gianni Rodari a Emanuele Luzzatti. La biblioteca è destinataria della copia d'obbligo per il deposito legale dei libri per ragazzi. Il pubblico può avere informazioni bibliografiche e consulenza del servizio bibliotecario nazionale, prestito delle opere. La biblioteca offre visite guidate per gruppi, fotocopie, spazio espositivo, uno spazio per la prima infanzia. Fa parte del sistema delle biblioteche di Roma.
Responsabile della biblioteca Anna Righini. Aperta dal mar. al ven. dalle ore 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.
BIBLIOTECA ROMANA SARTI
piazza dell'Accademia di San Luca 77
Donata al Comune nel 1877 dall'arch. Antonio Sarti[3] con obbligo del deposito perpetuo presso l'Accademia di San Luca. E' specializzata in Belle Arti, in particolare nell'architettura, contiene circa 30.000 tra volumi e opuscoli ed è in continua espansione.
La biblioteca fa parte del Sistema delle Biblioteche di Roma, vedi più avanti.
Si trova nel palazzo Carpegna con la facciata attribuita a Giacomo Della Porta[4], ampliata dal Borromini. E' sede dell'Accademia di San Luca che si riallaccia alla trecentesca "Università dei Pittori", riformata nel 1478. Abbattuta la sua antica sede per l'apertura di via dei Fori Imperiali venne qui trasferita insieme alla Galleria dell'Accademia che si trova la terzo piano. Vi si tengono mostre temporanee.
BIBLIOTECA ANGELICA
piazza sant'Agostino 8
Fondata nel 1614 dal padre agostiniano Angelo Rocca passata allo Stato nel 1873 e specializzata in letteratura e filologia[5]. Contiene circa 150.000 volumi, 12.000 opuscoli, oltre 1.000 icunaboli, 3.000 messali dal IX secolo in poi, oltre 11.000 edizioni cinquecentesche, 2.650 manoscritti. Splendido il salone Vanvitelliano.
Conserva le varie edizioni dell’Index librorum prohibitorum, la prima edizione fu voluta da Paolo IV nel 1559, cioè i libri vietati dalla Chiesa Cattolica perché espressione del libero pensiero. Tra questi il Decamerone di Boccaccio, i testi politici di Macchiavelli, quelli di Erasmo da Rotterdam, Garganuta e Pantaguerl di Rabelais, i trattati scientifici di Copernico, le opere di Giordano Bruno, le opere degli illuministi Diderot e Voltaire, anche presenze inaspettate come Balzac, Stendhal, Hugo, Dumas, Fogazzaro, Beccaria e Croce. L’Indice è stato abolito nel 1966.
BIBLIOTECA CASANATENSE
via di Sant'Ignazio 52
Fondata con testamento del card. Gerolamo Casanate nel 1698 in un edificio annesso a Santa Maria sopra Minerva, passata allo Stato nel 1873. Consta di due grandi sale di consultazione e di una sala di bibliografia. Nel salone la scaffalatura è del Settecento e vi si trova anche un busto in marmo del card. Casanate del Legros. Possiede 250.000 volumi, 100.000 opuscoli, 6.000 manoscritti, 2.080 icunaboli. Notevole la collezione di editti e bandi, la raccolta di rilegature artistiche e parecchi manoscritti miniati. La biblioteca è specializzata in storia della Chiesa[6].
BIBLIOTECA VALLICELLIANA
piazza della Chiesa Nuova 18
Fondata nel 1581 dal portoghese Achille Stazio, la più antica delle biblioteche romane aperta al pubblico, specializzata nella storia di Roma e della Chiesa. Contiene una raccolta di 2.500 preziosissimi messali, tra cui 221 greci dal sec X in poi e il più antico dei latini del VII secolo.
Si trova nell'oratorio dei Filippini del Borromini (1637-50) con tipica facciata in cotto a due ordini di lesene che la ripartiscono in cinque campate e la cui forma leggermente concava è accentuata dalla balconata centrale addossata a un nicchione appena incurvato: portale e colonne, finestre con elaborati frontespizi, timpano di conamento mistilineo.
All'interno si trova la sala del Borromini - il vero e proprio oratorio - ove san Filippo Neri faceva eseguire quelle laudi spirtuali che diedero origine alla composizione musicale detta appunto "oratorio". Nel palazzo sono notevoli i due cortili, la sala ovale e lo scalone tutte geniali costruzioni del Borromini. Vi hanno sede l'Archivio Storico Capitolino, comprendente l'archivio cittadino e quello delle famiglie Anguillare, Orsini e Boccapaduli. Vi sono inoltre la Biblioteca Romana, la Società Romana di Storia Patria e l'Istituto Storico per il Medioevo con annessa biblioteca[7].
BIBLIOTECA TEATRALE
via del Sudario 44
Insieme alla Raccolta Teatrale della Società Italiana Autori ed Editori, comprende più di 30.000 tra volumi e opuscoli riguardanti il teatro. Inoltre possiede una raccolta di stampe, oltre 100 maschere italiane, statuette antiche di terracotta, marionette del Settecento e Ottocento, busti, quadri, bozzetti di soggetto teatrale, maschere del teatro greco, latino e moderno, costumi di attori celebri oltre 5.000 fotografie.
La biblioteca e la raccolta si trovano nella Casa del Burcardo, costruita nel 1503 includendo una torre preesistente dal prelato Giovanni Burckhard di Strasburgo (m 1505), cerimoniere pontificio e autore di una famosa cronaca. Dal nome latino della sua città Argentorarum chiamò Argentina la torre. Da qui il nome alla zona e all'attuale largo. L'edificio ha l'aspetto tipico di una casa germanica del tardo Quattrocento: facciata liscia ad intonaco, semplice porta, due piani con finestre centinate e all'ultimo piano una loggia di sei arcate su colonnine. Cortile con trifore e altre tipiche finestre, resti di graffiti.
Accanto a destra la chiesa del Sudario, di Carlo Castellamonte del 1604, restaurata da Carlo Rainaldi[8] nel 1687 con facciata a intonaco incorporata nelle casse attigue. Era la chiesa dei piemontesi, nizzardi e savoiardi residenti a Roma. Chiesa particolare di Casa Savoia dopo il 1870[9].
BIBLIOTECA PACIS
via dei Fori Imperiali
Gli studi compiuti negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento hanno identificato l'ambiente oggi Chiesa dei Santi Cosma e Damiano come biblioteca Pacis del Foro della Pace voluto da Vespasiano e concluso da Domiziano. I suoi resti sono oggi sotto via dei Fori Imperiali.
La chiesa fu voluta da papa Felice IV nel 527. Fu rinnovata nel 1632 su disegno di L. Arrigucci. Il vestibolo antistante alla chiesa, verso il Foro Romano è il cosiddetto tempio del Divo Romaolo.
Per un lungo corridoio e un chiostro si passa nella chiesa ad unica navata. Nell'abside mosaici del VI secolo. Nell'atrio si trova un grande presepe napoletano del Settecento. Uscendo si noti la parete esterna del convento con i buchi lasciati dalle grappe che reggevano la Forma Urbis.
BIBLIOTECA DI AGAPITO
piazza san Gregorio (al Celio)
L’edificio che ospitava la biblioteca si vede dal Clivo di Scauro, adiacente al complesso di San Gregorio al Celio. Si tratta di un’aula absidata in muratura che per tecnica costruttiva è da datare nella tarda epoca romana. Il papa Agapito fu sul trono di Pietro dal 535 al 536, è riconosciuto come santo dalla chiesa cattolica (anni di inizio della guerra gotica). Di questa biblioteca ci resta una citazione in uno scritto di Cassiodoro e un’altra citazione nell’Anonimo di Einsiedelm, un ignoto pellegrino dell’VIII secolo che ha lasciato un elenco dei monumenti romani ancora esistenti ai suoi tempi (rivenuto nell’abbazia svizzera omonima).
Un altro edificio, poco più avanti, sulla stessa strada, con facciata a filo della carreggiata, appartenne alla biblioteca di Agapito.
BIBLIOTECA HERTZIANA
via Gregoriana 30
Casa dei Mostri. E' una strana costruzione fatta edificare da Federico Zuccari[10] alla fine del Cinquecento. Ha questo nome perchè la porta e le finestre sono bizzarramente decorate con grosse teste di mostri con la bocca spalancata e lo Zuccari non la vide finita. Non è difficile vederci una similitudine con la villa Orsini di Bomarzo. L'artista lasciò ai figli grossi debiti contratti per la costruzione di questa casa tanto che essi furono costretti prima ad affittarla e poi a venderla. Servì da abitazione a molti artisti: Angelica Kauffmann, Winkelmann, Overbeck e D'Annunzio che vi ambientò alcune pagine del Piacere. Alla fine dell'Ottocento fu comperata da Enrica Hertz che vi raccolse gran numero di opere scientifiche costituendo la cosiddetta BIBLIOTECA HERTZIANA. Nel 1913 la biblioteca fu donata in lascito allo stato tedesco che l'ha aperta al pubblico. Oggi la biblioteca si compone di 287.000 volumi dedicati all'arte italiana, in particolare rinascimentale e barocca, ma anche all'arte romana post classica (il testo più antico è del 1475). Inoltre possiede una fototeca di 900.000 volumi. Nel palazzo dei Mostri si trova la sala di lettura, uffici e depositi. Nelle cantine è stata rinvenuta una facciata di epoca repubblicana in opera reticolata forse riferibile alla villa di Lucullo.
Un importante intervento di restauro e di ampliamento è stato condotto su progetto dell'arch. madrileno Juan Navarro Baldeweg che si è ispirato a criteri di luminosità e leggerezza. Il concorso è stato vinto nel 1995, i lavori sono stati condotti nel 2001-11,l'inaugurazione èavvenuta l'1 febbraio 2013. Il cortile lucernaio ha intorno a se le sale di lettura disposte su quattro livelli come ballatoi fino alla terrazza sommitale che richiama gli ambienti della villa di Lucullo[11].
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ALESSANDRINA
Città Universitaria
piazzale Aldo Moro
Nel palazzo del Rettorato di Marcello Piacentini[12] con alto pronao a pilastri su ampia scalea. La biblioteca fu fondata da Alessandro VII Fabio Chigi, inaugurata nel 1670 e trasportata alla Sapienza nel 1935. Il nucleo storico delle raccolte della biblioteca è costituito dai duplicati della biblioteca Chigiana (1644), dai 423 duplicati della biblioteca Vaticana e da una parte della preziosa biblioteca dei duchi di Urbino (1666). A questo “fondo antico” si uniscono, a partire dal 1815, gli esemplari delle opere stampate nello stato Pontificio e, dal 1870 gli esemplari di quelle stampate da tipografie della provincia di Roma. Nel 1935, con il trasferimento in questa sede, vengono depositate qui le preesistenti biblioteche di Lettere, Giurisprudenza e Scienze Politiche. Successivamente ha ricevuto importanti donazioni come il fondo Vittorio Rossi, il fondoSchupfer e il fondo Chiovenda.
In base alla legge regionale 106 del 2004 tutti i documenti di interesse culturale pubblicati da editori della provincia di Roma vengono depositati legalmente in questa biblioteca. Oggi è una biblioteca pubblica statale che dipende, dal 1975 dal Ministero dei Beni e Attività Culturali. Il suo catalogo è consultabile on line[13].
SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE DI ROMA
Il sistema delle Biblioteche di Roma è nato nel 1996 con Rutelli sindaco, unificando e promuovendo la nascita di nuove biblioteche che fino ad allora facevano capo alle circoscrizioni. Questa nuova forma di gestione ha permesso un maggiore coordinamento e agilità nella gestione, ha consentito di avviare un processo di rinnovamento e di riqualificazione di tutto il servizio e delle sue sedi.
La sua finalità è quella di garantire il diritto alla cultura e all'informazione, promuovendo lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme.
Le biblioteche sono dislocate su tutto il territorio comunale, chiunque può liberamente entrare, sfogliare i libri oppure chiederli in prestito. I bibliotecari sono a disposizione per ogni informazione. Nelle biblioteche ci sono libri di tutti i tipi e su qualsiasi argomento, ma non solo libri, anche giornali, riviste, video, cd musicali e multimediali. In quasi tutte le biblioteche vi sono postazioni per la consultazione di internet[14].
Questo l'elenco delle biblioteche di Roma:
PRIMO MUNICIPIO
Biblioteca Rispoli in piazza Grazioli 4
Biblioteca Enzo Tortora in via Nicola Zabaglia 27b
Biblioteca Giordano Bruno in via Giordano Bruno 47
Biblioteca della Casa della Memoria e della Storia in via San Francesco di Sales 5
Biblioteca della Casa delle Traduzioni in via degli Avignonesi 32.
SECONDO MUNICIPIO
Biblioteca Europea in via Savoia 15
Biblioteca Flaminia in via Cesare Fracassini 9
Biblioteca Villa Leopardi in via Makallè
Biblioteca Villa Mercede, via Tiburtina 113
Biblioteca Villa Mercede, sezione ragazzi in via dei Sardi 35.
TERZO MUNICIPIO
Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39
QUARTO MUNICIPIO
Biblioteca Vaccheria Nardi, via Grotta di Gregna 37
Biblioteca Centro Culturale Aldo Fabrizi via Corinaldo (San Basilio)
QUINTO MUNICIPIO
Biblioteca Gianni Rodari, via Tovaglieri 237 (Tor Tre Teste)
Biblioteca Goffredo Mameli, via del Pigneto 22
Biblioteca Penazzato, via Dino Penazzato 112 (Collatino-Gordiani)
Teatro Biblioteca Quarticciolo, via Castellaneta 10.
SESTO MUNICIPIO
Biblioteca Borghesiana, largo Monreale snc (Vermicino)
Biblioteca Rugantino, via del Rugantino 113 (Torrespaccata)
SETTIMO MUNICIPIO
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21 (San Giovanni)
Biblioteca Casa dei Bimbi, via Libero Leonardi 153 (Cinecittà Est)
Biblioteca Raffaello, via Tuscolana 1.111 (Osteria del Curato)
OTTAVO MUNICIPIO
Bibliocaffè letterario via Ostiense 95 (ex mercati generali)
NONO MUNICIPIO
Biblioteca Pier Paolo Pasolini, v.le Caduti della Resistenza 410/a (Spinaceto)
DECIMO MUNICIPIO
Biblioteca Elsa Morante, via Adolfo Cozza 7 (Ostia)
Biblioteca Sandro Onofri, via Umberto Lilloni 39/45 (Acilia)
UNDICESIMO MUNICIPIO
Biblioteca Renato Nicolini, via Marino Mazzacurati 76 (Corviale)
Biblioteca Guglielmo Marconi via Gerolamo Cardano 135 (Marconi)
BiblioTrulloTeca, via Monte delle Capre, 23 (Trullo)
DODICESIMO MUNICIPIO
Biblioteca Casa dei Teatri, via di San Pancrazio
Biblioteca Colli Portuensi, viale dei Colli Portuensi
Biblioteca Longhena, via B. Longhena (Pisana)
TREDICESIMO MUNICIPIO
Biblioteca Cornelia, via Cornelia 45 (Montespaccato)
Biblioteca Valle Aurelia, v.le di Valle Aurelia 129
QUATTORDICESIMO MUNICIPIO
Biblioteca Casa del Parco, via della Pineta Sacchetti, 78
Biblioteca Franco Basaglia, via Federico Borromeo 67 (Primavalle)
QUINDICESIMO MUNICIPIO
Biblioteca Galline Bianche, via delle Galline Bianche 105.
Elenco aggiornato al 15.07.13
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
Tutte le notizie sono state prese dalla guida rossa del Tci, dal sito internet wikipedia.org, sapere.it e per ogni singola biblioteca si deve far riferimento alla nota con i testi e i siti consultati.
AGGIORNAMENTI
29.10.14E’ la notte bianca delle Biblioteche del Comune di Roma, si chiama bibliopride, tredici biblioteche aperte fine alle 24. A Villa Mercede Francesca Reggiani presenterà il suo libro “L’angelo delle nove”. Alla bibliteca Nicolini di Corviale si celebra la street art. Al bibliocafè di via Ostiense si leggeranno le poesie di James. Alla Mandela di via La Spezia documentario sull’omofobia. Alla Rispoli di piazza Grazioli lo scrittore Paolo di Dono parlerà del libro “Mandami tanta vita”. Alla Elsa Morante a Laurentino 38 Miles Davis l’autobiografia. Coinvolte anche la casa dei Teatri, la biblioteca Basaglia, la Mameli al Pigneto e villa Leopardi.
21.12.14 Biblioteca di Renato Nicolini. Composta di 12.000 volumi, definita di interesse culturale dalla Regione Lazio e donata al Comune di Roma sarà ospitata dall’archivio Storico Capitolino. Occuperà una sala allestita appositamente .
7.3.15 Biblioteche di Roma. L’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano donerà i suoi libri alle biblioteche nel quadro dell’iniziativa Ho in testa un libro con la quale i cittadini di Roma hanno donato 2.000 libri. Presto si apriranno altre due biblioteche, una a Torpignattara e un’altra a Finocchio, alla Collina della Pace.
05.11.15Biblioteca Nazionale. Una sala espositiva permanente dedicata a Pier Paolo Pasolini per i 40 anni dalla morte del poeta, presente il ministro Franceschini. La biblioteca ospiterà fino al 31 marzo una mostra fotografic sulle borgate romane con scatti tratti dall’archivio Rodrigo Pais. Comincerannonel 2016 i lavori di ristrutturazione di tutta l’area sottostante la biblioteca che sarà destinata a depositi. I lavori saranno finanziati con i fondi provenienti dalla legge di Stabilità, tra i 5 e i sei milioni. Si aggiunge all’area dedicata a Elsa Morante.
30.1.16 Biblioteche comunali. Dimezzate le iscrizioni da 31.000 a 16.000. In calo anche i prestiti. De Mauro: “Standard internazionali da rispettare o la cultura diventa un lusso riservato a pochi”.
22.11.16 Biblioteca Vaticana. 80.000 manoscritti on line. Siamo alla fase finale della digitalizzazione, usata la tecnologia della Nasa per “scannerizzare i documenti”.
[1] Icunabolo o incunabulo dal latino "in culla". Si riferisce ad un documento stampato con la tecnica dei caratteri mobili realizzato tra la metà del XV secolo e l'anno 1550 incluso. A volte è detto anche quattrocentina. Non presentano frontespizi. Sono i primi libri moderni, cioè realizzati in serie con delle modalità proto industriali, ma circa 10.000 dei 40.000 testi noti sono costituiti da fogli sciolti perchè erano bandi, proclami, lettere di indulgenza, modulistica. 1/4 degli icunaboli si trovano in Italia. Il più antico è la Bibbia di Gutenberg del 1452.
[2] Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Tutte le notizie da: Guida di Roma del Tci, bncrm.librari.beniculturali.it.
[3] Antonio Sarti (Budrio 1797-Roma1880), architetto. Formatosi all’Accademia di Bologna si trasferì a Roma. Influenzato da Stern e Valadier, costruì a Terracina la chiesa di San Salvatore, il suo capolavoro. A Roma lavorò in palazzo Grazioli, a villa Torlonia, realizzò la Manifattura Tabacchi con l’area circostante.
[4] Giacomo Della Porta (Genova 1533 - Roma 1602), architetto e scultore, allievo e aiuto del Vignola, costruì la chiesa del Gesù a Roma, la chiesa di Santa Maria ai Monti, la fontana di piazza Colonna, la fontana del Tritone, la fontana delle Tartarughe in piazza Mattei, le fontane minori in piazza Navona. E’ passato alla storia per aver realizzato la cupola di Michelangelo in San Pietro dopo la morte del grande artista, la facciata di palazzo Altemps.
[5] Filologia è un insieme di discipline che studiano i testi letterari al fine della ricostruzione della loro forma originaria attraverso l'analisi delle fonti e con lo scopo di raggiungere una interpretazione la più corretta possibile. Dal greco amante, amico della parola, del discorso.
[6] Biblioteca Casanatense. Tutte le notizie da guida di Roma del Tci e casanatense.it.
[7] Biblioteca Vallicelliana. Tutte le notizie da guida di Roma del Tci e vallicelliana.it.
[8] Carlo Rainaldi (Roma 1611-1691) Autore della facciata della chiesa di Santa Maria in Campitelli e dell'abside di Santa Maria Maggiore. Facciata di Sant'Andrea della Valle. La chiesa del Suffragio in via Giulia, la cappella Spada nella Chiesa Nuova, la tomba di Clemente IX in Vaticano. Presentò un progetto per il Louvre.
Collaborò con il padre Girolamo (Roma 1570-1655 catafalco per Alessandro Farnese al Gesù e a Sisto V in Vaticano, chiesa di santa Teresa a Caprarola e santa Lucia a Bologna, tomba Sfrondati in Santa Cecilia in Trastevere) sia nel Palazzo Nuovo al Campidoglio che nel palazzo Pamphili in piazza Navona. Suo il progetto delle chiese gemelle di piazza del Popolo.
[9] Biblioteca Teatrale. Tutte le notizie da: Guida di Roma del Tci e burcardo.org.
[10] Federico Zuccari (Sant'Angelo in Vado nelle Marche 1539 - Ancona 1609) pittore di stile manierista, la sua opera maggiore è il Giudizio Universale nella cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, a Roma ha lavorato nella chiesa della Trinità de Monti, nell'Oratorio del Gonfanlone, in San Marcello al Corso. Ha lavorato in palazzo Farnese di Caprarola. Sue opere sono nei principali musei del mondo. Era fratello minore di Taddeo.
[11] Nuova biblioteca Hertziana le notizie da: edilportale.com e altbiblhertz.it
[12] Marcello Piacentini (1881-1960) ponte Aventino nel 1917, cinema Corso in piazza San Lorenzo in Lucina nel 1915, palazzo per la Banca d'Italia in piazza del Parlamento, nel 1920 pianificazione della Garbatella con Giovannoni, teatro Quirinetta in via Minghetti, hotel Ambasciatori a via Veneto con Vaccaro, Casa Madre dei Mutilati in piazza Adriana, cinema Barberini nella piazza omonima, nel 1932-35 pianificazione della Città Universitaria con il palazzo del Rettorato e della biblioteca Alessandrina, chiesa di Cristo Re in viale Mazzini nel 1924-34, il palazzo della Banca Nazionale del Lavoro a via Veneto, sventramento della spina dei Borghi, piano regolatore dell'E42 con Auditorium in via della Conciliazione, cinema Fiamma, chiesa della città universitaria, teatro Sistina, nuova facciata del teatro dell'Opera, palazzo dello Sport all'Eur con Pier Luigi Nervi.
[13] Biblioteca Universitaria Alessandrina. Tutte le notizie dalla Guida di Roma del Tci e da alessandrina.librari.beniculturali.it.
[14] Sistema delle Biblioteche di Roma. Tutte le notizie da: bibliotechediroma.it
SAN LORENZO
DELIMITAZIONE
Tra via Tiburtina, piazzale del Verano, il Verano stesso, scalo merci San Lorenzo e le mura Aureliane. Per il comune di Roma è il VI quartiere: Tiburtino. Fa parte del II Municipio del comune di Roma.
TOPONOMASTICA
Le strade sono intitolate ai popoli italici pre-romani.
STORIA
Sorto come intervento di edilizia a destinazione popolare. L’edificazione dell’area iniziò nel 1878 a sud della Tiburtina, riproponendo in tono più dimesso l’eclettismo che caratterizzava i quartieri borghesi del tempo (Esquilino, Prati), mentre all’interno le esigenze di sfruttamento intensivo imposero in alcuni casi l’adozione della tipologia a ballatoio rara per Roma. E’ qui che nel 1907 Maria Montessori aprì la prima Casa dei Bambini. L’edificazione si concluse negli anni Trenta. La sua posizione, al di fuori delle mura cittadine contribuì ad isolarlo dal contesto urbano.
Agli inizi del Novecento nacquero due fabbriche: la Paszko-wsky poi birra Wurer nel 1902 e il mulino e pastificio Cerere nel 1905. Nel 1906-09 si costruisce la parrocchia dell’Immacolata.
Nel primo dopoguerra nacquero le sezioni del partito Popolare, del partito Repubblicano e del partito Socialista dotato di una biblioteca con enciclopedia. Fatto importante è che queste furono frequentate sia da uomini che da donne. Si formarono spontaneamente gli Arditi del Popolo, associazione comprendente democratici di varia provenienza che avevano come obiettivo di resistere alle squadracce fasciste.
Durante la marcia su Roma del 1922 il quartiere si oppose validamente alle formazioni fasciste come avvenne a Testaccio e Trionfale.
Il 19 luglio 1943 alle undici del mattino il quartiere fu colpito dal famoso bombardamento alleato. L’unica breve relazione italiana parla di 3.000 bombe sganciate e di oltre 2.000 morti e 2.000 feriti, in realtà si è accertato successivamente che i morti furono non meno di 3.000 e i feriti tra gli 11.000 e i 12.000. Si verificò immediatamente un massiccio esodo degli abitanti anche con il ritorno ai paesi di origine (in genere paesi dell’Italia centrale), il quartiere restò quasi deserto e le infrastrutture distrutte. La ricostruzione eliminò gli ultimi spazi non costruiti e fu accompagnata da una spinta di immigrazione proveniente dal Sud Italia.
Nel dopoguerra visse nel quartiere Giovanni Fontana detto Nino, esponente di spicco della malavita romana. Dagli anni Sessanta il quartiere ha mutato il carattere popolare per divenire sede di attività terziarie, molte attività industriali hanno chiuso, molte abitazioni sono state affittate a studenti per la vicinanza con la città universitaria (con i suoi 140.000 iscritti è l’università più grande d’Europa). La costruzione degli edifici di Neuropsichiatria infantile in via dei Reti - via dei Piceni e la Tangenziale Est nel 1973 mutano il volto del quartiere.
Negli anni Settanta fu sede di Lotta Continua e di Autonomia Operaia in via dei Volsci, oltre che di radio “libere”. Grazie alla presenza degli studenti, la facoltà di psicologia ha sede nella ex birreria Wuhrer, il quartiere è ricco di librerie, pub, birrerie, pizzerie, osterie, enoteche, associazioni culturali (“Ristoranti di Roma 2007/08”, ed. Repubblica, conta 44 locali di vario tipo) . Oggi San Lorenzo è considerato il quartiere universitario di Roma simile al quartiere Latino di Parigi.
La toponomastica è riferita ai popoli italici pre romani (da Guida di Roma del Tci, 1993, pag.733-4, da wikipedia.org, da vivisanlorenzo.it).
ITINERARIO
L’itinerario non può che iniziare dalla Basilica di San Lorenzo fuori le mura.
BASILICA DI SAN LORENZO FUORI LE MURA
Risulta dall’unione di due chiese: quella anteriore è del XIII sec., fu voluta da papa Onorio III, quella posteriore è del IV eretta da Costantino sulla tomba del martire Lorenzo. La chiesa ospita inoltre le spoglie di santo Stefano, primo martire cristiano.
Nel portico a sinistra la tomba di Alcide De Gasperi opera dello scultore Giacomo Manzù.
Interno. Nella controfacciata un sarcofago con scena nuziale del III secolo utilizzato come tomba dei Fieschi. Pavimento, amboni e candelabro pasquale cosmateschi sono del XIII secolo.
Fondo navata destra: Cappella di San Tarcisio di Vespignani.
Fondo navata sinistra: Cappella sotterranea di santa Ciriaca con le tombe Aleandri e Guglielmi su disegno di Pietro da Cortona.
Confessione: tomba di san Lorenzo di Virginio Vespignani.
Presbiterio: trabeazione con trofei di armi e foglie,
pavimento cosmatesco,
ciborio, firmato e datato 1148, il più antico che abbia la firma,
cattedra episcopale del 1254.
Arco trionfale rivolto ai fedeli con mosaici.
Cappella di Pio IX.
Dalla cappella di San Tarcisio si accede al chiostro del XII secolo in cui vi è l’ingresso alle catacombe di Ciriaca o di San Lorenzo.
(da Guida di Roma del Tci, 1993).
Foto della basilica bombardata in Pafi Benvenuti, Roma in guerra, ed. Oberon, 1985, pag.6.
Il 19 giugno 2007 le più importanti agenzie di stampa italiane riportano la notizia che il Santo Graal si trova a Roma proprio in questa basilica, a sostenere l’ipotesi è l’archeologo Alfredo Barbagallo che ha compiuto ricerche in questo senso negli ultimi due anni (da wikipedia.org).
Sul piazzale di san Lorenzo monumento al papa Pio XII (Eugenio Pacelli 1939-1958) di Antonio Berti del 1967, che si recò in visita al quartiere subito dopo il bombardamento del 19 luglio 1943. Si passa nel contiguo piazzale del Verano, qui è l’ingresso al cimitero omonimo.
IL VERANO
Il Verano è il Cimitero Monumentale di Roma la cui entrata è presso la basilica di San Lorenzo fuori le Mura, deve il suo nome alla gens Verani, senatori dai tempi della repubblica. La zona era da sempre luogo di sepoltura perché si trovava lungo una antichissima via consolare, la Tiburtina. Nelle catacombe di Santa Ciriaca fu sepolto San Lorenzo, sulla cui tomba sorse la basilica. Durante il dominio francese su Roma venne applicato l’editto di Saint Cloud (ordinanza del 19 luglio 1809) che stabiliva che tutte le sepolture dovessero essere fuori dai centri urbani. Il progetto del cimitero di deve a Giuseppe Valadier, lo stesso autore di piazza del Popolo tra il 1807 e il 1812. Con la restaurazione i papi mantennero l’uso del cimitero. Sotto la direzione di Virginio Vespignani venne realizzato il quadriportico d’ingresso (1880), dopo l’unità d’Italia il cimitero si ingrandì ancora fino ad acquistare villa Mancini, zona oggi denominata il Pincetto. Dagli anni Sessanta nel cimitero possono essere sepolte solo le persone che dispongono di cappelle di famiglia, da allora le sepolture avvengono nel cimitero Flaminio detto dai romani di Prima Porta. Il 19 luglio 1943 un terribile bombardamento degli alleati, che aveva lo scopo di colpire lo scalo ferroviario, causò gravissimi danni nel vicino quartiere di San Lorenzo e la morte di circa 1.000 persone. Anche il cimitero venne colpito, furono danneggiati il quadriportico, il Pincetto, il sacrario militare e il crollo di un tratto di mura a destra dell’ingresso causando la morte di alcune persone che vi avevano cercato riparo. Anche le tombe di Petrolini e della famiglia Pacelli subirono danni.
Nel cimitero vi hanno lavorato e lasciato traccia di se tre generazioni di architetti e ingegneri. La prima generazione ha intrecciato la propria opera con le prime costruzioni, dai progetti di Valadier a quello di Vespignani. La seconda generazione fu attiva con Roma capitale del nuovo stato unitario ed è la stessa che ha dato il nuovo volto alla citta: Gaetano Koch (Banca d’Italia, Piazza Esedra, Piazza Vittorio) e Giuseppe Sacconi (Vittoriano). A questa generazione appartiene anche Corrado Cianferoni attivo nell’ampliamento e autore di numerose tombe di stile floreale. La terza generazione operò negli anni Venti ed è rappresentata da Gustavo Giovannoni e Marcello Piacentini.
L’ingresso al cimitero è caratterizzato da tre fornici con quattro grandi statue de: la Meditazione, la Speranza, la Carità e il Silenzio. Per l’importanza storica e culturale da alcuni anni si organizzano visite guidate al cimitero stesso. Molti sono gli artisti degli ultimi due secoli che hanno realizzato tombe e sculture: Duilio Cambellotti, Mirko Basaldella, Raffaele De Vico e tanti altri.
Entrando, subito a destra si trova il monumento funebre a Virginio Vespignani. Procedendo nel viale centrale al primo incrocio, a sinistra si vede il grande monumento a Goffredo Mameli (ricordo), a destra quello a Ricciotti Garibaldi. Avanzando ancora e superato un altro incrocio si arriva al Quadriportico. Al centro si trova la statua di Cristo che ascende al cielo di Leopoldo Ansiglioni. Lo percorriamo in senso antiorario. Al primo angolo si trova il monumento a Tommaso Minardi del 1876 di Fontana, mentre sul lato lungo, verso la fine il monumento all’ammiraglio Saint Bon (Chambery 1828 – Roma 1892, ammiraglio, politico e senatore del Regno, fu primo capo di stato maggiore della Marina e ministro della Marina in più governi) del 1895 di Donati. A metà di questo primo lato lungo, ma sull’esterno del quadriportico si trova la tomba a Giuseppe Capogrossi, pittore. Sul lato corto del quadriportico, dopo la cappella di Santa Maria della Misericordia, all’ultimo angolo, ecco il monumento al generale Enrico Cosenz (Gaeta 1820 – Roma 1898, generale politico, prima ufficiale del Regno delle Due Sicilie, eroico difensore di Venezia, ufficiale di Garibaldi, capo di Stato Maggiore dell’esercito italiano, deputato e senatore). Sul lato lungo, prima della metà, si trovano il monumento al generale Giacomo Medici (Milano 1817 – Roma 1882, generale e politico, uno dei più valenti ufficiali di Garibaldi, prefetto in Sicilia, quindi generale dell’esercito italiano, si è distinto nella III guerra d’indipendenza) del 1884 di Monteverde e il monumento a Erminia Fuà Fusinato (Rovigo 1834 – Roma 1876, poetessa, educatrice e patriota) del 1876 di Galletti.
Giunti a metà di questo lato lungo si sale al Pincetto per una ripida scalinata. Il muro di cinta del Pincetto è opera di Pietro Camporese il Giovane[1]. Giunti in cima si prende il viale principale, poco dopo a destra si trova una deviazione, ecco in fondo ad essa un monumento circolare è quello al cardinale Antonelli, segretario di Stato di Pio IX. Ritornando sui nostri passi, riprendendo il viale principale, dopo poco si devia a destra e si trova un altromonumento circolare quello per i Caduti Pontifici della battaglia di Mentana.
Adiacente al Pincetto è il Pincetto Nuovo, ben presto si individua un piazzale circolare con la rampa Caracciolo di C. Cianferoni. Nel piazzale circolare si trovano: la Cappella Barbavara di C. Cianferoni (riquadro 4), il serbatoio dell’Acqua Marcia di G. Ersoch e la Cappella Riccini Margarucci di A. Leonori (riquadro2). A Nord del piazzale circolare si trovano la Cappella Del Drago di G. Koch e la Cappella Koch della stesso architetto. Più ad Ovest, sempre nel Pincetto Nuovo si trovano la Cappella Viola di Corrado Cianferoni e Ettore Ferrari (riquadro 29), la cappella di Giulio Monteverde nel riquadro 28, e la cappella di Cesare Maccari nel riquadro 81. Tra il piazzale circolare e la rampa Caracciolo si trova la Cappella Donati Sacconi di G. B. Giovenale (riquadro 68).
La Rampa Caracciolo è situata a Nord Est del Pincetto Nuovo ed è separata da questo dal viale delle Cappelle, nel portico della rampa Caracciolo si trova la tomba di Armando Brasini. Nella Rampa Caracciolo si trova la Cappella di Enrico Prampolini, pittore. Nella Rupe Caracciolo, situata subito a Est del Pincetto Nuovo (arcata 22), si trova la cappella Piacentini di Pio Piacentini. In viale delle Cappelle, nel tratto che separa la Rampa Caracciolo dall’Altopiano Pincetto, si trova la Cappella Ettore Ximenes.
A Nord Ovest del Pincetto Nuovo si trova l’Altopiano Pincetto. Tra il viale della Marina e il viale delle Cappelle si trovano: la Cappella Borrelli di G. B. Giovenale (riquadri 59 e 60), la cappella Di Rudinì di E. Basile (riquadro 58); la cappella Bazzani di Cesare Bazzani (riquadro 57); la cappella Macchi di Vincenzo Fasolo (riquadro 57) e la cappella Acanfora di Marcello Piacentini nel riquadro 55. Invece, posizionata più a Ovest, ma sempre nell’Altopiano Pincetto, si trova la cappella di Nino Costa, nel riquadro 30.
Ancora a Nord Ovest dell’Altopiano Pincetto si trova il Bassopiano Pincetto. Nel riquadro 139 si trova la Cappella di Giacomo Balla, pittore tra i massimi del movimento futurista.
Nel cimitero monumentale del Verano si trova un imponente e spettacolare monumento che ricorda le vittime della Grande Guerra. E’ collocato sul margine Est, lungo la tangenziale. Una parete di marmo bianco concava reca i nomi di tutti i romani caduti. E’ opera del 1926 dell’arch. Raffaele De Vico, il celebre architetto dei giardini romani (Villa Glori, Giardini di piazza Mazzini, Colle Oppio, ampliamento dello zoo con l’uccelliera, parco Nemorense e parco Savello sull’Aventino, serbatoio idrico di porta Maggiore). Al di sotto vi è una grandiosa cripta a pianta circolare dalla quale si accede da due scale circolari. E’ denominato Monumento Ossario ai Caduti della Guerra 1915-18. Tale monumento si vede anche dall’esterno del cimitero, passando da via Tiburtina e guardando dall’ingresso / cancellata di Portonaccio.
Nella vicina zona militare, riquadro 83 bis, si trova il Monumento ai marinai del Sebastiano Veniero di Publio Morbiducci[2].
Si tratta di un sommergibile italiano intitolato al doge veneziano che, all’età di 75 anni partecipò alla battaglia di Lepanto. Durante la II guerra mondiale il sommergile si trovava in viaggio tra Cagliari e le Baleari. Alle ore 16,25 del 29 maggio 1942 segnalò di aver avvistato unità nemiche. Alle ore 23,30 lanciò un altro messaggio che non fu possibile decifrare. Dopo di allora non diede più notizie di sé. A guerra finita si seppe che il 7 giugno un sommergibile italiano era stato attaccato da unità aeree nelle prime ore del mattino, un altro attacco verso mezzogiorno quando era in superficie danneggiato. Con il sommergibile scomparvero il comandante Zappetta, 5 ufficiale e 52 sottufficiale e marinai, l’intero equipaggio. Secondo alcune fonti vi sarebbero due sopravvissuti, un secondo capo e un sergente elettricista morto nel 2009, quest’ultimo affermò che il sommergibile era stato silurato dagli inglesi.
IL VERANO NEL CINEMA
Il Verano è stato spesso protagonista nel cinema. Nel film La grande Bellezza di Paolo Sorrentino (2013), il protagonista Jep (Beppe Servillo) vi si reca per il funerale di Elsa De Santi, la donna era stata il suo primo amore. Qui il marito della scomparsa chiede aiuto a Jep. Si riconosce molto bene il Quadriportico, i due scendono le scale che conducono al Pincetto, passa un gruppo di suore.
Nella parte nuova si trova la tomba monumento a Claretta Petacci (28.2.12 – 28.4.45). Nata a Roma da padre medico, titolare di una clinica, abitava alla Camilluccia, aveva 20 anni quando conobbe Mussolini che aveva 30 anni più di lei. Si conobbero ad una gita in auto verso Ostia nel 1932, allora era fidanzata con Riccardo Federici tenente dell’aeronautica, con lui si sposò, quindi si separò legalmente nel 1936. La famiglia fece affari con il regime, soprattutto il fratello Marcello Petacci. Dopo l’8 settembre si trasferì a Gardone.
Il 15 luglio 2003 è stato inaugurato il Centro di Documentazione dei Cimiteri Storici di Roma dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Collocato all’ingresso del portico è aperto su richiesta, nella settimana della Cultura (in primavera) e nel periodo della commemorazione dei defunti. Video, fotografie, proiezioni e cataloghi informatizzati costituiscono il materiale che si può consultare nel centro.
Si arriva all’incrocio tra via Tiburtina e via dei Reti .
Prendendo via dei Reti si trova sulla destra
EX VETRERIA SCIARRA
Edificio industriale realizzato nel 1926, riqualificato ora è sede della facoltà di filosofia, lettere, scienze umanistiche e studi orientali dell’università la Sapienza (Tutte le notizie da Open House 2015).
Sempre sulla destra, ai n. 44 -46 il ristorante Tram Tram. La gestione familiare attinge alle ricette del meridione per i primi piatti e a quelle romane per i secondi. Da non perdere l’antipasto con il purè di fave con cicoria, tra i primi le orecchiette con i broccoli e vongole. Le sale sono decorate con elementi ferroviari riciclati in modo straordinario per trasformarsi in portabottiglie e panche per l’angolo bar (da Roma. Viaggiare con stile. L’Espresso, 2006).
Sul lato opposto al n.25 si trova il pub Sotto casa di Andrea un’associazione culturale con un calendario sempre pieno di eventi (da Ristoranti di Roma 2007/08, ed. Repubblica).
Si percorre tutta via di Reti, giunti in fondo si trova il largo Settimio Passamonti, tenendosi a sinistra eccoci in via del Verano, qui al civico 27 si trova il locale 00100. Si tratta di un ristorante di nuova concezione frequentato soprattutto da giovani. Ristorante di specialità pesce nei locali di una vecchia posta dell’Ottocento, in un ambiente dal design ricercato. Altra caratteristica il brunch della domenica, con soli 15€ a persona si mangia senza limiti compreso bevanda e caffè. Ache pizzeria, dispone di un giardino.
Tornando all’incrocio si prende via Tiburtinain direzione del centro storico. Subito sulla destra:
palazzina al n. 207 di via Tiburtina, impreziosita dalle maioliche policrome, in una di queste tre persone in costume affacciate dalle finestre. Versa in stato di grave degrado (da Guida di Roma del Tci, cit.). Proseguendo su via Tiburtina, sulla sinistra spicca il
PASTIFICIO CERERE
pastificio Cerere del 1905, il più interessante esempio di archeologia industriale del quartiere (da Guida di Roma del Tci, cit. che riporta invece l’anno 1911, ma Repubblica il 19 maggio 2005 parla di festeggiamenti per i 100 anni dell’edificio). Così chiamato in onore della dea delle messi, fu costruito in vari tempi su progetto dell’ing. Pietro Satti. Dismessa la produzione nel 1960, alla fine degli anni Settanta l’edificio fu occupato da un gruppo di artisti che ne fecero la sede del loro atelier, per questo furono definiti “Gruppo di San Lorenzo” o “Scuola Romana di San Lorenzo”. Essi sono: Nunzio, Bruno Ceccobelli, Gianni Dessì, Giuseppe Gallo, Piero Pizzicannella e Marco Tirelli. Fu il critico Achille Bonito Oliva, nell’estate 1984 a rendere celebre il luogo con la mostra “Atelier” (da sito internet fondazionepastificiocerere.it). Scrive Marco Lodoli: “Palazzo che ormai è una leggenda nella storia dell’arte cittadina… Roma è una città viva dove sempre fioriscono bellezza e intelligenza” (da Repubblica 8 settembre 2002).
Per trovare l’entrata girare alla prima a sinistra in via degli Ausoni 7a (galleria Pino Casagrande – dal nome del magnate del tessile).
Continuando invece in via Tiburtina al civico 135, cioè sulla destra, c’è “un’ambascita della felicità, un’enclave di dolcezza tra le amarezze della vita”, un edificio di 1.000 metri quadri, dal 1923 la SAID Società Anonima Italiana Dolciaria, unica vera fabbrica capitolina del cioccolato, della famiglia De Mauro, sulle pareti orologi segnano l’ora di Caracas, Santo Domingo, Darei Salam, Papua, Avana, Antananarivo… ci fanno compagnia immagini di bastimenti in viaggio da quei luoghi esotici…” Marco Lodoli da Repubblica del 5 novembre 2006. In Ristoranti di Roma 2007/2008, ed. Repubblica, il locale è chiamato B-SAID dove la B sta per bar.
Più avanti sulla Tiburtina al civico 190 c’è la pizzeria Il gatto e la volpe, anche osteria, ai tavoli serve Baffo il proprietario, la griglia è sempre accesa, 90 posti, spesa media 12 € (da Ristoranti, cit.).
PIAZZA DEI SANNITI
Proseguendo in via degli Ausoni si raggiunge piazza dei Sanniti, un rombo nella maglia ortogonale delle strade del quartiere.
In piazza dei Sanniti 44 è il ristorante Pommidoro frequentato dalla comunità di artisti del vicino pastificio Cerere e dai calciatori della Roma. Il servizio è cordiale e alla mano, i camerieri danno del tu ai clienti, il proprietario Aldo esce spesso dalla cucina per raccontare aneddoti del locale. La carne alla griglia è una delle specialità della casa, assieme agli spaghetti alla carbonara e alla gricia (con pancette e pepe macinato). L’ultima cena di Pier Paolo Pasolini, il 2 novembre 1975, prima di andare incontro alla sua tragica fine, la consumò in questo ristorante da lui abitualmente frequentato. L’assegno con il quale lo scrittore pagò la cena è incorniciato ed appeso nella sala del ristorante da (wikipedia.org).
Al n 42 della piazza e in via dei Volsci 75 si trova la gioielleria artigiana Myriam B, ovvero la milanese Miriam Bottazzi crea gioielli espressionisti da ormai vent’anni durante i quali si è guadagnata molti clienti specialmente tra gli stilisti (da Roma. Viaggiare con stile, cit.).
Da piazza dei Sanniti si prende via dei Volsci in direzione centro della città.
Al primo incrocio girare a sinistra per via dei Sardi dove è al civico 37 la scuola elementare Saffi oggi facente parte dell’istituto comprensivo di via Tiburtina Antica 25, comprende la scuola Media Borsi, le scuole primarie nelle cliniche mediche, le scuole del carcere di Rebibbia e il II C.T.P. Per Natale 2007 la scuola elementare ha organizzato una mostra mercato, il ricavato di 700 € è andato all’Unicef, Emergency, Medici senza frontiere, Biblioteche Solidali e Banca popolare etica. Per la fine dell’anno la scuola ha bandito un concorso di poesia per tutti i bambini del III municipio intitolato “Ricordando Iqbàl”, l’ultimo giorno di scuola si è tenuto un pubblico spettacolo di danze italiane e africane (da scuolasaffiroma.it).
Ritorniamo indietro per via dei Sardi fino ad arrivare in via Tiburtina, all’angolo con via dei Marrucini c’è
VILLA MERCEDE
villa Mercede. Quando si costruì il quartiere il terreno apparteneva alla Banca d’Italia, nel 1913 la proprietà passò alla famiglia De Reinach e a Teresa Lemoine che vi costruirono un edificio di notevoli dimensioni detto “La Villetta”. Nel 1931 i proprietari cedettero al vicino Istituto Suore Ausiliatrici tutta la proprietà con l’edificio e la chiesa di Maria Ausiliatrice allora in fase di costruzione, progettata dall’arch. G. Gualandi e che sarebbe stata consacrata nel 1933. Nel 1975 l’area della villa su via Tiburtina fu acquistata dal Banco di Santo Spirito per destinarla a centro sportivo aziendale. Nel 1979, a seguito di una convenzione con il comune, fu aperta al pubblico. Nel 1983 la proprietà fu ceduta definitivamente al Comune con il teatrino oggi biblioteca. Nella parte privata rimangono oggi la villetta e la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice ora dedicata a San Tommaso Moro.
Nonostante le dimensioni abbastanza ridotte il parco, costituito da un ambiente fresco e ombroso è molto frequentato dagli abitanti del quartiere. E’ una tipica creazione di inizio Novecento, appena superato il cancello di ingresso inizia un vialetto a sampietrini, fiancheggiato da scogliere rustiche con evidenti tracce di nicchie, che si addentra nel bosco, sopraelevato rispetto al piano del viale, fitto di palme, pini, cedri e piante lussureggianti, sistemate sul modello dei giardini paesaggistici. Sul lato opposto due sentieri fiancheggiati da lecci da (comune.roma.it).
La biblioteca comunale del III municipio, ingresso da via Tiburtina 113, si sviluppa su 320 mq, possiede 13.000 volumi più altri 5.000 per bambini e ragazzi nella sede di via dei Sardi 35, possiede una sezione di audiolibri per non vedenti, una sala lettura con 30 posti, altri 10 posti per l’emeroteca, 3 postazioni internet, la responsabile è Maria Vittoria Persichilli. Nei locali della biblioteca si è conclusa il 31 gennaio 2007 la rassegna d’arte contemporanea: “Atelier d’artisti Fondazione Pastificio Cerere” (da sito internet biblioteca stessa).
Torniamo sui nostri passi fino a via dei Volsci angolo via dei Sardi, da lì riprendiamo via dei Volsci in direzione centro storico. In pochi passi si arriva all’incrocio con la breve via degli Etruschi. In questa strada al civico 9 visitiamo la Bottega del Mondo Engim, un negozio con prodotti equi e solidali provenienti dalle missioni dei Giuseppini del Murialdo distribuite in venti paesi del mondo, dom. e lun. chiuso a pranzo.
Si riprende via dei Volsci, presso largo degli Osci una curiosità, una strana insegna “Coltelli e profumi”, Marco Lodoli scrive che spesso si è chiesto il perché di questo strano abbinamento finchè un giorno è entrato nel negozio per chiedere lumi e il sig. Pette gli ha spiegato che ai primi del Novecento giunsero a Roma da Sant’Elena Sannita in provincia di Iseria tanti arrotini, costoro servivano soprattutto parrucchieri e barbieri ecco che iniziarono a vendere saponi e profumi e di qui l’abbinamento (da Repubblica del 25 maggio 2004 e dal libro Isole).
Al civico 85 di via dei Volsci il panificio Le bontà, ricco assortimento di dolci e salati prodotti dal proprietario Riccardo Ciotti, chiuso la domenica.
LARGO DEGLI OSCI
Continuando per via dei Volsci si giunge a largo degli Osci. Largo di forma triangolare ha al centro un mercato rionale scoperto – nato nel 1913 - che è stato riqualificato insieme alla piazza e aperto al pubblico il 18 luglio 2003. Si compone di 25 chioschi, ha 16 nuovi lampioni, belle foto d’epoca in bianco e nero lo delimitano. Sulla piazza, sempre animatissima, Cladio Sano (al civico 67a), Ferrazza (al 59 di via dei Volsci angolo largo degli Osci) e La piazzetta (al n.8).
Claudio Sano è un entusiasta artigiano del cuoio con grande talento creativo, produce sandali cuciti a mano, borse per donne, valigette con buco a forma di serratura, cinte, il tutto con un tocco surrealista (da Roma. Viaggiare con stile. Cit.).
Orlando Ferrazza gestisce una enoteca con una scelta di otre mille vini italiani in bottiglia e sfusi. Il menù di piatti leggeri servito nella piccola sala ristorante comprende ostriche e pesce marinato, il tutto si può consumare in un ambiente minimalista tutto incentrato sulle bottiglie in esposizione. E’ sempre affollata (da Roma. Viaggiare con stile, cit.).
La piazzetta è una pizzeria a taglio che offre un assortimento vasto di pizze e focacce oltre a supplì, crocchette e fritti (da Ristoranti di Roma 2007/2008, cit.).
PIAZZA DELL’IMMACOLATA E
CHIESA DELL’IMMACOLATA
Contigua al largo degli Osci è piazza dell’Immacolata, riqualificata nel febbraio del 2004, pedonalizzata con pavimento in basalto, alberi, panchine in pietra e nuova illuminazione, vi si tengono iniziative dell’estate romana. Marco Lodoli in un suo corsivo su Repubblica fa il confronto fra i giovani che frequentano la sera questa piazza e quelli che frequentano ponte Milvio (Repubblica 4 marzo 2007). Sulla piazza è la parrocchia del quartiere ovvero la:
Chiesa dell’Immacolata e San Giovanni Berchmans. In stile neogotico con rosone e cinque campaniletti. Inaugurata nel 1909, costruita su progetto degli arch. Francesco e Carlo Strocchi. Eretta con il contributo dei cattolici belgi.
Interno a tre navate, colonne a fascio, volte a vela, decorazione pittorica del dopoguerra del foggiano Praian. Un bel pannello illustra gli affreschi sotto la navata laterale destra.
Il campanile su largo degli Osci reca la data del 1929, vuole ricordare il campanile in piazza San Marco a Venezia. Il cortile è precedente alla chiesa (da Rioni e Quartieri di Roma, ed. Newton).
L’otto dicembre di ogni anno si tiene la processione per le strade del quartiere, in quest’occasione tanti anziani tornano nel quartiere. Vista la presenza di 4.000 studenti fuori sede la parrocchia offre spazi e momenti di incontro dedicati a loro, un sacerdote – padre Giorgio – si occupa solo di questa comunità. La parrocchia si sta preparando al suo centenario che cadrà nel 2009 (da sito internet vicariato di Roma: romasette.it ).
Da piazza dell’Immacolata imboccando via degli Apuli in discesa si trova sulla destra la ciminiera della demolita birreria Wuhrer oggi facoltà di Psicologia dell’università La Sapienza.
Da largo degli Osci, si prende via dei Latini, al civico 21 una lapide ricorda la medaglia d’oro Tortora Dionigi, si arriva in breve a via Tiburtina di fronte all’ingresso del
PARCO 19 LUGLIO 1943
parco 19 luglio 1943, con semplicissimo ma commovente monumento in ricordo dei morti di quel bombardamento, su una lastra di cristallo lunga 70 metri – che circonda l’aiuola centrale, scorrono i nomidi 1.492 morti. Spicca la famiglia De Angelis con 11 nomi. La sera si illumina. Il monumento è stato inaugurato il 19 luglio 2003 alla presenza del presidente della Repubblica Ciampi e del sindaco di Roma Veltroni. Il progetto del monumento di Luca Zevi è stato scelto da una commissione presieduta dal preside di architettura Roberto Palumbo che ha dichiarato “nella sua essenzialità e anti retorico”. Una canzone di Francesco De Gregori dal titolo San Lorenzo inserita nell’album Titanic (1982) racconta di questo tragico bombardamento (da wikipedia.org).
Foto del bombardamento in Pafi Benvenuti, Roma in guerra, ed. Oberon, 1985, pag. 6 e 7.
Fino al 30 giugno 1931 qui era il capolinea della ferrovia per Tivoli inaugurata il 17 giugno 1879 su progetto pontificio. Inizialmente dotata di locomotive a vapore, fu elettrificata agli inizi del Novecento. Si effettuavano cinque corse al giorno, impiegava un’ora e mezzo circa, la prima partenza da Tivoli era alle 5,43 e l’ultima partenza da Roma alle 18,05. Dette un non lieve contributo allo sviluppo del quartiere (da I rioni e i quartieri di Roma, ed. Newton, 1990, pag. 1666, ache in Muscolino, Appunti immagini curiosità sui tram di Roma e del Lazio, ed. Filopress, 2004; alle pag. 11 e 12 manifesti con orario e bel dipinto del treno presso ponte Lucano con l’Aniene, pag. 22 e 23 foto del treno con terrazza panoramica posteriore, pag. 87 bus per Tivoli a via Gaeta del 1941 e bus articolato del 1961).
Tornati a piazza dell’Immacolata si prende via dei Sabelli in direzione delle Mura Aureliane. In via dei Sabelli, al civico51, è il ristorante Vinosteria che ha preso il posto del famoso bistrot d’alta classe Il dito e la luna.
Proseguendo in via dei Sabelli, giunti al secondo incrocio si piega a sinistra in via degli Equi, qui al n. 13 si trova la pizzeria Formula Uno, con la fila dei clienti perennemente fuori e i poster della Ferrari all’interno, invece al n.58 il ristorante Uno e bino, uno dei migliori della città, prezzo medio € 45 vini esclusi. Al n.39 il pub La pinta, sembra di entrare nella stiva di un galeone, il nome allude alla caravella di Colombo e alla unità di misura inglese. Al n. 56 il ristorante La mucca bischera, la specialità è ovviamente carne alla brace, piatti di cacciagione e salumi maremmani, si mangia con 28 €.
Si prosegue fino a giungere in largo dei Campani, da qui subito a destra si prende via dei Marsi dove al n.58 il 6 gennaio 1907 Maria Montessori aprì la prima “Casa dei Bimbi” su invito dell’ing. Talamo direttore generale dell’Istituto Beni Stabili (da montessori.it).
Al civico 35 di via dei Marsi c’è la pasticceria Paci. Laboratorio di Luigi e Paola Paci specializzata in dessert di impronta partenopea, tra le specialità gustare la torta Caprese con mandorle e cioccolata, e la Pastiera preparata secondo la vera ricetta napoletana.
Da via dei Marsi prendere via dei Campani dove al n.73 è la libreria Anomalia dove si trovano in vendita testi della tradizione anarchica e libertaria, inoltre comprende il Centro di Documentazione Anarchica e il Fondo Valerio Verbano con manifesti, volantini, documenti vari dei gruppi della sinistra extra parlamentare degli anni Settanta (da Abbate pag. 252).
In fondo a via dei Campani si trova piazza Talamo con il sepolcro romano, piccolo mausoleo risalente al primo secolo, è rivestito esternamente in travertino e con una cella rotonda all’interno. Testimonianza della presenza nell’area di monumenti funebri di cui l’esempio più significativo è il vicino sepolcro del fornaio Eurisace a porta Maggiore.
Percorrendo tutta via dei Marsi si arriva in via di Porta Labicana che costeggia le mura Aureliane, i palazzi che costeggiano la strada hanno cortili interni con i ballatoi su cui si aprono gli ingressi ai singoli appartamenti.
PIAZZALE TIBURTINO
Via di Porta Labicana porta in piazzale Tiburtino, punto di inizio della via omonima ed una delle porte del quartiere. Il lato meridionale del piazzale è il meglio conservato, l’edificio – realizzato tra il 1879 e il 1885 ha eleganti ornati floreali e ovuli sul marcapiano. La costruzione del quartiere fece scomparire il vicolo Malabarba oggi ripreso dalle vie dei Falisci e degli Apuli. La torre con merlatura è un piccolo parco della rimembranza con la lapide ai caduti della guerra 1915 – 18, una ai caduti della Resistenza e ben dieci piccole lapidi, simili a ex voto, per ricordare alcuni caduti della guerra o del famoso bombardamento.
PORTA TIBURTINA
Da piazzale Tiburtino si prende via di porta Tiburtina fino ad arrivare a porta Tiburtina. In origine monumentale arco costruito dall’imperatore Augusto nel 5 a.C. per permettere il passaggio al di sopra della strada dei tre acquedotti dell’Acqua Marcia, Tepula e Iulia prevenienti dalla porta Praenestina oggi porta Maggiore. L’arco, inserito nelle mura fatte costruire dall’imperatore Aureliano a partire dal 271 a.C. è in travertino, ha pilastri tuscanici e chavi di volta ornate da bucrani (motivi ornamentali a forma di teschio di bue).
La via Tiburtina, di antichissima origine prende nome da Tibur, Tivoli, fu per millenni il percorso più diretto per la transumanza dai monti dell’Abruzzo alle pianure tirreniche. In epoca repubblicana iniziava dalla porta Esquilina (l’odierno arco di Gallieno) delle mura Serviane, dopo l’erezione di quelle Aureliane dalla porta Tiburtina; al 307 risale il suo prolungamento attuato dal console Marco Valerio Massimo (da qui il nome di Tiburtina Valeria) fino a Corfinio (da Guida di Roma del Tci, 1993).
Seguendo via di Porta Labicana verso Sud si giunge in viale dello Scalo San Lorenzo dove passa la Tangenziale Est, uno dei punti più brutti della città spesso immortalato nel cinema, vedi Fantozzi e la mini serie tv Fininvest I Liceali (anche Abbate a pag. 85).
CITTA’ UNIVERSITARIA
L’insufficienza del Palazzo della Sapienza era chiara a tutti fin dal 1870, per questo motivo varie facoltà avevano trovato altre sedi sparse per la città, mentre Medicina e Chirurgia ebbe sede nel Policlinico Umberto I. La città Universitaria occupa un’area trapezoidale di circa m 500 x 400, sorse negli anni 1932-35 su progetto generale di Marcello Piacentini che chiamò a collaborare sia architetti della corrente razionalista sia della tradizione accademica. E’ un complesso grandioso e di ampio respiro, con fabbricati non molto alti e ben distanziati e circondati da belle piantagioni. Rappresenta una delle più importanti realizzazioni architettoniche del fascismo.
La fronte sul piazzale Aldo Moro (già delle Scienze) è costituita da un alto ed esteso porticato a giorno che si collega alle estremità con gli edifici della Clinica Ortopedica a destra, e degli Istituti di Igiene, Batteriologia e Parassitologia a sinistra, il tutto dovuto ad Arnaldo Foschini. Guardando oltre, verso il viale dell’Università, si vede il Dopolavoro con il Teatro Ateneo di Gaetano Minnucci.
L’ampio viale alberato mediano, fiancheggiato a destra dell’Istituto di Chimica di Pietro Aschieri, e a sinistra dall’Istituto di Fisica di Giuseppe Pagano, sbocca nella grande piazza centrale, al centro della quale si trova una vasca rettangolare con la statua di Minerva, bronzo di Arturo Martini. Di fronte il Palazzo del Rettorato di Piacentini, con alto pronao a pilatri su ampia scalea. In esso si trovano l’Aula Magna capace di 2.000 posti con l’affresco “L’Italia fra le arti e le scienze” di Mario Sironi, e la Biblioteca Universitaria Alessandrina, fondata da Alessandro VII, inaugurata nel 1670 e trasportata alla Città Universitaria nel 1935, ricca di oltre un milione di volumi e di circa 16.000 periodici. Il rettorato forma un unico grande prospetto con la facoltà di Lettere e Filosofia a destra e la facoltà di Giurisprudenza a sinistra (dietro Scienze Politiche) di Gaetano Rapisardi.
All’interno della Città Universitaria sorge la chiesa della Divina Sapienza, o Cappella Universitaria, a pianta ellittica e cupola ribassata, con rivestimento in laterizio e travertino, del Piacentini, offerta da Pio XII nel 1948. Sopra il portale che guarda il viale delle Scienze: “Madonna con Bambino” di Arturo Dazzi, mentre “Cristo Maestro” bronzo di Romano Romanelli, sul portale che guarda il viale centrale della Città Universitaria. L’interno è circolare e presenta un alto matroneo, sulla sinistra si trova un calco della Pietà Rondanini, l’altare maggiore è in prospettiva con viale delle Scienze, alla sua sinistra piccolo “Crocifisso” in bronzo di Venanzio Crocetti, alle sue spalle un grande affresco murale con Gesù che indica i Vangeli. Lo spazio verde antistante è stato riqualificato recentemente perché negli spazi sotterranei è stato creato un parcheggio multipiano.
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ALESSANDRINA
Città Universitaria
piazzale Aldo Moro
Nel palazzo del Rettorato di Marcello Piacentini[3] con alto pronao a pilastri su ampia scalea. La biblioteca fu fondata da Alessandro VII Fabio Chigi, inaugurata nel 1670 e trasportata alla Sapienza nel 1935. Il nucleo storico delle raccolte della biblioteca è costituito dai duplicati della biblioteca Chigiana (1644), dai 423 duplicati della biblioteca Vaticana e da una parte della preziosa biblioteca dei duchi di Urbino (1666). A questo “fondo antico” si uniscono, a partire dal 1815, gli esemplari delle opere stampate nello stato Pontificio e, dal 1870 gli esemplari di quelle stampate da tipografie della provincia di Roma. Nel 1935, con il trasferimento in questa sede, vengono depositate qui le preesistenti biblioteche di Lettere, Giurisprudenza e Scienze Politiche. Successivamente ha ricevuto importanti donazioni come il fondo Vittorio Rossi, il fondoSchupfer e il fondo Chiovenda.
In base alla legge regionale 106 del 2004 tutti i documenti di interesse culturale pubblicati da editori della provincia di Roma vengono depositati legalmente in questa biblioteca. Oggi è una biblioteca pubblica statale che dipende, dal 1975 dal Ministero dei Beni e Attività Culturali. Il suo catalogo è consultabile on line[4].
PALAZZO DEL MINISTERO DELL’AERONAUTICA
VIALE DELL’UNIVERSITA’ 4. Aperto ufficialmente il 28 marzo 1931, il palazzo fu costruito in soli due anni quale sede dell’allora regia Aeronautica. Committente e ispiratore dell’edificio fu il maresciallo dell’aria Italo Balbo che volle un’opera di dimensioni imperiali, in stile razionalista. Il palazzo conserva saloni e luoghi di sontuosa eleganza, arricchiti da stucchi e pitture che richiamo al mondo dell’aviazione e delle stelle. Tutte le notizie da Open House Roma 2015.
BIOGRAFIE
Antonio Berti (San Piero a Sieve 1904 – Sesto Fiorentino 1990) scultore fiorentino. Proveniente da famiglia di contadini e pastori iniziò a lavorare come disegnatore alla Richard Ginori. Scoperto da Ugo Ojetti, studiò all’Istituto d’Arte di Santa Croce a Firenze. Ha realizzato il busto di Foscolo a Santa Croce, vari busti della famiglia reale. Nel dopoguerra il monumento a De Gasperi a Trento, Santa Luisa Marillac in San Pietro e quello per Aldo Moro a Maglie in Puglia.
Giosuè Borsi (Livorno 1888 – Zagora 1915) scrittore italiano morto al fronte durante la prima guerra mondiale.
[1] Pietro Camporese il Giovane. (1792-1873) Nipote del Vecchio. Ha lui si deve palazzo Wedekind in piazza Colonna come ufficio centrale delle Poste Pontificie, l'ospedale di San Giacomo degli Incurabili al Corso (1831-46), l'Istituto di Belle Arti a via Ripetta. Fu patriota, liberale moderato, favorevole ad una soluzione di forza per liberare Roma con Garibaldi, dopo il 1870 fu consigliere comunale.
[2] Publio Morbiducci (Roma 1889-1963) scultore, medaglista e pittore. Autore del monumento al Bersagliere a Porta Pia, del monumento a Emanuele Filiberto duca d’Aosta a Torino, di una delle statue alla base del Colosseo Quadrato a Roma.
[3] Marcello Piacentini (1881-1960) ponte Aventino nel 1917, cinema Corso in piazza San Lorenzo in Lucina nel 1915, palazzo per la Banca d'Italia in piazza del Parlamento, nel 1920 pianificazione della Garbatella con Giovannoni, teatro Quirinetta in via Minghetti, hotel Ambasciatori a via Veneto con Vaccaro, Casa Madre dei Mutilati in piazza Adriana, cinema Barberini nella piazza omonima, nel 1932-35 pianificazione della Città Universitaria con il palazzo del Rettorato e della biblioteca Alessandrina, chiesa di Cristo Re in viale Mazzini nel 1924-34, il palazzo della Banca Nazionale del Lavoro a via Veneto, sventramento della spina dei Borghi, piano regolatore dell'E42 con Auditorium in via della Conciliazione, cinema Fiamma, chiesa della città universitaria, teatro Sistina, nuova facciata del teatro dell'Opera, palazzo dello Sport all'Eur con Pier Luigi Nervi.
[4] Biblioteca Universitaria Alessandrina. Tutte le notizie dalla Guida di Roma del Tci e da alessandrina.librari.beniculturali.it.
POSIZIONE GEOGRAFICA
Il quartiere Parioli si trova nel quadrante Nord di Roma. I suoi confini sono: via Flaminia a Ovest che la separa dal quartiere Flaminio, il fiume Tevere da ponte Milvio fino alla confluenza dell’Aniene, il fiume Aniene fino al ponte della via Salaria, tale confine lo separa dal quartiere Tor di Quinto e dalla zona Val Melaina, verso Est il confine è rappresentato dalla via Salaria fino all’incrocio con viale Liegi, qui confina con il quartiere Trieste. A Sud il confine è rappresentato dal viale Liegi, piazza Ungheria, viale Parioli e viale Maresciallo Pilsudski fino a tornare sulla via Flaminia.
Il quartiere è nettamente distinto in due aree edificate: il Villaggio Olimpico a Ovest, la zona che gravita intorno a piazza delle Muse – piazza Ungheria a Est. A segnare la netta distinzione è il parco di Villa Glori. Una gran parte del quartiere è occupata da villa Ada e dal Centro Sportivo dell’Acqua Acetosa.
Il quartiere Parioli fa parte del II municipio del Comune di Roma. Il nome del quartiere deriva dalle alture che si trovano sulla destra della via Flaminia subito fuori porta del Popolo, prima dell’edificazione vi erano molti peri, da qui il nome. Popolazione ab. 14.090[1].
TOPONOMASTICA
Nella zona del Villaggio Olimpico le strade sono intitolate a stati europei ed extraeuropei a ricordare la partecipazione internazionale all’evento sportivo del 1960. Ma vi sono anche strade intitolate a sportivi: Nedo Nadi, Dorando Pietri, Pietro de Coubertin.
Nella zona compresa tra piazza Ungheria e piazza delle Muse le strade sono intitolate a personaggi del mondo dello spettacolo: Eleonora Duse, Leopoldo Fregoli, Ettore Petrolini, Anna Magnani, Giacinta Pezzana, ma anche irredentisti: Ruggero Fauro, Scipio Slataper e Vittorio Locchi; oltre ai toponimi. Nella zona tra piazza Ungheria, viale Liegi e via Salaria le strade sono intitolate a città capitali di stati europei ma non solo (Lisbona, Bruxelles, ma anche Lovanio e Lima).
STORIA
In epoca romana la zona aveva una vocazione agricola come testimonia la villa ritrovata in occasione della costruzione dell’Auditorium. Lungo la via Flaminia e la Salaria si trovavano sepolcri come era consuetudine dei romani di seppellire al di fuori delle mura, lo testimoniano le catacombe di San Valentino tra la via Flaminia e viale Pilsudski e le catacombe di Priscilla lungo la via Salaria, oggi sotto villa Ada. Un’altra importante area funebre è stata recentemente ritrovata a piazza Euclide nei lavori per la costruzione di un parcheggio sotterraneo. E’ opera dei romani il ponte Milvio, il più antico ponte in muratura di Roma. A monte Antenne, nel perimetro di villa Ada, sono stati ritrovati resti di costruzioni precedenti alla nascita di Roma, si tratta della città di Antemnae.
Nel medioevo tornò alla sua funzione agricola, nell’Ottocento vi sorsero osterie dove il popolo vi trascorreva i giorni festivi in quelli che si chiamavano le “gite fuori porta”. Una delle mete preferite erano i prati presso la fonte dell’Acqua Acetosa.
Dopo l’unità d’Italia nacque viale Parioli come passeggiata suburbana voluta da Filonardi e Giorgi, proprietari dei terreni, interessati alla costruzione di un quartiere di villini e case di lusso, per la ricca borghesia. Il piano regolatore del 1909 di Sanjust decretò che il quartiere fosse tutto a ville e villini con giardini. Negli anni del fascismo nel quartiere si stabilirono il comando generale della milizia, il comando dei Carabinieri, le abitazioni di personaggi del calibro di Galeazzo Ciano e di Pietro Badoglio. Per le esigenze speculative tuttavia decaddero i vincoli a verde, si restrinsero le sezioni delle strade, si moltiplicarono i piani e aumentò la cubatura. Nel 1932 entra in funzione la ferrovia Roma Civitacastellana Viterbo (per i romani Roma Nord) che ha nel quartiere le fermate di Euclide, Acqua Acetosa e Campi Sportivi (oggi è gestita da Atac). Nel dopoguerra i Parioli confermarono la loro caratteristica di quartiere dell’alta borghesia, nel 1957, finalmente, villa Ada venne aperta al pubblico (era proprietà dei Savoia che ne donarono parte all’Egitto per l’ospitalità data a Vittorio Emanuele III dopo la fine del secondo conflitto mondiale). Per le Olimpiadi del 1960 sorse il Villaggio Olimpico con lo scopo di dare un’abitazione agli atleti che giungevano a Roma per partecipare alle gare. Al termine delle Olimpiadi le case vennero assegnate ai dipendenti dello Stato. La zona aveva già impianti sportivi: il campo Parioli per le corse di cavalli, lo stadio Nazionale all’incirca dove oggi c’è lo stadio Flaminio. In occasione delle Olimpiadi sorse corso Francia, altra importante infrastruttura viaria che sostituiva ponte Milvio, e via del Foro Italico con un altro ponte sul Tevere, oggi comunemente chiamata Tangenziale Est. Negli anni Ottanta inizia la costruzione della moschea, la più grande d’Europa, la sua inaugurazione avviene nel 1995.
Sempre più il quartiere ospita ambasciate, consolati, banche, società finanziarie e una miriade di studi di ogni genere. Conseguenza di ciò fu l’invecchiamento della popolazione e la sua diminuzione.
ITINERARIO
L’itinerario non può che iniziare da piazza Ungheria, vero cuore del quartiere che, per i romani comprende anche il Pinciano. Sul lato Nord della piazza si trova la
CHIESA DI SAN ROBERTO BELLARMINO
La chiesa fu consacrata il 10 giugno 1933, progettata da Clemente Busiri Vici[2] appartente ad una famiglia di architetti giunti alla nona generazione. La facciata è a capanna in quanto la larghezza supera l’altezza, è chiusa tra due bassi torri campanarie a pianta ottagonale. Un semplicissimo portico sorretto da quattro pilastri è anteposto alla facciata ricoperta, come tutto l’esterno, da una cortina di mattoni. Una breve scalinata conduce ai tre ingressi. Il transetto e la bassa cupola ottagonale sono appena percepibili dall’esterno sopra la copertura dell’unica navata, da cui sporgono i corpi delle cappelle laterali. L’interno è decorato da mosici di Renato Tomassi che rivestono le strutture in cemento armato del transetto, della cupola ottagonale e dell’abside. La totale assenza di decorazioni esterne è la caratteristica principale.
Sulla piazza il CAFFE’ HUNGARIA è uno dei principali punti di incontro del quartiere. Sulla piazza transita la PISTA CICLABILE PONTE RISORGIMENTO – VILLA BORGHESE – VILLA ADA di Km 3,146 che proviene da valle Giulia, prosegue per via Panama e si dirige a villa Ada (Parco Rabin).
Si imbocca viale Liegi, la naturale continuazione di viale Regina Margherita oltre la via Salaria. Al civico 42 si trova una costruzione realizzata da Massimo Piacentini tra il 1916 e il 1922, si tratta di un villino di quattro piani più attico, caratterizzato dagli aggetti dei Bow window sulla facciata e sul prospetto laterale all’angolo con via Montevideo.
Si percorre tutta viale Liegi fino all’incrocio con via Salaria. Si prende via Salaria verso sinistra fino a giungere a
VILLA GRAZIOLI LANTE DELLE ROVERE
La storia della villa è legata a quella del maresciallo Pietro Badoglio, il conquistatore di Addis Abeba, che ottenne come premio questa villa come la propria dimora e la preferì ad un palazzo del centro storico. Incaricò quindi l’arch. Busiri Vici di progettare la residenza. Attualmente l’edificio ospita l’ambasciata della Repubblica Popolare Cinese presso il Quirinale. La parte di villa Grazioli trasformata in parco pubblico è un giardino rettangolare tra viale di villa Grazioli e via Bruxelles. L’edificio centrale della villa è stato rimaneggiato più volte, tanto da perdere ogni caratteristica originaria. Parte della villa è stata distrutta per le lottizzazioni.
Si percorre viale di villa Grazioli fino ad incrociare via Bruxelles.
In via Bruxelles n. 47 si trova una palazzina aperta e proiettata sul giardino opera di Andrea Busiri Vici del 1935[3], simile a quella in piazza delle Muse di Ugo Luccichenti.
Si prosegue per viale di villa Grazioni fino a trovare via Lima, qui, al civico 4 si trova la
PALAZZINA DI PIETRO SFORZA
Si tratta di una palazzina degli anni Trenta, tre piani più piano attico, ha la facciata caratterizzata da una estrema simmetria. Al centro di ogni piano si apre un balcone rientrante, fiancheggiato da finestre, conferendo un certo movimento alla massa compatta della palazzina nel suo complesso. Lungo i prospetti laterali corrono delle balconate che, formando una curva, si protendono agli angoli fino sulla facciata con mattoni aggettanti.
Si percorre tutta via Lima fino a piazza Cuba, di qui in breve si torna a piazza Ungheria. Volendo percorrere via Panama, ci si trova in una strada che ha sulla sinistra, sul marciapiede la pista ciclabile già citata in piazza Ungheria. Nell’ultimo tratto si trova un’area verde, il PARCO RABIN, per notizie su questo luogo vedi il testo Villa Ada. In via Panama al civico 96 (di fronte al parco Rabin) si trova la palazzina di Mario Tufaroli[4], in essa il gioco di luci e ombre, una corretta distribuzione degli spazi ma, soprttutto la buona fattura sono le qualità di questa e di tante altre palazzine del quartiere (un appartamento è occupato dalla ambasciata di Romania presso la Santa Sede).Da questa piazza si prende l’ampio viale Romania, ha al centro un filare di platani e pini marittimi. Sulla destra si trova la
LUISS
Già sede dell’Istituto Pio XII delle reliose dell’Assunzione. La Luiss è la Liberà università internazionale degli studi sociali “Guido Carli”. L’università è nata tra il 1974 e il 78 da un gruppo di imprenditori tra i quali Umberto Agnelli, nel 1978 Carli divenne presidente e vi rimase fino alla morte, dal 1994 gli è intitolata, oggi Luca Cordero di Montezemolo è il presidente. Il presidente è affiancato dalla figura del rettore. Si compone di tre facoltà: Economia, Giurisprudenza e Scienze politiche. La sede centrale è – dall’ottobre 2007 - in viale Romania ai Parioli, precedentemente era in via Pola angolo via Alberoni, dove tutt’ora esistono aule e uffici. In via di Santa Costanza n. 53 c’è la biblioteca (da sito internet e cronaca di Repubblica). Un’altra sede dovrebbe sorgere in villa Blanc sulla Nomentana, non lontana da qui (nov. 2013).
Poco oltre si incrocia via del Canneto, stretta e silenziosa, una vera strada di campagna nel cuore di Roma, è delimitata dalla villa che accoglie la Luiss e
VILLA POLISSENA
Già villa Calvi di Bergolo, oggi dei Carabinieri, vi si può entrare da qui o da via San Filippo Martire. Faceva parte di villa Ada, era destinata agli ospiti. Il ridente giardino è abbellito da fontane a conca mentre l’edificio della villa si presenta in stile rococò, negli anni Trenta gli furono aggiunte due nuove ali senza turbare l’equilibrio della costruzione.
Sulla sinistra di viale Romania si trova il
COMANDO MILITARE CENTRALE
Costruito, su progetto dell’arch. Cafiero[5], negli anni Trenta per essere il comando della milizia fascista, venne solennemente inaugurato nel giugno 1936.
Proseguendo per viale Romania si raggiunge piazza Bligny. Di fronte a noi, sulla destra, inizia via San Filippo Martire, dove è un altro ingresso di villa Polissena. Dopo un’ampia curva, la strada prosegue con il nome di via Ettore Petrolini e trova sulla destra il parco Mario Riva. In questo punto via Giacinta Pezzana scende alla Moschea. Proseguendo la via arriva con altri nomi a piazza delle Muse.
Tornati a piazza Bligny, di fronte a noi, ma sulla sinistra si apre via di Villa San Filippo. Il nome deriva dall’omonima villa seicentesca il cui ingresso era di fronte a villa Polissena, ne rimane solo il portale con il banale cancello, all’interno una palazzina moderna sede di una impresa edile. Le “Taxae Viarum” del 1674 parlano della presenza in zona di una cappellina dedicata a San Filippo.
Si percorre via di Villa San Filippo, si piega nella prima a destra: via Eleonora Duse, questa conduce in
PIAZZA DELLE MUSE
Ad angolo tra la piazza e via Eleonora Duse si trova un edificio progettato dall’architetto, designer e saggista milanese Giò Ponti[6], autore della Concattedrale di Taranto (1964) e del Pirellone (1960) direttore di riviste quali Domus e Stile, realizzato nel 1939. Lo schema simmetrico della facciata si ritrova anche nei prospetti laterali caratterizzati da una leggera sporgenza del corpo dei servizi. Colpiscono il particolare rapporto tra dei muri e il vuoto delle bucature in corrispondenza di finestre e balconi e il rivestimento bianco del mosaico di gres. Proprio negli anni in cui fu relizzato l’edificio, infatti, Giò Ponti si fece sostenitore dell’opportunità di usare materiali quali il cotto e la ceramica nei rivestimenti esterni al posto dell’intonaco, più facilmente deperibile.
Accanto all’edificio di Giò Ponti ai nn. 6/7 sorge una palazzina ideata dall’architetto Ugo Luccichenti costruita nel 1940. L’edificio, che ospita due appartamenti di lusso per piano e uno più grande all’attico, si apre su un panorama che va da villa Ada a monte Mario. La facciata è caratterizzata da una estrema simmestria e dagli ampi balconi che sembrano voler dilatare gli spazi verso l’esterno. L’annullamento delle pareti gioca un ruolo determinante nella costruzione. Sia la facciata del palazzo che gli angoli dei prospetti laterali, infatti, sono costituiti interamente da grandi vetrate interrotte solamente dal ritmo dei pilastri. Il volume dell’edificio viene così ad essere in parte smaterializzato, come il parapetto in metallo fa perdere agli ampi balconi la maggior parte del loro peso per trasformali in un esile elemento a sbalzo. Attualmente ospita l’ambasciata della Repubblica Popolare Cinese presso la Santa Sede.
Al centro della piazza un giardino che è stato recentemente riqualificato, al di sotto si trova un parcheggio. Due eleganti chioschi bar offrono uno splendido panorama verso il Tevere, la moschea, la collina di Monte Mario e in lontananza il monte Soratte.
Si imbocca via Gian Giacomo Porro, qui si trova la Clinica Quisisana nella quale morì Antonio Gramsci il 27 aprile del 1937. Proseguendo per via di Villa San Filippo e viale Romania si torna in piazza Ungheria. Prima di arrivare in piazza Ungheria si faccia una deviazione in via Scipio Slataper, la penultima a destra, al civico 9 si noti il palazzo INCIS del 1928 di Alfio Susini, notare il singolare portone di ingresso a forma stellare[7].
Tornati in piazza Ungheria si riprende l’itinerario nella parte Ovest del quartiere. Si imbocca viale Parioli. Si tratta di un ampio viale, sinuoso, in discesa, ideato come passeggiata, nel primo tratto ha molti negozi, ristoranti e bar, è fiancheggiato da palazzine e villini di pregio.
All’inizio di viale Parioli, angolo con via Stoppani, si trovava il
VILLINO VILLIEGAS
Costruito nel 1887 era in stile moresco, ebbe una grande notorietà. A volerlo fu il pittore spagnolo Josè Villiegas y Cordero che dirigeva l’Accademia di Spagna, in quegli anni il villino era circondato da campagna e spiccava per la sua architettura singolare, ancora ai primi del Novecento, tutto il lato destro del viale era una verde collina. Venne citato da diverse riviste di architettura italiane e straniere, ma la sua fama la deve al romanziere Paul Bouregt che vi ambiento alcune scene de Cosmopolis. Successivamente divenne proprietà Tavazzi, fu abitato dal cardinale Massimi e dopo la seconda guerra mondiale venne demolito.
Al civico 16 si trova il COLLEGIO SAN GABRIELE un istituto privato e confessionale. Proprio sotto questa scuola privata c’è il
BAR CIGNO
che rappresenta un luogo di incontro dei “pariolini” al pari del caffè Hungaria di piazza Ungheria già citato. Di questo bar parla anche Marco Lodoli: “… possiamo andare a prenderci un aperitivo al bar del Cigno di viale Parioli, che dal 1949 contiene un’opera unica al mondo. Oltre il bancone, dietro le spalle dei baristi indaffarati a servire crodini, si distende il mito greco di Leda e il Cigno, reso nella vivacità smagliante della ceramica. Ricordate? Giove, ossessionato dalle femmine, s’era acceso di desiderio per la procace Leda, moglie del re di Sparta, e per conquistarla si mutò in un cigno meraviglioso. Lei rimase incita e dopo qualche tempo partorì un uovo enorme: quando l’uovo si schiuse saltarono fuori Castore e Polluce, ossia i Dioscuri, i gemelli divini che sarebbero diventati una costellazione dello zodiaco. Ebbene, nei sei o sette metri di ceramica questa storia c’è tutta, e ci sono anche le guance gonfie di Eolo e il carro di Fetonte, le ninfe dei boschi, i pavoni, le volpi, i mostri marini, le tante forme di un universo mitico che non si smetterebbe mai di ammirare. L’opera è di Capizzano e Gigotti, due artisti degli anni Quaranta, ha una sua grazia tutta popolare: è una favola raccontata ai bambini, agli uomini di passaggio nel bar, a tutti noi che sempre siamo costretti a trasformarci, per amore o solo perché la vita non sta mai ferma[8]”.
Al civico 45 di viale Parioli alberi e cemento sembrano fondersi in un’unica costruzione nella SEDE DELL’ACI, con il tetto a terrazza da cui fuoriescono due alti pini marittimi che giancheggiano l’ingresso principale.
La seconda a destra è via Gualtiero Castelli, qui si trova la CASERMA PASTRENGO dei Carabinieri a cavallo. E’ uno squadrone speciale dell’arma che si esidisce in esrcitazioni particolari come il famoso carosello di piazza di Siena in occasione del concorso ippico internazionale.
Si riprende viale Parioli che in breve giunge a piazzale Santiago del Cile, piazza circolare con giardino al centro, tale luogo rappresenta il punto posto a metà di viale Parioli, dopo di esso il viale scende più velocemente. Se nelle palazzine di prima prevaleva il giallo ora prevale il grigio. Proseguendo per viale Parioli, la prima a sinistra è via Giovanni Battista Brocchi, in pratica una scalinata che raggiuge la più elevata via Barnaba Oriani. Si procede ancora per viale Parioli, prima del viale della Moschea sulla destra della strada si trova un rinomato ristorante – pizzeria La Celestina al civico 184. Per Tripadvisor è al posto 2.963 su 9.120 ristoranti di Roma (dato del 6.4.15). Dopo poco, sempre sulla destra si trova il:
MERCATO DI VIALE PARIOLI
Il primo e unico mercato di Roma e d’Italia ad essere aperto fino alle ore 23 con “street food”.
Il mercato era da oltre trenta anni in via Locchi, finalmente ad aprile 2006 è stato trasferito in questa nuova sede con cinque grandi chioschi gestiti da 18 operatori. I lavori di trasferimento sono costati 800.000 €. All’inaugurazione era presente il sindaco Walter Veltroni che ha dichiarato: “Il mercato era una zona di degrado, perciò abbiamo deciso di trasferirlo e di realizzare un mercato come questo più civile in cui gli operatori lavoreranno meglio e i cittadini saranno più garantiti”. Con l’inaugurazione del nuovo mercato una parte dei marciapiedi è stato trasformato in parcheggi.
E’ stato il primo mercato di Roma ad essere trasformato la sera in luogo di incontro per i giovani, il banco del pane in pizzeria, la macelleria in fast food di qualità, il banco della frutta in negozio di frullati, inoltre vi è una birreria. Su questa strada dovranno andare gli altri mercati di Roma a cominciare da quello di Testaccio, di Prati in piazza Unità e di via Magna Grecia.
Siamo giunti quasi alla fine di viale Parioli, sulla destra ecco viale della Moschea. Prendiamo viale della Moschea.
La percorriamo, troviamo sulla destra la PISTA CICLABILE DORSALE ANIENE di Km 9,450, proviene dalla via Flaminia, va nella valle dell’Aniene e giunge fino a Monte Sacro, da lì si può proseguire ancora sui sentieri sterrati nella Riserva Natural Valle dell’Aniene fino a Casal de Pazzi e Ponte Mammolo sulla Tiburtina. Su viale della Moschea si trova AQUANIENE una piscina e centro sportivo realizzato per i mondiali di nuoto del 2009 che si tennero a Roma. Si prosegue su viale della Moschea fino a trovare, sulla sinistra, la
MOSCHEA
Si tratta della più grande moschea d’Europa, sorge su 30.000 mq di terreno e può ospitare fino a 12.000 fedeli, ad essa è unito un Centro Culturale Islamico, si tratta di un punto di riferimento importante per gli arabi presenti a Roma e non solo. E’ opera dell’architetto romano Paolo Portoghesi[9], inaugurata il 21 giugno 1995, giorno del solstizio d’estate.
Fu voluta da re Fausal dell’Arabia Saudita custode delle moschee di Mecca e Medina, quando ancora non vi erano arabi di fede musulmana immigrati dai paesi del nord Africa, cioè negli anni Settanta del Novecento. Il consiglio comunale di Roma donò il terreno nel 1974, la prima pietra fu posta nel 1984 alla presenza del presidente della Repubblica Sandro Pertini. Ci vollero più di dieci anni di lavori per giungere alla inaugurazione.
Il primo aspetto che colpisce è la sua integrazione nel verde della vicina villa Ada e l’incrocio tra il moderno e la tradizione islamica. L’ingresso è preceduto da una sorta di ruscello nel quale i fedeli compiono i lavaggi rituali prima di entrare in moschea. Prima di varcare la porta lasciano le scarpe e camminano su grandi tappeti che coprono l’intera superficie della sala. La grande sala di preghiera richiama indubbiamente una foresta con le sue colonne a tre steli, sono usati materiali tipicamente romani come il travertino e il cotto rosato. L’apparato decorativo, molto discreto come è nella religione islamica, è costituito da ceramiche invetriate di colori delicati con frasi tratte dal Corano, il libro sacro della religione. L’interno di questa grande aula presenta il matroneo come nelle chiese mediovali cattoliche, questo spazio non è contemplato nella fede musulmana, è un omaggio alla terra nella quale ci troviamo, alla sua storia e tradizione anche culturale e religiosa. Una sorta di abside richiama il punto cardinale nella cui direzione si trova la Mecca, e verso tale punto che si inginocchiano a terra e quindi si distendono per pregare.
Oggi imam della moschea è l’egiziano Ala’ al-Din Muhammad Ismai’il al- Ghobaschi. Hai foto della moschea in costruzione.
Si torna indietro in viale Parioli che è giunta ormai alla fine, siamo in piazzale Parco della Rimembranza. Qui è l’ingresso a:
VILLA GLORI
Il Comune di Roma, con delibera del 23 ottobre 1923, decise di trasformare l’area dove oggi è villa Glori, in Parco della Rimembranza dedicato ai caduti della Grande Guerra. Il progetto del nuovo parco fu affidato a Raffaele de Vico, architetto del Servizio Giardini, in soli otto mesi creò un giardino per passeggiate immerse nel verde mediterraneo di pini, lecci, querci, lauri, aceri, cedri, ippocastani ed ulivi, tutti puntigliosamente allineati a filari. Il parco fu inaugurato il 18 maggio 1924. Una grande croce e un enorme altare sono la memoria tangibile dei caduti in guerra.
Venne scelto questo luogo perché il 23 ottobre 1867 qui avvenne uno scontro tra le truppe pontificie e una settantina di patrioti al comando dei fratelli Cairoli. Tale azione doveva scatenare l’insurrezione della popolazione romana, cosa che avvenne ma in misura minore, ma soprattutto doveva anticipare e giustificare l’intervento di volontare guidati da Garibaldi. Purtroppo i patrioti venne sopraffatti dalle truppe pontificie e uccisi, sulla sommità dell’altura si trova ancora un ramo secco di mandorlo dove morì Enrico Cairoli, mentre il fratello Giovanni, gravemente ferito, morì poco dopo. I superstiti raggiunsero Mentana dove combatterono con Garibaldi. In quegli anni vi era una vigna proprietà di un tale Vincenzo Glori, in essa anche un casale poi riadattato ad uso agricolo.
L’idea di farne un parco pubblico era già prevista dal piano regolatore del 1883, si iniziò con gli espropri e nel 1895 fu inaugurata una colonna in marmo di Pietrasanta a ricordo dei patrioti del 1867. Nel 1924 il parco venne inaugurato. Nel 1929 fu avviata la costruzione di tre padiglioni in legno destinati ad ospitare una colonia estiva per i bambini dalla salute precaria, il Dispensario Marchiafava. Dal 1988 tali padiglioni sono stati affidati alla Caritas che ne hanno fatto una casa famiglia per malati di Aids. Nel 1997, su idea della critica d’arte Daniela Fonti, il Comune di Roma ha promosso la costituzione di un parco di scultura contemporanea all’aperto intitolata Varcare la soglia che voleva esprire la possibilità di integrazione tra luogo di sofferenza e luogo di svago. Sono state così installate opere di Dompè “Meditazione”, Mattiacci “Ordine”, Mochetti “Arco-laser”, Caruso “Portale mediterraneo”, Castagna “Monadi”, Kounellis “Installazione”, Nunzio “Linea”, Staccioli “Installazione”. Nel 2000 si sono aggiunti “La porta del Sole” di Giuseppe Uncini e “Uomo erba” di Paolo Canevari. Nel 2003, alle spalle del mandorlo di Enrico Cairoli, è stata collocata una piccola lapide dedicata ai carabinieri morti a Nassiryia, in Iraq.
Sempre dal piazzale Parco della Rimembranza si prende verso Nord via della Fonte dell’Acqua Acetosa (controllare! Perché google.maps riporta via Antorio Sant’Elia che dopo la fonte diventa via dei Campi Sportivi) che in breve conduce alla stazione del treno Roma Nord “Campi Sportivi” e alla
FONTANA DELL’ACQUA ACETOSA
La fontana si trova in una piccola conca al di sotto del livello stradale e vi si accede da una scalinata. Un’epigrafe di fianco alle tre piccole vasche, fatta incidere da papa Paolo V enumera i mille mali per i quali quell’acqua digestiva e rinfrescante è salutare. A questa iscrizione se ne aggiungono due che corrispondono a due momenti diversi nelle vicende storiche della fontana. La più grande, posta nel timpano, ricorda l’opera di papa Alessandro VII Chigi; l’altra, di minori dimensioni, inserita nel riquadro sopra la nicchia centrale, ricorda il risanamento voluto da papa Clemente XI nel 1712. Nella primavera di quell’anno la quantità d’acqua era molto diminuita ed era peggiorata anche la sua qualità. Clemente XI istituì una commissione per lo studio e il risamentto della fonte, in tale commissione figurava monsignor Lancisi medico di Sua Santità e l’architetto Egidio Maria Bordoni. I lavori diedero esito positivo e fu più comodo attingere acqua.
La fonte fu fatta costruire da papa Paolo V[10], tra il 1644 e il 1655 fu papa Innocenzo X a far restaurare la fontana mentre Alessandro VII[11] fece erigere nel 1661 il prospetto architettonico ad esedra su progetto del Bernini che ancora si conserva.
Nell’Ottocento l’acqua della fonte veniva venduta in città dai cosiddetti “acquacetosari”, una corporazione di venditori ambulanti, tuttavia nel 1910 il Comune provvide all’appalto dell’Acqua Acetosa.
La fontana dell’Acqua Acetosa è stata restaurata nel dicembre 2009. a cura del circolo Canottieri Aniene che da allora si prende cura dell’area verde abbandonata da cinquanta anni. La solenne consegna della fonte alla città è avvenuta venerdì 18 dicembre 2009, madrina dell’evento Federica Pellegrini, prima nuotatrice italiana ad aver vinto una medaglia d’oro alle olimpiadi (Pechino 2008). Nel 2003 il Fai segnalò il monumento come da restaurare con priorità (i luoghi del cuore). La fonte è chiusa dal 1959 per inquinamento della falda acquifera, da allora l’Acea l’ha allacciata all’acquedotto.
Proseguendo per via dei Campi Sportivi si raggiungono i:
COMPLESSO SPORTIVO DELL’ACQUA ACETOSA
La zona, originariamente paludosa, era diventata proprietà del Coni nel 1954 che vi aveva iniziato lavori di bonifica, l’area si estende su 21 ettari. Nel 1956 l’architetto Annibale Vitellozzi[12] progettò la prima serie di opere che furono completate per le Olimpiadi del 1960. Quattro campi di calcio, tre di rugby, tre di hochey su prato, un campo di baseball, uno di pallavolo, una piscina scoperta, sei palestre formano il complesso di cui fa parte anche l’Istituto di Medicina Sportiva che il Vitellozzi progetto con Cesare Ligini[13]. Negli anni Sessanta fu costruito il Centro di Preparazione Olimpica, fu creato un centro pulcini per i bambini, un centro giovanile di addestramento all’equitazione e al pentathlon e una nuova piscina coperta con il centro di addestramento al nuoto e ai tuffi.
Si torna al piazzale Parco della Rimembranza, si imbocca viale Maresciallo Pilsudski che nel primo tratto è dominato dall’alta mole della chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria di piazza Euclide (ricade nel quartiere Pinciano) opera di Brasini. Dopo poco si vedono le volte dell’Auditorium, prima di esse si gira a destra in via Giulio Gaudini per giungere in breve a viale Pietro De Coubertin dove è l’ingresso all’
AUDITORIUM
L'auditorium Parco della Musica è stato progettato dall'architetto Renzo Piano[14], la sua costruzione è iniziata nel 1995 ed è stato inaugurato il 21 aprile 2002[15] (il 21 dicembre dello stesso anno è stata inaugurata la sala Santa Cecilia). Dalla distruzione dell'Auditorium all'interno del Mausoleo di Augusto (Augusteo 1936 - teatro Adriano - teatro Argentina - Auditorium via della Conciliazione) la città di Roma non aveva un luogo dedicato alla musica, svolgeva una simile funzione l'auditorium di via della Conciliazione.
L'auditorium si compone di tre sale che dall'alto assomigliano a tre scarabei oppure a tre liuti, ogni sala è progettata per essere la cassa acustica più idonea per il genere di musica che vi verrà interpretata. Tutti i materiali richiamano i colori di Roma: il bianco del travertino, il rosso dei mattoni, il grigio della copertura delle sale richiama la cupola del Pantheon. La sala Santa Cecilia da 2.700 posti dedicata ai concerti sinfonici per grandi orchestre. Le strutture portanti di copertura - di dimensioni eccezioni - sono costituite da travi in legno lamellare e acciaio. Il palcoscenico si trova quasi in posizione centrale circondato dai vigneti, cioè i posti a sedere posti su diversi livelli. Il controsoffitto - vera innovazione - è costituito da 26 gusci in legno ciliegio americano di 180 mq ciascuno, nel complesso coprono una superficie di 4.000 mq. Il tempo di riverberazione del suono è di 2,2 secondi. E' la più grande sala da concerti d'Europa. La sala Giuseppe Sinopoli[16] da 1.200 posti si adatta ai più diversi tipi di musica anche perchè l'orchestra può assumere varie posizioni. La sala Petrassi[17] da 700 posti per generi musicali più nuovi a causa dei tempi di riverberazione dei suoni, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche perchè permette il cambio delle scene e dei costumi. Le due pareti laterali del palco possono ruotare di 90° così da realizzare il boccascena, tradizionale sipario all'italiana. Esiste una quarta sala: il teatro Studio, uno spazio poliedrico di 492 mq con 330 posti, aperta nel settembre 2005, dotato di posti a sedere non fissi, si trova tra la sala Petrassi e la sala Sinopoli. In quest'area si trovano il Teatro Studio1 - 2 - 3 ognuno di 120 mq, di ciliegio, con annessa sala di regia.
Nel foyer, lungo 150 metri, si trovano venti testi dell'artista toscano Maurizio Nannucci[18].
All'aperto è stata ricavata una càvea intitolata a Luciano Berio[19] di ben 3.000 posti per gli spettacoli estivi, mentre d'inverno ospita una pista di ghiaccio. Nell'auditorium parco della musica si trova - dal 9.2.2008 - il MUSA ovvero il Museo degli Strumenti Musicali dell'Accademia di Santa Cecilia, una delle principali raccolte italiane, si compone di 500 pezzi ma ne espone 130 a testimonianza di diverse culture musicali appartenenti a cinque secoli e a tre continenti: Europa, Asia e Africa. Strumenti della musica colta e della musica popolare, delle musiche etniche extraeuropee. Il nucleo più importante è formato da stumenti della tradizione liutaria italiana dal Seicento al Novecento, alcuni pezzi sono frutto del dono della regina Margherita di Savoia. Fra questi il violino di Antonio Stradivari del 1690, di particolare interesse i mandolini romani di Gaspar Ferrari ideatore di questo strumento. Grazie all'ausilio di sistemi audiovisivi e postazioni multimediali interattive è possibile esplorare l'orchestra, scoprire suoni e sezioni, approfondire la conoscenza della musica. Il museo è stato realizzato grazie all'8 per mille dell'Irpef. E' aperto - ad ingresso gratuito - tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 18, chiuso il mercoledì.
La bibliomediateca si trova subito dopo la libreria, anche questo spazio è stato ideato da Renzo Piano ed è stato aperto al pubblico nel 2005. Contiene l'archivio storico dell'Accademia di Santa Cecilia dal 1651 ad oggi, la biblioteca istituita subito dopo l'unità d'italia nel 1877 con edizioni, partiture, manoscritti, intavolature, libretti, collezioni di grandi critici o compositori. Oggi è stata parzialmente digitalizzata ed è consultabile online sul sito dedicato. E' aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 17.
Nei lavori di scavo per realizzare questa struttura è stata ritrovata una villa romana dell'età repubblicana e imperiale che ha avuto vari periodi di vita con demolizioni e ricostruzioni. La villa del 300 a.C. aveva tegole angolari di gronda con testa di divinità fluviale, questo è diventato il simbolo del piccolo museo che espone i resti archeologici ritrovati prima dei lavori di costruzione dell'auditorium.Si trova tra la sala Sinopoli e la sala Santa Cecilia. Completano l'area un giardino pensile di 30.000 mq, parcheggi sotterranei e a raso, spazi espositivi, caffetteria, libreria, uffici.
Dal 2006 vi si tiene - in autunno - il Festival Internazionale del film di Roma, fino al 2007 denominato Festa Internazionale del Film di Roma. Dal 2012 il direttore artistico è Marco Muller. L'ultima edizione è stata vinta dal film coprodotto dall'Argentina e dalla Spagna dal titolo: "Cosa piove dal cielo?" di Sebastian Borensztein.
Di fronte all’auditorium si estende il
VILLAGGIO OLIMPICO
Vedi documento Villaggio Olimpico.
Fu costruito tra il 1957 e il 1960, su progetto di Vittorio Cafiero[20], Adalberto Libera, Amedeo Luccichenti, Vincenzo Monaco e Luigi Moretti.
Nato per ospitare gli atleti giunti da ogni parte del mondo per le Olimpiadi del 1960, dopo la manifestazione sportiva le case vennero assegnate ai dipendenti dello Stato (Incis). Il Villaggio Olimpico è un complesso unitario di edifici sistemati tra ampie zone verdi tutti caratterizzati dal piano terreno a pilotis ( i pilastri teorizzati da Le Corbusier[21] nel 1927 come uno dei cinque punti della nuova architettura). La stessa caratteristica ha il quartiere di Decima e quello di Casilino 23 oggi Villa De Sanctis.
Ho una foto dei prati che si trovavano nel luogo dove oggi è il Villaggio Olimpico, un’altra foto presenta uno dei palazzi appena terminato.
Proseguendo per viale Pietro de Coubertin, prima della via Flaminia si trova il
PALAZZETTO DELLO SPORT
Piazzale Apollodoro: il Palazzetto dello Sport, dell’ing. Pier Luigi Nervi e dell’arch. Annibale Vitellozzi, 1956-58, a pianta circolare, capace di 5.000 posti e la cui cupola ha il diametro di 68,50 metri. E’ costruito con elementi prefabbricati in cemento armato e sorretto da pilastri a forcella. L’idea è di costruire un edificio in stretto rapporto alla sua funzione e volutamente privo di qualsiasi elemento decorativo. L’edificio – per la sua originalità – si caratterizza come un indicatore urbano. Ho una foto del Palazzetto dello Sport in costruzione e una del 1960.
Davanti al Palazzetto dello Sport passa la PISTA CICLABILE DORSALE ANIENE di Km 9,450. Inizia da ponte Milvio, percorre via Flaminia, giunge al Palazzetto dello Sport, segue per via De Coubertin, si interrompe per breve tratto, via Maresciallo Pilsudski, via della Moschea, via del Foro Italico (Tangenziale Est), incrocia la via Salaria, segue la valle dell’Aniene fino a Monte Sacro. Di lì si può proseguire su sentieri sterrati nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene.
Vicinissimo al Palazzetto dell Sport, nel prato ad angolo tra viale Tiziano e via Nedo Nadi, si trova la scultura di Mario Ceroli[22] “GOAL”, collocata in occasione dei mondiali di calcio del 1990. Si tratta di un’opera in legno ricoperta di acciaio zincato, alta m 16,5.
Si percorre la via Flaminia in direzione centro città. La prima strada a sinistra, che collega via Flaminia con viale Tiziano è via dei Sansovino. Ad angolo si trova un interessante esempio di EDIFICIO POLIFUNZIONALE con facciata su viale Tiziano. E’ opera di Domenico De Riso, del 1961-62. Si riprende via Flaminia fino a piazza Manila, dove confluisce viale Maresciallo Pilsudski. Qui si trova lo
STADIO FLAMINIO
Lo STADIO FLAMINIO è una ardita e razionale costruzione in cemento armato dell’ingegner Pier Luigi Nervi e dell’architetto Antonio Nervi, costruito in previsione delle Olimpiadi del 1960 sul posto del vecchio Stadio Nazionale. Al campo di calcio con gradinate capaci di 24.000 spettatori, sono annesse una piscina coperta, tre palestre , campi e piste d’allenamento, una sala di scherma. E’ adibito a campo di calcio e di rugby, vi si tiene il Torneo Sei Nazioni. Nel 1988 ha ospitato il concerto di Michael Jackson. Durante i lavori di rifacimento dell’Olimpico in previsione dei mondiali di calcio del 1990, questo stadio fu utilizzato da Roma e Lazio per il campionato di serie A. Nel 2007 sono state montate due strutture mobili sopra le curve per aumentare la capacità di 8.000 posti, per il 2012 è previsto un ampliamento stabile con strutture in ferro per portare la capienza a 42.000 posti.
Ho una foto della baraccopoli che si trovava nell’area dello stadio Flaminio prima della sua costruzione.
STADIO NAZIONALE
Lo stadio nazionale venne costruito nel 1911, ristrutturato nel 1927 e ribattezzato Stadio del Partito Nazionale Fascista, dopo la guerra riprese il nome originario, dopo il disastro di Superga fu chiamato Stadio Torino, nel 1953 fu dismesso, nel 1957 demolito. Al suo posto venne costruito l’attuale Stadio Flaminio in previsione delle Olimpiadi di Roma del 1960.
Il progetto dello stadio si deve a Marcello Piacentini, sorse presso villa Flaminia, i campi ippici di villa Glori e ai monti Parioli. Piacentini richiamò i tratti classici dei modelli ellenici, aveva la forma di una U allungata, l’ingresso era formato da due enormi corpi laterali che reggevvano colossali statue sedute della Forza e della Civiltà, internamente si trovavano quattro colonne onorarie congiunte da nastri e festoni di bronzo e sovrastate da statue in bronzo. Misurava 220 metri di lunghezza e 120 di larghezza, era affiancato da due lunghe gradinate raccordate da un lato a semicerchio, un altro lato era aperto per il pubblico. All’interno si trovavano piste podistiche e ciclistiche, dentro numerosi locali su due piani per l’Istituto Nazionale di Educazione Fisica, palestre, bagni, refettori, uffici e dormitori per atleti. Non fu mai utilizzato per incontri di calcio. Fu abbandonato durante la Grande Guerra.
Lo stadio fu ristrutturato nel 1927 prendendo il nome di Stadio del Partito Nazionale Fascista, la tribuna centrale fu dotata di una tettoia a struttura in cemento armato per 7.000 posti. Sul lato di ingresso venne inserita una piscina all’aperto lunga 50 metri e larga 18, dotata di spalti. Internamente vi trovarono posto una vasca coperta, palestre, alloggi, uffici della direzione generale del Coni. Al centro venne realizzato un campo di calcio, la pista podistica venne trasformata in anulare. L’ingresso fu sostituito da una facciata classicheggiante con semicolonne e quattro sculture di Amleto Cataldi, oggi nei giardini del Villaggio Olimpico. Venne inaugurato ufficialmente il 25 marzo 1928 con una amichevole Italia – Ungheria, terminata 4-3. Il 24 maggio 1931 si ebbe la prima partita della Lazio, un derby finito in parità, seguito da una rissa che fu punita con la squalifica del campo di entrambe le squadre. Per i mondiali del 1934 venne eliminata la piscina e ampliato nella capienza. Dal 1940 anche la Roma iniziò a utilizzare questo stadio.
Qui la Roma giocò dal 1940/41, in quell’anno vinse il suo primo scudetto, vi giocò fino al 1953.
Durante l’ultima guerra fu requisito dalle truppe alleate, Roma e Lazio usarono il Motovelodromo Appio e lo stadio della Rondinella. Nel 1953 lo stadio fu abbandonato da Roma e Lazio che preferirono il nuovo stadio Olimpico. Ho una foto dello stadio Nazionale.
STADIO DELLA RONDINELLA
Lo stadio della Rondinella si trovava tra l’attuale stadio Flaminio e il Palazzetto dello Sport, venne costruito nel 1914, ricostruito nel 1924 e dotato di tribuna coperta in legno, spogliatoi, docce, abitazione del custode, spalti su tre lati, con una capienza di 15.000 spettatori. In attesa del trasferimento al campo Testaccio l’impianto ospita anche le partite della Roma, tra queste lo storico 9-0 contro la Cremonese vittoria casalinga con maggior reti di scarto nella storia del club giallorosso. Nel 1957 viene distrutto da un incendio, ciò che rimane viene abbattuto e trasformato in parcheggio.
Nel parcheggio tra lo stadio Flaminio e il Palazzetto dello Sport (via Dorando Pietri) si trova un piccolo monumento con una COLONNA ALLA MEMORIA di due agenti della Polizia di Stato: Franco Sammarco e Giuseppe Carretta uccisi in questo luogo l’8 giugno 1982 mentre effettuavano un controllo in una macchina qui parcheggiata. Nella macchina c’erano tre terroristi dei NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari), di ideologia neofascista, questi riuscirono a sopraffare gli agenti e li uccisero con un colpo alla nuca. L’omicidio venne rivendicato dai NAR che dissero di averlo compiuto per vendicare un loro camerata morto suicida in carcere. Il 28 giugno venne arrestato per questo delitto Roberto Nistri dei Nar che rimase in carcere fino al 1995 quando usufruì di permessi di lavoro, dal 2005 è libero.
Nel quartiere si trova:
VILLA ADA
Vedi documento word “Villa Ada”
Villa Ada è una delle più belle e grandi ville storiche italiane, a Roma è seconda solo a villa Doria Pamphili. Nel Seicento era una tenuta agricola del Collegio Irlandese, alla fine Settecento passò ai principi Pallavicini che la ristrutturarono come giardino di paesaggio creandosi percorsi geometrici e piccole costruzioni. Fu acquistata
dai Savoia nel 1872 che la ingrandirono con altre proprietà fino a giungere ai 180 ettari attuali, a loro si devono le scuderie che attualmente sono in abbandono. Umberto I preferiva vivere al Quirinale e vendette la villa al conte Tellfner, amministratore dei beni della famiglia reale, che la intitolò alla moglie Ada. Vittorio Emanuele III la riacquistò nel 1904 e divenne residenza reale chiamandola villa Savoia fino al 1946 quando i Savoia dovettore lasciare l'Italia in seguito al referendum monarchia o repubblica del 2 giugno.
Durante l'ultima guerra mondiale nella villa venne costruito un bunker antiareo che attualmente si sta restaurando; in questo luogo, il 25 aprile 1943 Benito Mussolini venne arrestato dopo il voto di sfiducia del Gran Consiglio del fascismo. Dopo questi avvenimenti parte della villa rimase di proprietà della famiglia Savoia, mentre la parte più vicina alla via Salaria fu acquisita dal Demanio nel 1957. Una parte della villa fu donata all'Egitto in cambio dell'ospitalità ricevuta durante l'esilio, oggi ospita l'ambasciata di tale paese.
Nella villa ci sono resti archeologici dell'VIII secolo a.C. si riferiscono alla città di Antemnae, probabilmente abitata dai sabini. Venne distrutta dai romani nella loro prima espansione nel Lazio. Sotto il terreno della villa si estendono le catacombe di Priscilla, queste conservano la più antica immagine di Maria e una piccola basilica consacrata da papa Silvestro I.
Anche se il parco è circondato da quartieri edificati da circa cento anni, chi vi passeggia ha l'impressione di trovarsi immerso nella natura: la fitta vegetazione forma a tratti una selva impenetrabile, per questo è luogo ideale per passeggiate o per correre o per andare in bicicletta tra pinete, boschi di leccio, querce da sughero popolate di scoiattoli e conigli selvatici.
Dal 27 novembre 2012 la villa è oggetto di lavori di restauro di grandi proporzioni.
Sono stati piantati 10 nuovi pini alti 6 metri che vanno a sostituire quelli gravemente e irriparabilmente danneggiati dalla nevicata del febbraio 2012. Gli arredi e le strutture di fruizione saranno in breve restaurate: saranno sostituite 1.000 metri di staccionate, 100 vecchi tronchi rimossi, 40 pozzetti impiegati per l'irrigazione saranno messi in sicurezza.
DA: I NONNI DI ROMA RACCONTANO
“Dopo aver abitato a via Frattina andammo ad abitare in viale Bruno Buozzi n. 19, nelle case dell’INA. Le palazzine dell’INA erano, in quegli anni, le più periferiche della strada. Al di là c’erano i campi e qualche villa isolata sulle alture. In quei campi giocavamo a pallone noi ragazzi della zona. La via delle Tre Madonne allora, sembra impossibile oggi, era un sentiero che correva tra sterpi e fratte spinose e che sboccava sulla via Aldrovandi, anch’essa ben diversa da quella che è attualmente”. Da racconto di Giuseppe Tulli in AA. VV. I nonni di Roma raccontano la storia, ed. Comune di Roma, 2006, pag. 43.
“Per molti anni non c’è stata l’acqua corrente in casa, ed ogni rione aveva la fontanella a disposizione per approvvigionarsi di acqua e per i più benestatnti passava anche l’acquaiolo, con i contenintori sulle spalle osu un carretto, che vendeva l’acqua acetosa” (Anna Silvani).
“Della Roma dei miei tempi ricordo la caratteristica Fonte dell’Acqua Acetosa, dalla parte dei Parioli, a pochi metri dal fiume Tevere. Dopo una scalinata di una trentina di scalini si accedeva alla fonte dell’Acqua Acetosa che usciva da varie fontanelle. Si diceva che fosse un’acqua medicamentosa, essa faceva bene a tutte le malattie e malesseri del corpo. Forse questo non era vero; ma la gente accorreva da ogni parte di Roma per fare ampie bevute di un’acqua, leggermente acidula, nella speranza di ricavarne vantaggi per la salute. Molti ne riempivano bottiglie e fiaschi per i famigliari” (Tullio Filtri). Da: AA.VV. I nonni di Roma raccontano la stori, ed. Comune di Roma, 2006, pag. 57.
Chiesa Sacro Cuore Immacolato di Maria, nel luglio 2013 vi si sono svolti i funerali di Rinaldo Santini già sindaco di Roma e presidente della Regione Lazio.
Vicino via Archimede, in un attico, abitava re Farouk d’Egitto dopo essere stato spodestato nel 1965 da Nasser. Spesso capitava di vederlo con Irma Capece Minutolo, promessa dal canto lirico e attrice. Usciva a tarda sera per il Cafè de Paris a via Veneto dove frequentava Anita Ekberg, Ava Gardner, Sofia Loren, Gregory Peck. Nel giro Marcello Mastroianni, Walter Chiari e spesso Frank Sinastra con la scorta. Frequentava anche il caffè Rosati in piazza del Popolo. Si racconta di un ristorante fatto riapriare alle due di notte per il piacere del re di mangiare. E’ stato uno dei personaggi della dolce vita.
IL QUARTIERE NEL CINEMA
In piazza Ungheria è l’abitazione del protagonista del film “Audace colpo dei soliti ignoti”, si tratta dell’attore Vittorio Gassman che interpreta Giuseppe “Peppe er pantera”. Il film è del 1959, la regia di Nanni Loy.
BIBLIOGRAFIA
- AA.VV. Guida d’Italia, Roma, ed. Tci, 1993.
- AA.VV. Roma, libri per viaggiare, ed. Gallimard – Tci, 1994.
- AA.VV. I rioni e i quartieri di Roma, ed. Newton & Compton, 1989.
- AA.VV. Le strade di Roma, ed. Newton & Compton, 1990.
- Claudio Rendina (a cura di), Enciclopedia di Roma, ed. Newton & Compton, 2005.
- Sabrina Ramacci, 1001 cose da vedere a Roma almeno una volta nella vita, Newton Compton, 09.
- Mariano Armellini, Le chiese di Roma, ed. Pasquino, 1982.
- Carlo Zaccagnini, Le ville di Roma, ed. Newton Compton, 1991.
- Willy Pocino, Le fontane di Roma, Newton & Compton, 1996.
- Irene de Guttry, Guida di Roma moderna, ed. De Luca 1989.
- Gaia Remiddi e altri, Il moderno attraverso Roma, ed. Groma, 2000.
- Piero Ostilio Rossi, Roma. Guida all’architettura moderna, ed. Laterza, 1991.
SITOGRAFIA
www.comune.roma.it
www.archeoroma.beniculturali.it
www.museiincomune.roma.it
www.culturaroma.it
www.romasegreta.it
www.laboratorioroma.it
www.romasparita.eu
www.info.roma.it
www.abcroma.com
www.it.wikipedia.org
www.maps.google.it
Piero Tucci
07.04.14
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
inbiciperoma.blogspot.org
AGGIORNAMENTI
10.4.14Parioli. Apre sede della Lega Nord in via Caroncini 23 in un elegante studio professionale. Presente Matteo Salvini segretario.
14.9.14 Antico tiro a volo in via Eugenio Vajna 21 (piazza delle Muse). Stop allo sgombero di uno dei circoli più antichi e blasonati di Roma. Il Comune rivuole i locali, ma il Tar ha congelato il provvedimento. Il circolo ospita appuntamenti mondani, tra le presenze Carlo Azeglio Ciampi e Gianni Letta. Anche il sindaco di New York Bill De Blasio.
21.12.14Chiesa di San Roberto Bellarmino a piazza Ungheria, ieri i funerali dell’attrice Virna Lisi.
27.3.15 Stadio Flaminio. Una fiacc olata contro il degrado. Molte associazioni puntano alla gestione, potrebbe dare lavoro a centinaia di persone.
31.3.15 Cronaca. Parioli, via Archimede. Furto in casa dell’attrice Vittoria Belvedere, portati via orologi di lusso e gioielli.
10.2.16 Parioli. Villa Ada.Il chiosco bar Panamino deve essere smantellato, la sentenza del Consiglio di Stato chiude un contenzioso che dura da quattro anni.
19.2.16 Parioli. Ristorante Celestina.Incendio doloso la mattina di ieri intorno alle ore 6, ritrovata una tanica di benzina. Era frequentato da Massimo Carminati ma anche tanti uomini del mondo dello spettacolo: Costanzo, Sophia Loren e George Clooney.
24.2.16 Inchiesta concessioni edilizie. Parioli. L’edificio della Zecca di piazza Verdi diventato albergo di lusso. Tale trasformazione avvenuta contro il parere dell’avvocatura del Comune del 2011. Si indaca sul dipartimento Urbanistica.
5.3.16 Auditorium. Da qualche giorno l’annuncio che la sala Petrassi sarà dedicata al cinema, i gestori dei cinema del Lazio si ribellano. Ma dalla dirigenza dell’Auditorium arrivano toni concilianti: la sala Petrassi solo per prime ed eventi speciali.
11.3.16 Cronaca. Alle ore 19,15 è nata Isabel, terza figlia di Totti, pesa Kg 3,240, il parto è avvenuto alla clinica Mater Dei dei Parioli, via Antonio Bertoloni 34. Il papà ha assistito al parto.
14.3.16 Auditorium. Villa Giulia. Il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano, per la finale del settantesimo anniversario, il 2 luglio prossimi si trasferisce dal Ninfeo di villa Giulia all’auditorium con una serata speciale di filmati e testimonianze.
1.10.16 Auditorium. Festa del Cinema. Roma città del cinema. Dal 13 al 23 ottobre l’undicesima edizione dedicata a Gian Luigi Rondi recentemente scomparso. 44 film in concorso e incontri con i protagonisti. Il 18 a Trinità dei Monti la proiezione di Vacanze Romane con i figli di Gregory Peck. Il 13 l’attore Tom Hanks – che inaugura la rassegna - riceverà il Premio alla Carriera e gli sarà dedicata una ampia retrospettiva. Oltre che all’Auditorium si terranno proiezioni al Maxxi, alla Casa del Cinema in un drive-in realizzato all’Eur, al Barberini e in altre sale.
5.10.16 Auditorium. Blancio 2015 in rosso. Meno
o iniziative, sponsor in fuga, buco di 2,2 milioni. Nel conto il taglio dei trasferimenti pubblici, in particolare del Comune passato da 2,3 a 1,3.
7.11.16 Palazzetto dello Sport. Parioli. Piano per il restauro e la messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport da 1.980.000€ di euro voluto dal Comune (Frongia, vicesindaco e assessore allo sport.
11.2.17Botteghe storiche. Parioli. Chiude la casa delle sete, Bruscoli a via Nino Oxilia (piazza Ungheria). Dopo 60 anni termina le attività per la troppa concorrenza delle catene di intimo. Per la sua prima gravidanza Monica Bellucci ha compato qui cinque vestaglia e camicie da notte, tutte di colori diversi. La Magnani e la Loren tra i clienti di intimo: calze, parure da notte in seta, i guanti da pellame talmente sottili da scordarsi di averli indossati.
[1] Popolazione al 2013, dati statistici di Roma Capitale.
[2] Clemente Busiri Vici (1887-1965) chiesa di San Roberto Bellarmino a piazza Ungheria nel 1932-33, chiesa dei Santi Fabiano e Venanzio a villa Fiorelli nel 1936, chiesa di sant'Ippolito al quartiere Nomentano nella via omonima nel 1933, chiesa di san Saturnino in via Avigliana al quartiere Trieste nel 1935, l'Istituto Nazionale Luce in via Tuscolana 1055 nel 1937, Case Gescal in viale Spartaco tra viale Publicola e viale Agricola (in coll.) nel 1963-65
[3] Palazzina in via Bruxelles. Da: Guida di Roma moderna di Irene de Guttry, pag. 58.
[4] Palazzina di Mario Tufaroli in via Panama. Tutte le notizie da: Guida di Roma Moderna di Irene de Guttry.
[5] Vittorio Cafiero (Roma 1901-81) Sede del Comando dei Carabinieri in via Romania nel 1935, il palazzo del ministero dell'Africa Italiana ora palazzo della Fao (in coll.) nel 1938-52 e ampliamento nel dopoguerra, Villaggio Olimpico con Libera, Luccichenti, Monaco e Moretti nel 1960, ministero delle Finanze all'Eur in viale America nel 1962, ponte di Tor di Quinto nel 1962, il quartiere Incis di Decima in coll. con altri nel 1961.
[6] Giò Ponti. (Milano 1891 - 1979) E' l'autore del grattacielo Pirelli a Milano nel 1956-61, della Concattedrale di Taranto nel 1964-71. Nel 1935 progettò l'istituto di Matematica nella città universitaria. Nel 1964 l'hotel Parco dei Principi in via Mercadante.
[7] Palazzo Incis di via Scipio Slataper. Tutte le notizie da Guida di Roma moderna di Irene de Guttry, pag. 59. L’INCIS era l’Istituto Nazionale per le Case agli Impiegati dello Stato. Un esempio è il quartiere di Decima a Roma.
[8] Bar Cigno a viale Parioli. Il testo di Marco Lodoli è preso dalla cronaca di Roma de la Repubblica del 02.02.2003.
[9]Paolo Portoghesi (Roma 1931) docente universitario e critico dell'architettura, principale esponenste del moviemnto Postmoderno di cui ha riunito gli esponenti più significativi alla Biennale del 1980. Accademico di San Luca, è stato presidente del Politecnico di Milano e docente della facoltà di architettura a valle Giulia. Autore della moschea di Roma (1974), del restauro del borgo di Calcata nella valle del Treja, della reggia di Amman in Giordania nel 1973, del quartiere per dipendenti Enel di Tarquinia nel 1981, del quartiere di Ponte di Nona Ater a Roma (progetto del 1986, realizzazione nel 2005-08), ha ridisegnato a titolo gratuito piazza San Silvestro a Roma (2011).
Tra le altre realizzazioni si ricordano: Casa Baldi al Km 12 della via Flaminia nel 1960, il villino Papanice in via Marchi 1 nel 1967, la scuola Ennio Flaiano in via Fleming - via Gosio con Gigliotti nel 1971. Ha ristrutturato l'Hotel de la Minerva a Roma nel 1990.
[10] Paolo V. Camillo Borghese papa dal 1605 al 1621. Fu un papa nepotista, il nipote diede avvio alla costruzione della villa e del Casino come pure della collezione d'arte oggi Galleria Borghese. Affidò a Carlo Maderno la costruzione della facciata di San Pietro su cui spicca il suo nome, eresse il transetto modificando il progetto michelangiolesco. Affidò a Flaminio Ponzio l'ampliamento del palazzo del Quirinale. Restaurò l'acquedotto che portava l'acqua da Bracciano detto di Traiano e da allora Acqua Paola, fece costruire il fontanone del Gianicolo e quello oggi in piazza Trilussa come mostra. In santa Maria Maggiore fece costruire la cappella Paolina di fronte alla Sistina e davanti alla chiesa fece erigere la colonna prelevata dalla basilica di Massenzio. Fermo sostenitore dei diritti della Chiesa entrò in conflitto con Venezia per cui lanciò l'interdetto a Venezia nel 1606. Appoggiò la lega cattolica nella Guerra dei Trent'Anni. Fece costruire i porti di Fano e Civitavecchia.
[11] Alessandro VII. Fabio Chigi di Siena, papa dal 1655-67. Lo stemma quadripartito ha i tre monti con una stella e la quercia con i frutti. Membro di una famiglia di banchieri si avvalse del nepotismo in maniera ampia. Protettore del Bernini gli diede l'incarico di progettare il colonnato di piazza San Pietro e la sua tomba nella Tribuna di San Pietro. A lui si deve la biblioteca universitaria oggi nella città universitaria, già alla Sapienza. Impartì il battesimo a Cristina di Svezia. E' sepolto in San Pietro nel passaggio tra abside e transetto sinistro.
[12] Annibale Vitellozzi. (Anghiari 1902 – Roma 1990) Stazione Termini con altri, stadio Olimpico nel 1960 con altri, complesso sportivo dell'Acqua Acetosa con Ligini, la nuova sede della Biblioteca Nazionale a Castro Pretorio nel 1969, lo stadio del nuoto al Foro Italico con Del Debbio nel 1960.
[13] Cesare Ligini. (Roma 1913-1988) Inizia come scenografo e grande disegnatore di prospettive, aderisce al razionalismo e poi al rinnovamento del linguaggio architettonico italiano all'interno dell'APAO. Costruisce padiglioni italiani alle fiere d'Europa e d'America, anche edifici pubblici con la collaborazione di artisti come: Severini, Gentilini, Castelli e Capogrossi. Le Torri delle Finanze (1962) le ha progettate con Cafiero, Marinucci e Venturi. Suoi il complesso sportivo dell'Acqua Acetosa (1960) con Vitellozzi, il Velodromo Olimpico sempre all'Eur e la Casa di Culto delle Suore Dorotee in via della Pineta Sacchetti.
[14] Renzo Piano (Genova 1937) autore del Centre Pompidou a Parigi (1971), della ristrutturazione del Porto Vecchio di Genova in occasione dell'Expo 1992, dell'aeroporto internazionale di Kansai in Giappone (1988-94), del Centro Culturale Tijbaou a Noumea in Nuova Caledonia (1991-98), della riqualificazione di Potsdamer Platz a Berlino dopo il crollo del muro del 1989 (1992-2000), delle quattro torri per uffici e residenze a Sydney in Australia (1996-2000), della Chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo (Foggia) e dell'Auditorium de l'Aquila (6 ottobre 2012).
[15] Inaugurazione Alla presenza del Presidente della Repubblica Ciampi e di 50.000 persone, 13 ore di musica in quella giornata. Per il 21 dicembre Ciampi intervenne in diretta alla trasmissione tv di Morandi "Uno di noi" abbinata alla lotteria Italia. Ditte costruttrici: Colombo Costruzioni, Edil Pav, Speco, Addessi Service. I materiali sono stati forniti dalla Mapei.
[16] Giuseppe Sinopoli (Venezia 1946 - Berlino 2001) direttore d'orchestra, compositore e saggista.
[17] Goffredo Petrassi (Zagarolo 1904 - Roma 2003) compositore e maestro per un'intera generazione di compositori, la sua attività abbraccia vari generi musicali pur mantenendosi coerente. Da ragazzo lavorò come commesso in un negozio di strumenti musicali. Diplomato al Conservatorio di Roma in organo e composizione.
[18] Maurizio Nannucci (Firenze 1939) uno dei maggiori esponenti della "poesia visiva". Sudente all'Accademia di Belle Arti di Firenze e di Berlino, fu inizialmente scenografo, lavorò con il Gruppo Fluxus, si dedicò alla musica elettronica. La sua prima esposizione nel 1967 al Centro Arti Visive di Trieste, da allora realizza testi con lampade al neon. Attento al rapporto con l'architettura e il paesaggio collabora con Piano, Fuksas e Botta negli anni Novanta. Ha esposto alla Biennale di Venezia, sue opere al Moma di New York, al Centree Pompidou di Parigi al Paul Getty Art Center di Los Angeles.
[19] Luciano Berio (Oneglia, Imperia 1925 - Roma 2003) compositore italiano d'avanguardia, pioniere nel campo della musica elettronica.
[20] Vittorio Cafiero (Roma 1901-81) ha progettato il Comando Carabinieri a viale Romania, l'ampliamento del palazzo della Fao. Nel 1957-62 il ministero delle Finanze all'Eur attualmente in demolizione.
Adalberto Libera (Trento 1903-Roma 1963) Ha progettato il palazzo delle Poste in via Marmorata con De Renzi nel 1933, il palazzo dei Congressi all'Eur nel 1937-42, Casal Palocco, il quartiere di Decima con altri.
Amedeo Luccichenti (Isola Liri 1899- Roma 1976) ha progettato le case popolari in via Pinturicchio nel 1949-50, ville a Casal Palocco e l'Hotel Hilton a monte Mario.
Vincenzo Monaco (Roma 1911-1969) ha lavorato con Luccichenti. Nel 1968 ha progettato l'hotel Jolly in via Labicana con Corre e Ferretti.
Luigi Moretti (Roma 1907-1973) Accademia di Scherma al Foro Italico, la Casa del Girasole a via Buozzi, il quartiere Incis di Decima e il parcheggio di Villa Borghese.
[21] Le Corbusier pseudonimo di Charles Edouard Jenneret - Gris (1887-1965) maestro del movimento moderno, pioniere dell'uso del calcestruzzo armato, padre dell'urbanistica contemporanea. In 60 anni di attività a progettato 75 edifici in 12 paesi del mondo. Forse il suo capolavoro è la Cappella di Notre Dame de Haut a Ronchamp del 1950. Ha progettato una nuova città Chandigarh, capitale del Punjab in India.
[22] Mario Ceroli. (Castel Frentano 1938) scultore vivente, tra i massimi rappresentanti dell’arte povera, i suoi lavori sono caratterizzati da sagome in legno di figure umane o oggetti, prive di colore, ripetute in serie. La sua prima opera che lo ha reso famoso è “Ultima cena” del 1965, seguì “Uomo di Leonardo” del 1964, “La Cina” del 1966, tutto l'arredo interno della chiesa di Tor Bella Monaca di Roma Maria Madre del Redentore (1985), “Unicorno alato” del 1987 per il Centro Rai di Saxa Rubra. Ha realizzato una installazione ambientale "Burri" (1966) dove Twobly guarda seduto su sedie grezze un quadro di Burri (da depliant mostra su Burri alle Scuderie del Quirinale). Svolse un’intesa attività di scenografo per il Teatro alla Scala di Milano e per il Teatro Stabile di Torino. Quando nel 2007 il palazzo delle Esposizioni di Roma ha riaperto al pubblico, una sua retrospettiva lo ha inaugurato. Docente all'Accademia di Belle Arti di Roma.
PASSEGGIANDO CON
BEATRICE CENCI
Un ringraziamento particolare
va al mio amico Giuseppe D.R. che
mi ha fornito tutto il materiale
necessario per questo testo.
LA VICENDA UMANA
Beatrice Cenci è nata a Roma il 6 febbraio 1577, figlia di tale conte Francesco Cenci appartenente ad una delle più ricche e influenti famiglie della Roma del tempo e di Ersilia Santacroce.
Il conte era uomo rissoso, violento, spesso in contrasto con la giustizia. Trattava i sei figli molto duramente, li faceva vivere in povertà, privandoli anche del necessario. La loro situazione peggiorò quando il padre si invaghì di una donna bellissima, Lucrezia Petroni. Allora allontanò i figli da Roma mandandoli a studiare all’università di Salamanca e, guarda caso, la moglie morì. Nel 1593 Francesco sposò Lucrezia Petroni, da allora fece di tutto per isolare la sua famiglia da ogni contatto con l’esterno.
La figlia Antonina scrisse al Papa scongiurandolo di trovargli un marito o di farla rinchiudere in un convento. Clemente VIII fece in modo di farla maritare con Carlo Gabrielli, di una nobile famiglia di Gubbio, costringendo il padre a predisporre una cospicua eredità. Nel frattempo i tre figli maschi tornarono a Roma perché non ricevevano più alcun sostentamento, quando il padre li vide li cacciò di casa. Anche in questo caso i giovani si rivolsero al pontefice che costrinse il conte ad assegnargli una discreta somma.
Intanto Beatrice cresceva in grazia e bellezza, il padre la teneva chiusa in casa e – a causa della sua mente malata – abusava di lei. La matrigna fece si che Beatrice conoscesse monsignor Guerra, un giovane avviato alla carriera ecclesiastica, nella speranza che chiedesse la mano di Beatrice al fine di salvarla da un padre così possessivo. Allora il conte portò tutta la famiglia a Rocca di Petrella, lì tutti i membri della famiglia furono rinchiusi nella rocca. Due servitori riuscirono a far uscire dalla rocca alcune lettere di Beatrice a monsignor Guerra, in esse la giovane donna chiedeva di essere aiutata a liberarsi del padre-padrone. Allora Guerra offrì ai servitori 2.000 zecchini per assassinare il conte.
I due servitori, con l’aiuto di Lucrezia, uccisero il conte durante il sonno e lo gettarono dal torrione della rocca per simulare un incidente o suicidio. Dopo tale delitto la famiglia rientrò a Roma. Uno dei due assassini venne arrestato a Napoli per un altro omicidio e confessò l’assassinio del conte Cenci. La famiglia Cenci venne arrestata. Monsignor Guerra camuffatosi da carbonaio fuggì da Roma e si rifugiò in Francia. Giacomo, Bernardo e Lucrezia furono interrogati e sottoposti a tortura con la corda. A questo punto confessarono accusando Beatrice di aver organizzato il tutto. Anche Beatrice, costretta sotto tortura, alla fine confessò. Clemente VIII[1] tolse il titolo nobiliare alla famiglia, confiscò i loro beni (tra questi il ritratto di Beatrice opera di Guido Reni) che furono acquistati dalla famiglia Borghese.
I Cenci furono giudicati colpevoli e condannati: alla decapitazione Beatrice e Lucrezia, allo squartamento Giacomo, mentre Bernardo, per la sua giovane età ebbe salva la vita, anche se fu costretto ad assistere alla condanna. L’esecuzione avvenne davanti ad una grande folle la mattina dell’11 settembre 1599 di una giornata calda e afosa. Il corpo di Beatrice, dopo essere rimasto esposto fino alle ore 16,30 davanti alla statua di San Paolo, fu raccolto dalla Confraternita della Misericordia e, insieme ad una folla commossa, portato in San Pietro a Montorio dove venne sepolto sotto l’altare maggiore con il capo poggiato su un piatto d’argento.
Della tragica figura di Beatrice Cenci hanno scirtto: Shelley, Stendhal, Guerrazzi, Dumas padre, Moravia e tanti altri italiani e stranieri. Numerose le opere musicali dall’opera in tre atti del compositore triestino Giuseppe Rota su libretto di Davide Rabbeno (1863) fino al musical di Simone Martino e Giuseppe Cartellà del 2015.
Alla figura di Beatrice Cenci sono ispirati ben otto film, il primo nel 1909 di Mario Caserini, l’ultimo nel 2014 “Vittima degli eventi” di Claudio Di Biagio. Il film “Beatrice Cenci” di Riccardo Freda del 1956 vede tra gli interpreti Gino Cervi. Nella miniserie Rai “Caravaggio” del 2007 c’è un riferimento a Beatrice Cenci interpretata da Maria Elena Vandone.
Ogni anno, nell’anniversario della morte della giovane, per volontà del principe Cenci Bolognetti, discendente della famiglia Cenci, viene celebrata una messa nella chiesa di Gesù e Maria in via del Corso.
PALAZZO CENCI
E’ un complesso edilizio sorto su un’altura denominata Monte Cenci, costituitasi sui ruderi del Circo Flaminio. Già nel Trecento i Cenci sono qui segnalati, il palazzo assunse il volto attuale tra il 1570 e il 1585, costituendo una sorta di castello con torre demolita nel 1888. Anche se la facciata principale è su via dei Cenci è la parte posteriore quella da sempre considerata la più importante e caratteristica. Il palazzo è collegato, tramite il cosiddetto Arco de’ Cenci al palazzetto Cenci, progettato da Martino Longhi il Vecchio[2] nella prima metà del Cinquecento. L’arco dei Cenci è tristemente noto perché collegato ad un fatto di sangue: sotto l’arco vi era una mmmagine della Vergine dinanzi alla quale due uomini vennero ai coltelli. Uno dei due vistosi perduto, implorò l’altro di non ucciderlo, questi gettò il coltello, allora l’altro lo pugnalò a morte. In seguito a ciò la Madonna pianse. Il luogo divenne meta di pellegrinaggi tanto che l’immagine venne trasportata nella chiesa che ora si chiama Santa Maria del Pianto.
La facciata si presenta in due parti ben distinti, una al civico 21, mostra sotto l’intonaco caduto la costruzione a tufelli di epoca medioevale con una finestra murata, l’altra è impostata su strutture tardo cinquecentesche, presenta un bugnato liscio al piano terra nel quale si aprono due portali su uno di questi è posta una testa di medusa. Osservando bene questa costruzione si riconosce la torre medioevale distrutta a fine Ottocento quando venne risanato il Ghetto, per la presenza di finestre sovrapposte.
Il palazzo è fronteggiato dalla chiesa di San Tommaso in Capite Molarum, per la sua vicinanza ai molini ancorati nel Tevere. Nel Trecento la chiesa divenne la cappella gentilizia della nobile famiglia dei Cenci che qui avevano preso dimora. La chiesa è il risultato dei lavori fatti eseguire da Cristoforo Cenci nel 1555 e terminati dal figlio Francesco nel 1575. Fra i due portali di ingresso si trova una ara funeraria di epoca funeraria. Interno a navata unica affrescato dal Sermoneta[3] con scene della Natività. Oggi la chiesa appartiene alla confraternita dei vetturi o bottari, che ogni anno vi fanno celebrare una messa nell’anniversario dell’uccisione di Beatrice Cenci.
Il retro è costituito da due palazzi. Al civico 7a l’ingresso è costituito da un arco e sormontato da una graziosa loggia ornata da paraste con capitelli ionici e conchiglie e da una finestra incorniciata con stucchi settecenteschi, il coronamento è un fregio con le mezzelune dei Cenci e le aquile dei Lante in ricordo del matrimonio tra Ludovico Cenci e Laura Lante nel 1575.
Al civico 7 vi è un altro ingresso con un portale bugnato e sormontato da volute, il corpo di fabbrica è rivestito di semplice intonaco. L’Arco dei Cenci è subito dopo. Oltrepassato l’arco si giunge in breve in via di Santa Maria dei Calderari che nel nome ricorda una chiesa scomparsa sede della confraternita dei calderari, rigattieri, materassai e cocchieri. Nella strada si trova la chiesa di Santa Maria del Pianto e resti di un arco di mattoni incorniciato da due pilastri tuscanici in travertino che sostengono una piattabanda appartenuto ad un portico, per molto tempo si credeva che appartenesse alla Cryta Balbi[4], finchè nel 1960 uno studio approfondito attribuì l’arco ad un portico vicino al circo Flaminio.
CORTE SAVELLA
In via di Monserrato 43 sorge un palazzo seicentesco, sede dal 1650 del Collegio Inglese, rinnovato da Virginio Vespignani[5] nel 1869. Impossibile vedere le strutture quattrocentesche dell’edificio di proprietà dei Savelli, nobili custodi del conclave di Santa Romana Chiesa, e sede del tribunale assegnato a quella famiglia nel 1375. Il palazzo si può vedere nella pianta del Tempesta del 1648. I prigionieri, durante gli interrogatori venivano sottoposti a tortura, i condannati spesso venivano impiccati alle inferriate stesse del palazzo, altre volte venivano decapitati in piazza di Ponte, di fronte a Castel Sant’Angelo. In questo palazzo finirono anche due rappresentanti della stessa famiglia Savelli. Il palazzo ebbe funzione di carcere fino al 1652 (insieme al carcere di Tor di Nona) quando papa Innocenzo X decise la costruzione delle Carceri Nuove in via Giulia su progetto di Antonio Del Grande.
In questo carcere vennero rinchiuse, interrogate e torturate Beatrice Cenci e la matrigna Lucrezia Petroni, mentre i fratelli Giacomo e Bernando erano nel carcere di Tor di Nona.
PALAZZO BARBERINI
Uno dei più imponenti palazzi nobiliari costruiti a Roma ed uno degli esempi più alti dello stile Barocco. L’elezione al soglio pontificio di Urbano VIII nel 1623 portò la famiglia Barberini a volere per se un palazzo che fosse emblema del livello sociale raggiunto. Per realizzare tale palazzo vi lavorarono tre artisti di livello eccezionale: Bernini, Borromini e Pietro da Cortona.
Fu Carlo Maderno a iniziare i lavori e a concepire una pianta innovativa, non chiusa con un cortile al centro, secondo la tradizione rinascimentale, bensì aperta ad ali parallele congiunte da un corpo centrale (come la villa Farnesina di Baldassarre Peruzzi). Ampio e solenne lo scalone a pianta quadrata , sulla sinistra, opera del Bernini, più piccola ma pittoresca la scala elicoidale a destra, realizzata dal Borromini. Pietro da Cortona, invece, dipinse la volta del grande salone, che porta il suo nome, con il Trionfo della Divina Provvidenza, giustamente considerato uno dei vertici della pittura barocca. Con essa si voleva esaltare la famiglia Barberini, in essa l’artista fece uso di ardite trovate prospettiche e illusionistiche.
Il palazzo conserva il presunto ritratto di Beatrice Cenci di Guido Reni[6] e Giuditta e Oloferne di Caravaggio[7] che era presente all’esecuzione di Beatrice e nell’episodio biblico ritrò la vicenda vissuta dalla giovane romana.
PIAZZA DI PONTE SANT’ANGELO
In questo luogo, profondamente cambiato dopo la costruzione degli argini del Tevere (1880 circa), avvenivano le esecuzioni capitali. Qui la mattina del 11 settembre 1599, giornata afosa, venne condannata a morte tramite decapitazione Beatrice Cenci, testimoni del tempo dicono che appoggiò di sua iniziativa la testa al ceppo, e prima di morire invocò Gesù e Maria. Dopo di lei venne uccisa la matrigna Lucrezia Petroni, quindi il fratello Giacomo venne stordito con un colpo di mazza e squartato. Una grande folla seguì l’esecuzione, tra di loro Caravaggio e Artemisia Gentileschi.
La presunta spada con la quale venne mozzata la testa a Beatrice Cenci venne ritrovata nel Tevere a fine Ottocento nei lavori di canalizzazione che portarono alla costruzione degli argini del fiume. La lama è lunga cm 101 e larga cm 5, l’impugnatura misura cm 38. Tale spada è conservata nel museo Criminologico di via del Gonfalone (via Giulia), dove una volta erano le carceri pontificie. Secondo una antica leggenda, assolutamente non dimostrata, la notte tra il 10 e l1 settembre di ogni anno, se notte di luna piena, il fantasma di Beatrice Cenci attraversa il ponte reggendo sulla mano destra la sua testa.
Ponte Sant’Angelo è forse il più bello dei ponti antichi sul Tevere, detto Elio dal nome dell’imperatore Elio Adriano che lo fece costruire dall’architetto Demetriano nel 136 come accesso al suo mausoleo, solo le tre arcate di mezzo sono antiche. Clemente VII[8] fece porre le due statue di San Pietro ( di Lorenzetto) e San Paolo ( di Paolo Taccone) sul lato opposto al castello, per cura di Clemente IX[9] vi furono collocate, su nuove spallette disegnate dal Bernini, le dieci statue di Angeli coi simboli della Passione, spettacolare e scenografica parata, costituente uno dei più eleganti e armoniosi complessi del Barocco romano. Le statue furono scolpite da allievi del Bernini che ne fornì i bozzetti e ne seguì l’esecuzione. L’Angelo col cartiglio e L’Angelo con la corona di spine sono del maestro, ma il papa volle che fossero collocate nella chiesa di Sant’Andrea delle Fratte, quindi i contemporanei ne realizzarono copie per il ponte. L’Angelo con la collana è di Antonio Raggi, l’Angelo con la Croce è di Ercole Ferrata[10].
Fino agli anni Sessanta, sotto ponte Sant’Angelo, c’era la spiaggetta per i bagni nel fiume e il barcone del “Ciriola” tipico personaggio romanesco, chiamato così perché pescava un pesce a forma del pane romano detto ciriola o sfilatino, il suo barcone venne utilizzato per vari film: “Poveri ma belli”, “Vacanze romane”. Il Ciriola aveva salvato molte persone.
CHIESA DI SAN PIETRO IN MONTORIO
La chiesa sorge sul luogo dove, secondo la tradizione, l’apostolo Pietro fu crocifisso sulla croce a testa in giù, sebbene la storia ritenga che il martirio sia avvenuto nel circo di Caligola e Nerone presso il Vaticano. L’appellativo Montorio deriva da Mons aureus per la marna gialla. La chiesa fu fondata nel medioevo per i monaci celestini, nel XII passò passò ai benedettini e alla fine del quattrocento fu affidata da papa Sisto IV ai frati Francescani. I frati, provvidero ad abbattere il vecchio edificio per costruirne uno nuovo. La chiesa fu eretta con donazioni di Luigi XI di Francia, poi dei reali di Spanga Ferdinando V ed Isabella di Castiglia, consacrata il 6 giugno 1500. Architetto fu Baccio Pontelli. I bombardamenti per schiacciare la repubblica Romana del 1849 danneggiarono seriamente la chiesa e il campanile che venne ricostruito.
La chiesa presenta un’elegante facciata a timpano a due ordini con rosone gotico, preceduta da una doppia rampa di scale.
L’interno è a unica navata terminante ad abside poligonale, conserva notevoli opere d’arte di Giorgio Vasari (la cappella del Monte e la precedente), di Sebastiano del Piombo (la Flagellazione e la Trasfigurazione nella prima cappella di destra) e di Gian Lorenzo Bernini (seconda cappella di sinistra, Raimondi). La Trasfigurazione di Raffaello era sull’altare maggiore. Ora sull’altare maggiore si trova una copia della Crocifissione di San Pietro di Guido Reni realizzata da Vincenzo Camuccini.
Sotto l’altare maggiore, non ricordata da alcuna lapide, venne sepolta Beatrice Cenci. Con l’occupazione francese di Roma a fine Settecento, la tomba venne profanata da un soldato francese di nome Jean Maccuse per impossessarsi di un piatto d’argento. Il soldato prese a calci il teschio della povera sventurata. Il pittore Vincenzo Camuccini[11] fu testimone del lugubre evento.
A destra della chiesa si trova un chiostro formato da una serie di arcate murate e da un portico di tre arcate rette da pilastri. Al centro si innalza il bellissimo tempietto del Bramante, nella cappellina sotterranea si può vedere il foro nel quale sarebbe stata piantata la croce del martirio. Qui il Bramante realizzo, nel 1502 quello che molti considerano il primo vero edificio rinascimentale di Roma. La forma circolare del tempio ricorda i martyria cristiani (le cappelline che ricordavano i primi martiri), dodici colonne doriche sostengono la trabeazione con metope sormontata a sua volta da una balaustra. Al di sopra si innalza la cupola, impostata su alto tamburo cilindrico.
BIBLIOGRAFIA
- AA.VV. Guida d’Italia, Roma, ed. Tci, 1993.
- AA.VV. Roma, libri per viaggiare, ed. Gallimard – Tci, 1994.
- AA.VV. I rioni e i quartieri di Roma, ed. Newton & Compton, 1989.
- AA.VV. Le strade di Roma, ed. Newton & Compton, 1990.
- Claudio Rendina (a cura di), Enciclopedia di Roma, ed. Newton & Compton, 2005.
- G.C. Argan, Storia dell'arte italiana, ed. Sansoni, 1975.
- AA.VV. Storia dell’Arte, Istituto Geografico De Agostini,1975.
- AA.VV. Storia Universale dell’Arte, ed. Leonardo,1997.
- Ernest H. Gombrich, La storia dell’arte, ed. Leonardo, 1995.
- AA.VV. L’arte nella storia dell’Uomo, Giunti, 1997.
- AA.VV. Enciclopedia Universale, ed. Garzanti, 2003.
- AA.VV. Enciclopedia dell’Arte, ed. Garzanti, 2002.
- AA.VV. Stradaroma, ed. Lozzi, 2005.
- AA.VV. Tutto Città, 2011/2012, ed. Seat.
SITOGRAFIA
www.comune.roma.it
www.archeoroma.beniculturali.it
www.tesoridiroma.net
Piero Tucci
26.12.16
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
[1] Clemente VIII Ippolito Aldobrandini. Nato a Fano.Papa dal 1592 al 1605. Il suo stemma è attraversato diagonalmente da una striscia dentata, ai lati della quale si trovano tre stelle per lato. Durante il suo pontificato furono eseguite le condanne a morte di Giordano Bruno (1600) e di Beatrice Cenci (1599). Riconobbe Enrico IV re di Francia, riuscì ad includere Ferrara nello stato della Chiesa. Indisse il Giubileo del 1600. E’ sepolto in Santa Maria Maggiore.
[2] Martino Longhi il Vecchio. (Viggiù 1534 – Roma 1591, architetto papale e capostipite di una famiglia di architetti alla quale appartennero il figlio Onorio e il nipote Martino. Progettò San Girolamo degli Schiavoni, Santa Maria della Consolazione, palazzo Altemps, il cortile di palazzo Borghese e la torre campanaria di palazzo Senatorio al Campidoglio.
[3] Sermoneta. Girolamo Sciolante (Sermoneta 1521-1580 circa) pittore manierista attivo a Roma, collaboratore di Perin del Vaga. Sue opere a San Luigi dei Francesi, a San Giovanni in Laterano, dipinse la scala regia al Quirinale, ancora nella chiesa dell’Ara Coeli e Santa Maria in Monserrato.
[4] Crypta Balbi. Era un isolato del centro storico di Roma dove sorgeva un vasto portico annesso al teatro di Lucio Cornelio Balbo del 13 a.C.
[5] Virginio Vespignani. (Roma 1808-1882) Architetto collaboratore di Poletti è stato molto attivo durante il pontificato di Pio IX soprattutto in opere di restauro essendo di formazione accademica. Sua la cappella della Madonna dell'Archetto nel rione Trevi (1851), il quadriportico del Verano, i restauri a porta San Pancrazio e Porta Pia (facciata esterna).
[6] Guido Reni. (Bologna 1575-1642) pittore e incisore, si accostò ventenne all'Accademia dei Carracci. Sue opere nei principali musei del mondo. San Michele Arcangelo nella chiesa romana di Santa Maria della Concezione, il Suicidio di Cleopatra nella pinacoteca Capitolina, Atalanta e Ippomene al museo di Capodimonte a Napoli (1615-20) che è considerato il suo capolavoro, l'Aurora al palazzo Rospigliosi di Roma. Una sala gli è dedicata al museo Nazionale d'Arte Antica a palazzo Barberini: Santa Maria Maddalena Penitente e Beatrice Cenci. Nella chiesa della Trinità dei Pellegrini al rione Regola sull'altare maggiore "La Trinità" grande pala realizzata in soli 27 giorni su commissione di Ludovico Ludovisi.
[7] Caravaggio. Michelangelo Merisi detto il (Milano 1571 – Porto Ercole 1610). Tra i suoi capolavori: Canestro di frutta, Milano, Pinacoteca Ambrosiana; Cena di Emmaus, Milano, Brera; Vocazione di San Matteo, Cappella Contarelli, San Luigi de Francesi, Roma; Crocifissione di San Pietro, 1600-01, Cappella Cerasi, S. Maria del Popolo, Roma. Da: Enciclopedia dell’Arte Garzanti, 2002. Sue tele a palazzo Barberini: Giuditta e Oloferne, San Francesco in Meditazione.
[8] Clemente VII. Giulio de Medici (Firenze 1478 – Roma 1534). Papa dal 1523. Parteggiò per Francesco I di Francia e dovette subire il sacco di Roma del 1527. Si riavvicinò a Carlo V, lo incornò imperatore a Bologna ed ottenne di restaurare i Medici a Firenze. Rifiutò di sciogliere il matrimonio di Enrico VIII provocando lo scisma della chiesa anglicana.
[9] Clemente IX. Giulio Rospigliosi (Pistoia 1600 – Roma 1669), papa dal 1667. Collaborò alla pace di Aquisgrana, riuscì a comporre temporaneamente il dissidio con i giansenisti.
[10] Foto ponte Sant’Angelo. In Roma ieri, oggi e domani, n. 44 pag. 77, foto in cui si vedono i muraglioni in costruzione.
[11] Camuccini Alla Gnam “La morte di Cesare”.
Pagina 2 di 2