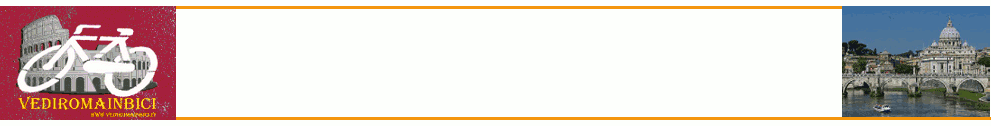Foto e Schede 2017
VIA CRISTOFORO COLOMBO
LA STRADA PIU’ LUNGA DI ROMA
TUTTA FIANCHEGGIATA DA PISTA CICLABILE
DALLE TRE FONTANE
ALLE MURA AURELIANE
La via Cristoforo Colombo collega la città con il mare, nel quartiere marino di Castel Fusano. E’ la strada più lunga (Km 28) e più larga di Roma (quattro corsie più corsia per la sosta di emergenza, più due complanari a due corsie con sosta di emergenza). Venne progettata nel 1937 per collegare la città con l’E42 il quartiere espositivo oggi Eur, per poi proseguire fino al mare. La strada doveva chiamarsi via Imperiale e contribuire all’espansione di Roma verso il mare. Venne costruita tra il 1952 e il 1954. E’ tutta alberata con pini domestici. Tutto il suo percorso ricade nell’ VIII Municipio (Ostiense – Garbatella), IX (Eur – Torrino – Laurentino) e X (Ostia).
ABBAZIA DELLE TRE FONTANE
Sorge nel luogo dove, secondo la tradizione, l’apostolo Paolo subì il martirio della decapitazione. La leggenda narra che la testa, cadendo a terra, rimbalzò tre volte, lì scaturirono tre fonti. Presto vennero costruite tre chiesette, ma il luogo venne abbandonato perché malarico. Dal 1868 il terreno è proprietà dei frati trappisti che l’hanno bonificato e vi hanno piantato gli eucalipti, i primi di Roma, dai quali distillano il noto liquore. Il complesso comprende il monastero cistercense, il secondo in Italia dopo quello di Chiaravalle a Milano.
Si entra in un portale, detto arco di Carlo Magno, preceduto da pronao del sec. VIII, avanzo di antico oratorio di San Giovanni Battista, con sculture bizantine e avanzi di affreschi del sec. IX. Una lapide ricorda che in questo luogo furono nascoste alcune famiglie di ebrei negli anni dell’ultima guerra.
In fondo al piazzale è la chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio, la più grande delle tre, fondata da Onorio I[1] nel 625 per accogliere le reliquie di Sant’Anastasio (dall’VIII secolo anche quelle di Vincenzo) e rifatta da Onorio III nel 1221 e restaurata alla fine dell’Ottocento. Facciata alta in cotto a doppio spiovente con finestre centinate e a strombatura che circondano un rosone ad archetti. Sotto il portico con colonne ioniche di spoglio e architravato, resti di affreschi del XIII secolo. Interno spazioso e severo, tre navate su pilastri, resti di affreschi del Cinquecento.
Sul lato sinistro della chiesa si dispongono gli edifici monastici dai quali si accede al chiostro (non visitabile), il piu antico cistercense superstite a Roma, originale nei lati Nord ed Est.
Sulla destra del piazzale, sopra un rialzo di terreno, è la chiesa di Santa Maria Scala Coeli, opera di Giacomo Della Porta[2] (1583), così detta per una visione di San Bernardo avvenuta in questo luogo. Sorge sul luogo dove subirono il martirio, sotto Diocleziano, San Zenone e i suoi 10.203 legionari cristiani. E’ a pianta ottagonale con cupola, cappelle laterali e abside, in questa “Santi con papa Clemente VIII[3] e suo nipote Aldobrandini”, mosaico di Francesco Zucchi su disegno di Giovanni de’ Vecchi. Nel sotterraneo bel pavimento cosmatesco del secolo XII.
Dal piazzale parte un viale che conduce alla chiesa di San Paolo alle Tre Fontane, eretta nel secolo V sul luogo del martirio dell’apostolo, rifatta nel 1599 da Giacomo della Porta. Nell’interno tre nicchie con le leggendarie fontane miracolose e tre teste del Santo in rilevo (l’acqua non scorre più dal 1950). Nel pavimento bellissimo mosaico romano policromo con le personificazioni delle quattro stagioni, proveniente da Ostia. Nell’anngolo destro si trova la colonna a cui sarebbe stato legato San Paolo per subire il martirio. Nella cappella di sinistra era la Crocifissione di Guido Reni, trasferita a Parigi dai francesi nel 1797. Quando fu recuperata fu portata nella Pinacoteca Vaticana, quella attuale è una copia.
Da facebook:
scitto da Massimo Consentino
OGGi ho fatto una visita ad un posto che vidi alcuni anni fa con una dolcissima amica. L'abbazia delle 3 fontane luogo del martirio dell'aposolo paolo . Gia l'ingresso da la sensazione di uscire dal tempo ove troneggia la statua del fondatore e il motto ora et labora. Si arriva all'arco di carlo magno dell xii secolo . Poco dopo c'e' la chiesa dei ss vincenzo e anastasio sull'architrave del portico d'ingresso indica l,.anno della costruzione 1140 e la scritta della fine dello scisma di anacleto ii. Si arriva alla chiesa di s naria scala coeli dove s bernardo ebbe la visione delle anime dei legionari uccisi perche' cristiani e li sepolti, che salivano al cielo nella cripta c'e' il luogo dell'ulltima detenzione di paolo infine ultime 2 foto la chiesa costruita sul luogo dell'esecuzione e la colonna dove venne legato. Andate a visitarlo perche oltre alla storia e' un0posto che invita al raccoglimento e alla preghiera a pochi metri da una comunita di monaci di strettissima clausura. ciao alla prossima
PIAZZALE CADUTI DELLA MONTAGNOLA
Un piccolo monumento con colonna romana nel piazzale tenuto a giardino è dedicato a quanti combatterono nella difesa di Roma dall'invasione tedesca nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre. Recentemente la piazza è stata riqualificata e vi si trova un antimonumento, una lastra di marmo nella quale sono i nomi dei caduti, uomini e donne, militari e civili. Sulla piazza si trova la chiesa di Gesù Buon Pastore (consacrata il 18 marzo 1959) con una cripta votiva dedicata ai 53 caduti del 9-10 settembre 1943. Quattro altorilievi o murales ricordano: il bombardamento di San Lorenzo del 19 luglio 1943, la battaglia di Forte Ostiense, la battaglia della Montagnola e le Fosse Ardeatine (24 marzo 1944).
I combattimenti in questo luogo, come al ponte della Magliana, a forte Ostiense, volevano rallentare la marcia dei paracadutisti tedeschi, che percorrevano la via Laurentina, verso la città. Una volta superato questo punto, altri combattimenti si svolsero a porta San Paolo che divenne il simbolo della Resistenza romana.
SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI
Il santuario fu consacrato l’8 dicembre 1954, in quello che fu dichiarato anno Mariano.Il santuario costituisce il centro di un complesso detto Città di Maria, formato da edifici della Casa Centrale della Pia Società di San Paolo, dedita ai mezzi di comunicazione e che promuove una valida casa editrice e prodotti cinematografici e audiovisivi. La Pia Società di San Paolo fu fondata da don Alberione nel 1914. Don Giaccardo Alberione, nel 1943, mentre si recava alla casa delle suore fosse sfiorato da una bomba, allora promise di erigere un santuario alla Vergine Maria là dove la bomba era esplosa. Già nel 1945 si gettarono le fondamenta, nel 1951 veniva celebrata la prima messa natalizia. Il ricordo del voto di don Alberione è inscritto nel pavimento della chiesa. Una festa anima il quartiere nell’ultima domenica di maggio.
Il santuario è stato progettato dall’arch. Giuseppe Forneris. E’ a pianta centrale, preceduto sulla fronte da alti pilastri e sormontato da una cupola, il cui tamburo e la cui lanterna sono scanditi da una serie di alte e rettinee finestre. All’interno è l’affresco della Regina Apostolorum seduta tra i dodici apostoli mentre lo Spirito Santo scende su tutti, è opera di A. G. Santagata. Gli affreschi del Santagata si estendono con altre immagini mariane per una superficei di ben 1.200 mq. Importante è la campana della chiesa fusa dalle fonderie Marinelli di Agnone, recante gli emblemi delle attività paoline nella stampa, cinema, radio e televisione e ornata dai simboli delle nazioni dove le case paoline sono presenti.
Da via Vedana si torna alla via C. Colombo, si attraversa il parco Falcone e Borsellino, di fronte il parco Giancarlo Sbragia, a questi segue il parco della Solidarietà (solo sulla destra della strada), ancora avanti si scorge sulla destra il vasto CENTRO DIREZIONALE di piazzale Caravaggio, di Pietro Barucci del 1963-68, composto di quattro edifici per attività terziarie che costituiscono l’unica attuazione del progettato Sistema Direzionale Orientale previsto dal piano regolatore del 1962. Sul lato opposto inizia viale Giustiniano Imperatore con case popolari di recente edificazione (vedere il testo “Ostiense”).
EX FIERA DI ROMA
Il 5 giugno del 1948 nasce la Fiera di Roma con la sua prima esposizione, su un’area di ha 7,6; ma la costituzione della manifestazione come Ente Fiera si ha nel 1951, nel 1955 ottiene il riconoscimento della personalità giuridica come Ente Morale, con decreto del Presidente della Repubblica.
Nel 1970 viene costruito il palazzo dei Convegni con altri impianti . Nel 1982 l’Ente viene collocato giuridicamenete nel contesto della regione Lazio che ne assume il controllo, diventa fiera internazionale, vengono creati nuovi padiglioni per 15.000 mq di superficie coperta. L’anno successivo viene ampliato il palafiera. Nel 1995 l’ente diventa Società per Azioni, e tre anni dopo nasce la Fiera di Roma Spa, operativa dal 1° gennaio 2000.
Dal 21 aprile 2004 cominciano i lavori per la realizzazione della nuova struttura sulla Roma-Fiumicino all’altezza di Ponte Galeria, il progetto si deve allo studio Valle, viene inaugurata il 21 aprile 2008, il 22 settembre la prima manifestazione: Orocapital.
Nei padiglioni della ex Fiera di Roma c’era il Museo dell’Energia Elettrica costruito dall’Enel nel 1988 per il 25° dell’ente. Oggi vi è allestito il Museo delle Auto della Polizia di Stato. Per le elezioni comunali del 2016, una parte dei padiglioni sono utilizzati come ufficio elettorale del Comune di Roma, qui sono confluiti i registri e le urne contenenti le schede di tutte le sezioni elettorali della città.
Nel luglio del 2014 la giunta comunale approva, su proposta dell’assessore Caudo, un progetto di riqualificazione dell’area che prevede un grande edificio per tutti gli uffici dell’Onu a Roma. Sui 7,6 ettari aree verdi, pista ciclabile, residenze fino all’80% di cui 20% di edilizia sovvenzionata. Con la caduta della giunta Marino tutto torna in discussione.
Il 15.11.17 i giornali informano che l’ex Fiera di Roma sarà venduta per risanare i debiti della nuova Fiera di Roma. Ora manca il si della Regione per il cambiamento della destinazione d’uso dei vecchi capannoni. Diventeranno case. La vendità servirà per saldare i debiti della Nuova Fiera di Roma. Investimenti Spa di Comune Regione e Camera di Commercio ricorrerà al Piano Casa per costruire un 30% in più di quanto deciso dalla giunta Raggi. Il debito della Fiera di Roma con Unicredit è di 180 milioni. La Raggi ha tagliato le cubature del 35% e così dalla vendita invece di guadagnare 130 milioni se ne guadagnareranno 85.
Di fronte alla ex Fiera di Roma si vede un massiccio fabbricato costruito come albergo di massa in vista del Giubileo del 1950.
PIAZZA DEI NAVIGATORI
La strada prosegue in leggera salita fino al PALAZZO DELLA REGIONE LAZIO, già palazzo INAM, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie. Si trattava di un ente pubblico al quale era affidata la gestione dell’assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti privati e delle loro famiglie in malattia. Istituito nel 1943 è stato sciolto nel 1977 con la nascita del Servizio Sanitario Nazionale, da allora i contributi obbligatori pagati dai lavoratori sono gestiti dall’INPS. Il palazzo è stato il set del primo film della serie Fantozzi. A destra viale di Tor Marancia porta nell’omonimo quartiere popolare arricchito di splendidi murales nel 2015 (vedi testo sul quartiere Ardeatino). A sinistra via Genocchi porta al quartiere della Garbatella (vedi apposito testo word).
PIAZZA dei NAVIGATORI è chiusa sul lato Nord da un palazzo porticato di grandi dimensioni che, per essere stato costruito in un punto alto si vede da diversi punti della Caffarella e della città. Tale edificio venne costruito nel 1947 come alloggio per i pellegrini dell’Anno Santo e adibiti poi a case popolari[4]. Sul lato Sud si nota un edificio vetrato international style per uffici, la sua costruzione è terminata nel 2012 ma è solo in parte utilizzato. Al centro della piazza si trovano alcune sculture di arte contemporanea collocate nel 1990.
Riprendiamo la Colombo, ora la strada è in discesa, sulla sinistra, tra la via e la sua complanare ecco i resti di una CISTERNA ROMANA, si tratta di due cisterne, una addossata all’altra, la prima in laterizio, la seconda in opus reticolatum, avanzi di una villa romana del I – II secolo. Sempre sulla sinistra, al civico 90, un palazzo con pareti vetrate e bronzate è la sede delle redazioni dei giornali del gruppo l’Espresso, quindi anche de “la Repubblica”.
CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE
La discesa termina all’incrocio con circonvallazione Ostiense, sulla destra si trova un sentiero che raggiunge la via Appia Antica attraversando anche un parco pubblico. L’incrocio ha il nome di largo Angelo Fochetti, ma nessuno se ne accorge perché la piazza non esiste, è solo un incrocio con una scultura di arte astratta collocata nel 1990. In questo punto passava il fiume Almone prima che venisse intubato.
Poco oltre si vedono a sinistra degli edifici per abitazione costruiti nel 2012 con un parco (giardino Lanzarotto Maloncello, per google.maps) a loro riservato e splendido ponte pedonale in legno. La strada prosegue in leggera salita, scavalca la ferrovia Roma – Fiumicino e Roma – Civitavecchia. Subito dopo incrocia una grande arteria di veloce scorrimento via Marco Polo – via Cilicia. Arrivati alle mura, ecco a destra la villa Almone, una delle sede della Repubblica Federale di Germania.
MURA AURELIANE
Le mura Aureliane rappresentano la più colossale costruzione dell’Italia antica. Si tratta delle mura più estese d’Europa. Le mura Aureliane furono costruite dall'imperatore romano Aureliano tra il 271 e il 273. Dopo aver subito numerose ristrutturazioni oggi si presentano in un buon stato di conservazione come poche città italiane possono vantare, ad esempio a Firenze le mura furono demolite con l'Unità d'Italia, restano solo alcune porte. Oggi sono lunghe Km 12,5.
Nel 260 gli Alemanni erano riusciti ad arrivare fino a Roma ma rinunciarono a saccheggiarla, nel 270 l'imperatore Aureliano riuscì ad arrestare gli Alemanni e i Goti presso Piacenza, non senza difficoltà. Ci si rese conto allora della necessità di proteggere la città con delle mura poichè lo Stato versava in una situazione di profonda crisi. La costruzione delle mura iniziò nel 271 e ci vollero due anni di lavori, ma il completamento avvenne solo nel 280 con l'imperatore Probo. Il progetto era improntato alla massima velocità di realizzazione e semplicità strutturale. Certamente gli esperti militari ebbero un ruolo fondamentale nella realizzazione delle mura. A Massenzio si devono alcuni interventi di rinforzo delle mura e alla costruzione di un fossato che però fu concluso da Costantino.
Il tracciato seguiva in buona parte gli uffici di dogana che si trovavano lungo le vie di accesso alla città, si trattava di una linea immaginaria fissata nel 175. Per una maggiore velocità di esecuzione dell'opera diverse costruzioni preesistenti vennero incluse nei 19 Km di perimetro, fra queste: il Castro Pretorio, l'Anfiteatro Castrense e la Piramide Cestia. Inoltri diversi tratti degli acquedotti vennero inglobati nelle mura.
Le mura di Roma erano alte dai 6 agli 8 metri, più due metri di fondazione, avevano uno spessore di m 3,30. Per risparmiare le spese di esproprio il 40% del perimetro venne fatto passare su terreno demaniale. Ogni 30 metri vi era una torre, in tutto erano 381, avevano pianta rettangolare (ai lati delle porte erano cilindriche, si discute se questa fosse una innovazione di Onorio!). Nelle mura si aprivano 14 porte oltre a diversi passaggi secondari. Sul cammino di ronda esistevano 116 servizi igienici.
Una delle maggiori preoccupazioni dei romani era la necessità di rifornimento idrico, per questo le mura si spinsero al di là del Tevere a comprendere l'attuale rione Trastevere e il Gianicolo. Nel V secolo si presentò la minaccia dei Goti di Alarico. L'imperatore Onorio, o meglio il suo generale Stilicone, in un paio d'anni intorno al 403 raddoppiò l'altezza delle mura, dai 6 - 8 metri si passò ad almeno 10,5 -15, venne creato un doppio camminamento, uno inferiore coperto (era il primo camminamento di ronda) ed uno superiore, scoperto e con la merlatura. Il mausoleo di Adriano venne inglobato nel percorso delle mura ed anche l'area del colle Vaticano venne circondata da mura. Nonostante questi lavori il 24 agosto del 410 i Goti di Alarico entrarono a Roma per la porta Salaria e la saccheggiarono. Gli Unni di Attila vennero fermati "più o meno miracolosamente" da Leone il Grande, preoccuparono di più i Vandali di Genserico che nel 455 riuscirono ad entrare a Roma per porta Ostiense e Portuense e la saccheggiarono per la seconda volta. La città era stremata da una pestilenza del 442 e da un terremoto del 443. Alla fine del secolo il re Ostrogoto Teodorico restaurò le mura di Roma dopo che si era impadronito di tutta l'Italia (tolta ad Odoacre re degli Eruli). Le mura ressero all'assedio di Vitige nel 538, questa volta la città era difesa da Belisario, generale dell'imperatore d'Oriente Giustiniano. Quarant'anni dopo ci fu il ventennale assedio dei longobardi ad una città ridotta a poche migliaia di abitanti.
Il potere politico passò alla Chiesa cattolica, fu la volta di papa Pio IV a restaurare le mura nella seconda metà del Cinquecento, l'intervento comprese anche una nuova edificazione di mura al posto delle mura Leonine (volute da papa Leone IV) intorno alla basilica di San Pietro. Nel Cinquecento vennero eretti i bastioni da Antonio da Sangallo il Giovane tra porta San Sebastiano e porta del Popolo, nel Seicento vennero erette le mura Gianicolensi (Urbano VIII). Le mura restarono nella loro funzione difensiva fino al 20 settembre 1870 quando con la presa di porta Pia venne posta la fine del potere temporale dei papi e Roma divenne la capitale d'Italia. Proprio il continuo uso militare delle mura ne ha permesso il buono stato di conservazione.
In vista dell'Anno Santo del 2000 il Comune di Roma ha speso 30 miliardi di lire per il restauro dell'intero perimetro, nonostante ciò nella Pasqua del 2001 (15 aprile) è crollato un tratto di 20 metri in via di Porta Ardeatina, mentre il 1° novembre 2007 è crollato un altro tratto di 10 metri in viale Pretoriano al quartiere San Lorenzo. Il CNR e l'Università di Tor Vergata hanno iniziato un lavoro di TAC per monitorare la manutenzione di tutta la struttura. Nella zona di porta Pinciana e porta Tiburtina vi sono ancora abitazioni private.
Un museo delle Mura è allestito all'interno di porta San Sebastiano, dove è anche possibile percorrere un tratto del camminamento coperto. Un altro tratto è stato reso agibile sopra porta Asinaria, se ne attende l'apertura al pubblico.
VILLA OSIO
Viale di Porta Ardeatina 55. Inaugurata nel 2005, fortemente voluta dal sindaco Walter Veltroni. Si tratta della villa Osio della fine degli anni Trenta, voluta dal fondatore della BNL Arturo Osio, che diede incarico all'arch. Cesare Pascoletti[5] di modificare e adattare un casale seicentesco. La villa passò, dopo molti anni, ad Enrico Nicoletti (detto "Il secco", negli anni Settanta collaborò con Enrico De Pedis detto Renatino sepolto in Sant'Apollinare per molti anni, poi riesumato; nuovamente arrestato il 26 febbraio 2012 deve scontare una condanna a 6 anni e 6 mesi per usura, estorsione e rapine, da la Repubblica e Il fatto quotidiano) cassiere della banda della Magliana. La villa aveva marmi, stucchi, vasca idromassaggio a due posti, rubinetti d'oro. Le forze dell'ordine riuscirono a arrestare i componenti della banda e la villa venne prima sequestrata e consegnata al comune di Roma nel 2001 che la destinò a sede della casa del jazz. Per questo motivo all'entrata della villa si trova una lapide che ricorda i caduti a causa della mafia. La villa venne restaurata a partire dal 5 novembre 2003 con una spesa di 6 milioni di euro ed inaugurata il 21 aprile 2005 con tre giorni di concerti gratuiti. Il parco di tre ettari venne aperto al pubblico esattamente un anno dopo l'inaugurazione. Solo nel primo anno di vita si sono tenuti 150 concerti con 500 musicisti e 70.000 spettatori (tutti i dati da la cronaca di Roma de la Repubblica).
La villa contiene, nell'edificio principale, un auditorium da 150 posti dove si tengono concerti dal vivo, proiezioni di film e incontri. Nello stesso edificio si trova un sofisticato impianto di registrazione, un archivio audiovisivo e una biblioteca dedicata alla musica jazz. Un secondo edificio nella villa è riservata alle sale di prova e registrazione oltre che a foresteria per gli artisti provenienti da fuori Roma. Un terzo edificio è adibito a ristorante
[1] Onorio III E’ il papa che nel 1220 incorona imperatore Federico II. Nel 1223 approva la regola francescana, nel 1216 aveva approvato la regola domenicana. Invece Onorio I è stato papa dal 625 al 638, un mosaico lo raffigura nella basilica di Sant’Agnese fuori le mura. Diede impulso a campagne missionarie nelle isole Britanniche. Con lui la Curia divenne chiesa di Sant’Adriano.
[2] Giacomo della Porta (Genova 1533 - Roma 1602), architetto e scultore, allievo e aiuto del Vignola, costruì la chiesa del Gesù a Roma, la chiesa di Santa Maria ai Monti, la fontana di piazza Colonna, la fontana del Tritone, la fontana delle Tartarughe in piazza Mattei, le fontane minori in piazza Navona. E’ passato alla storia per aver realizzato la cupola di Michelangelo in San Pietro dopo la morte del grande artista, la facciata di palazzo Altemps.
[3] Clemente VIII Giulio di Giuliano dei Medici, papa dal 1523 al 1534. Figlio naturale, poi legittimato, di Giuliano de Medici ucciso nella congiura de Pazzi un mese prima della sua nascita e di una certa Fioretta. Fu affidato dallo zio Lorenzo il Magnifico alle cure di Antonio da Sangallo, poi lo zio lo prese sotto la sua protezione. Nel 1488 riuscì a convincere Ferdinando I d'Aragona a concedergli il priorato di Capua dell'Ordini di San Giovanni di Gerusalemme, beneficio prestigioso e molto remunerativo. E' il Papa del Sacco di Roma dei Lanzichenecchi del 1527 (inizio assedio 5 maggio, il giorno successivo i Lanzichenecchi entrarono in Borgo e Trastevere). E' anche il Papa dello scisma anglicano.
[4] Piazza dei Navigatori. La notizia delle case Iacp costruite per l’anno santo del 1950 proviene dalla Guida di Roma del Tci del 1993, pag. 779.
[5] Cesare Pascoletti (1898 - 1986) allievo di Marcello Piacentini. Progettò la palazzina per funzionari della BNL in via Bruxelles 20 nel 1936, il Palazzo per il Museo della Civiltà Romana all'Eur con Aschieri e Bernardini nel 1939-41, il ponte di Testaccio nel 1940, il palazzo per uffici della BNL in viale Regina Margherita nel 1940-45, la sede della BNL in piazza Albania nel 1954. Da: Irene de Guttry e Publio Ostilio Rossi, cit.
DONATO BRAMANTE
Donato “Donnino” di Angelo di Pascuccio detto Bramante (Fermignano[1] 1444 - Roma 1514) è stato un architetto e pittore italiano tra i maggiori del Rinascimento. Formatosi a Urbino, dove fu probabilmente allievo e aiutante di Piero della Francesca e dove conobbe Melozzo da Forlì. Urbino era tra i maggiori centri della cultura italiana del XV secolo. Fu attivo prima a Milano dove realizzò l’abside di Santa Maria presso San Satiro, il cortile della basilica di Sant’Ambrogio, la tribuna di Santa Maria delle Grazie[2], come pittore realizzo il “Cristo alla colonna” oggi a Brera (lavorò anche a Pavia e Vigevano). Quindi a Roma dove – per ordine di papa Giulio II - progettò la basilica di San Pietro, a pianta centrale; di tale progetto furono realizzati i quattro pilastri su cui poggia la cupola michelangiolesca. Per realizzare tale progetto Bramante demolì abside e transetto dell’antica basilica e perciò fu definito “maestro ruinante”. I contemporanei paragonarono la sua opera a quella delle vestigia romane.
ITINERARIO
PALAZZO DEI CONVERTENDI
Si trova in via della Conciliazione, dopo palazzo Torlonia (di fronte al palazzo dei Penitenzieri, oggi hotel Columbus). Il palazzo, in origine su piazza Scossacavalli[3], fu demolito e ricostruito lungo il lato Nord di via della Conciliazione. Il palazzo progettato da Donato Bramante per la famiglia Caprini di Viterbo, ancora incompiuto venne venduto a Raffaello per 3.000 ducati, qui il pittore vi trascorse gli ultimi 3 anni della sua breve vita, qui dipinse la Trasfigurazione, ultima opera del grande artista, rimasta incompiuta per la sua morte (poi completata da Giulio Romano). Passò varie proprietà finchè divenne la sede dell’ospizio dei Convertendi, istituzione dedicata alla protezione dei protestanti che volevano convertirsi alla fede cattolica. Il palazzo dipendeva direttamente dal Papa. Danneggiato da una alluvione fu restaurato da Gregorio XVI (1831-46).
Il palazzo attuale ha due piani con un portale bugnato sormontato da un balcone del Peruzzi. L’edificio riceve la luce da finestre quadrate al piano terra, centinate e bugnate al piano nobile e rettangolari al secondo piano. Il tetto è concluso da un cornicione aggettante. Nell’androne è stata murata l’iscrizione: “Qui morì Raffaello Sansio il 6 aprile 1520”.
Al primo piano è esposta una collezione di 120 dipinti russi di soggetto religioso, perché papa Benedetto XV, nel 1917, assegnò il palazzo alla appena fondata Congregazione per le chiese orientali.
SAN PIETRO IN MONTORIO
Si trova sul Gianicolo in uno dei punti panoramici più belli di Roma. Commissionato dal re di Spagna, è un tempietto di piccole dimensioni ripreso dai templi peripteri[4] circolari e monumentali romani. Ha un corpo cilindrico, scavato da nicchie di alleggerimento e circondato da un colonnato dorico sopra al quale corre una trabeazione decorata con triglifi[5] e metope[6] a tema liturgico. La muratura della cella è scandita da paraste come proiezione delle colonne. La colonna dorica è posta su una base, come per i romani, mentre per i greci poggiava direttamente sul pavimento.
L’interno ha un diametro di circa 4 metri e mezzo, non c’è spazio per le celebrazioni liturgiche, venne costruito quindi con funzione celebrativa del martirio di San Pietro (crocifissione).
La cupola, realizzata in conglomerato cementizio, ha un raggio d’azione pari alla sua altezza e, all’altezza del tamburo su cui si appoggia, in questo ha un chiaro riferimento con il Pantheon.
La vicina chiesa si deve a Baccio Pontelli (ma per il Vasari a Meo del Caprino) su finanziamento spagnolo (Ferdinando II e Isabella di Castiglia). La chiesa subì danni durante la difesa della Repubblica Romana (1849). Attualmente è una chiesa molto usata per i matrimoni. Sotto l’altare maggiore era sepolta Beatrice Cenci, al di sopra si trovava la Trasfigurazione di Raffaello. La chiesa è ricoperta di affreschi del Cinque e Seicento. Notare la seconda cappella a sinistra (cappella Raimondi) del Bernini e la seconda cappella a destra con un affresco del Pomarancio, affreschi del Pinturicchio e una sibilla attribuita a Baldassarre Peruzzi.
FONTANA DI SANTA MARIA IN TRASTEVERE
Si trova nella piazza omonima che è il cuore di Trastevere. La fontana è opera di Donato Bramante con successivi interventi di Gian Lorenzo Bernini e Carlo Fontana, su preesistente opera forse di epoca imperiale.
Si ritiene che sia la più antica fontana di Roma ancora funzionante, sembra che una fontana in questo luogo ci fosse già in età augustea, era alimentata dall’Acqua Alsietina[7], non potabile, alimentava la naumachia in zona e veniva utilizzata per scopi agricoli. Forse papa Adriano nell’VIII secolo, restaurò la fontana, ma non abbiamo notizie certe. Mentre nel 1450, papa Niccolò V, in occasione del Giubileo fece edificare una vasca quadrata, posta su gradini, al centro della quale su un piedistallo con balaustri, erano due catini circolari.
Tra il 1496 e il 1501 interviene Bramante che aggiunse al catino superiore degli ornamenti a forma di testa di lupo da cui cadeva l’acqua. Alla fine del Cinquecento interviene Giovanni Fontana[8] che cambiò la forma della vasca da quadrata a ottagonale.
La realizzazione dell’acqua Paola, sul vecchio tracciato dell’acquedotto di Traiano, comportò maggior afflusso d’acqua e la collocazione della fontana nel luogo attuale, al centro della piazza. Nel 1658 Bernini la alzò su gradini e vi pose conchiglie sui lati alterni. Un altro intervento è di Carlo Fontana[9], nel 1694, che ampliò la capienza della vasca realizzandola in travertino. Nel 1873 il Comune rifece la vasca principale in marmo bardiglio e pone la scitta SPQR all’esterno delle conchiglie. Un ultimo intervento di restauro nel 1984.
Volgiamo lo sguardo alla chiesa di Santa Maria in Trastevere, ci troviamo di fronte a uno dei gioielli medioevali di Roma. Secondo la tradizione è la prima chiesa di Roma aperta ufficialmente al culto. Fondata nel IV secolo da papa Giulio I (337-352) fu anche la prima chiesa dedicata a Maria nella città. I mosaici dell’abside con l’incoronazione della Vergine furono realizzati nel 1143, le storie della Vergine – invece – sono di Pietro Cavallini (1290). Questi mosaici documentano il graduale passaggio dall’elegante ma immobile linguaggio bizantino, a composizioni tridimensionali in cui figure e architetture acquistano sempre maggiore spessore. Non si può ancora parlare di prospettiva, ma è evidente una nuova concezione dello spazio. Siamo ormai prossimi alla rivoluzione di Giotto.
Approfittiamo della visita alla chiesa per andarne a scoprire altri capolavori. Notiamo il ricchissimo soffitto ligneo a lacunari del Domenichino (1617). All’inizio della navata centrale, sulla destra ecco il tabernacolo marmoreo firmato Mino del Reame con fine bassorilievo prospettico (sec. XV). Nel transetto destro si trova la cappella del Coro d’Inverno realizzata su progetto del Domenichino (1625), sull’altare Madonna di Strada Cupa, attribuita a Perin del Vaga, a sinistra Fuga in Egitto di Carlo Maratta. A sinistra dell’abside, in continuità prospettica con la navata sinistra si trova la cappella Altemps eretta per il cardinale Marco Sitticio Altemps, nipote di Pio IV, da Martino Longhi il Vecchio (1584-85); all’altare è la celebre Madonna della Clemenza”, preziosa tavola a encausto, opera romana del VI – VII secolo.
CHIOSTRO DI SANTA MARIA DELLA PACE
E’ molto probabile che sia una delle prime opere di Bramante a Roma, fu progettata nel 1500, su commissione di Oliviero Carafa. Presenta un linguaggio severo e privo di decorazioni, in questo si distacca dal periodo milanese nel quale realizzava opere con un ricco repertorio decorativo. Lo spazio è circondato da 16 pilastri che formano un portico continuo di volte a crociera.
Il chiostro su pianta quadrata è realizzato utilizzando elementi architettonici e compositivi ripresi dall’architettura romana. Il primo ordine presenta archi a tutto sesto poggianti su pilastri ed inquadrati da paraste e dalla soprastante trabeazione. L’ordine superiore è innovativo per il mancato uso di strutture ad arco: è formato da pilastrini e colonne alternati che sostengono la trabeazione. Sono dorici i pilastri del piano terreno, ionici le paraste, composito il loggiato superiore, come avviene nel Colosseo.
La chiesa di Santa Maria della Pace fu eretta per un voto di papa Sisto IV[10] e dedicata a Maria per ricordare un evento miracoloso per cui un'immagine della Madonna avrebbe sanguinato a lungo. Il papa chiese alla Madonna che la congiura dei Pazzi non portasse ad una guerra. Accolto il desiderio affidò il progetto a Baccio Pontelli[11]. E' formata dall'unione di due organismi, un'aula rettangolare nella parte anteriore, seguita da un ottagono a cupola, aggiunto forse dal Bramante[12]. Nella seconda metà del Seicento papa Alessandro VII fece restaurare la chiesa da Pietro da Cortona[13] che vi aggiunse la facciata barocca che si spinge in avanti tra le ali concave, voleva simulare un palcoscenico teatrale. La facciata è preceduta da un pronao semi circolare sostenuto da colonne tuscaniche binate. Si tratta di una delle principali realizzazioni del barocco romano.
Sull'altare maggiore Carlo Maderno[14] pose il venerabile dipinto della Madonna col Bambino. La prima cappella a destra, detta Chigi è attribuita a Raffaello che eseguì anche l'affresco sull'arcone delle Sibille e Angeli nel 1514. Gli affreschi superiori con i quattro Profeti furono realizzati da Timoteo Viti dopo la morte del maestro su disegno di Raffaello stesso. Sull'altare di questa cappella Cristo trasportato da Angeli di Cosimo Fancelli. La seconda cappella, detta Cesi, fu progettata da Antonio da Sangallo il Giovane ed ha una decorazione rinascimentale sull'arcata esterna di Simone Mosca. La prima cappella sinistra, detta Ponzetti, ha dei notevoli affreschi rinascimentali di Baldassarre Peruzzi Madonna col Bambino e sante Brigida e Caterina con il cardinale Ferdinando Pozzetti 1516. La seconda cappella a sinistra, detta Mignanelli, ha i marmi presi dal Tempio di Giove Capitolino, qui si trova il monumento al vescovo Giovan Andrea Boccaccio opera di Luigi Capponi, scultore lombardo seguace di Andrea Bregno.
La tribuna ottagona ha una serie di cappelle affrescate: da destra Visitazione di Carlo Maratta (1655), Presentazione al tempio di Baldassarre Peruzzi (1524). La prima cappella a destra dell'altare, detta Olgiati, ha un Battesimo di Gesù di Orazio Gentileschi del 1603. La prima cappella a sinistra dell'altare, ha un crocifisso quattrocentesco della scuola di Andrea Bregno.
BIBLIOGRAFIA
- AA.VV. Guida d’Italia, Roma, ed. Tci, 1993.
- AA.VV. Roma, libri per viaggiare, ed. Gallimard – Tci, 1994.
- AA.VV. I rioni e i quartieri di Roma, ed. Newton & Compton, 1989.
- AA.VV. Le strade di Roma, ed. Newton & Compton, 1990.
- Claudio Rendina (a cura di), Enciclopedia di Roma, ed. Newton & Compton, 2005.
- Sabrina Ramacci, 1001 cose da vedere a Roma almeno una volta nella vita, ed. Newton Compton, 09.
- Giorgio Carpaneto, I palazzi di Roma, ed. Newton & Compton, 1991.
- Mariano Armellini, Le chiese di Roma, ed. Pasquino, 1982.
- Carlo Zaccagnini, Le ville di Roma, ed. Newton Compton, 1991.
- Willy Pocino, Le fontane di Roma, Newton & Compton, 1996.
- G.C. Argan, Storia dell'arte italiana, ed. Sansoni, 1975.
- AA.VV. Storia dell'Arte, Istituto Geografico De Agostini,1975.
- AA.VV. Storia Universale dell'Arte, ed. Leonardo,1997.
- Ernest H. Gombrich, La storia dell'arte, ed. Leonardo, 1995.
- AA.VV. L'arte nella storia dell'Uomo, Giunti, 1997.
SITOGRAFIA
www.comune.roma.it
www.archeoroma.beniculturali.it
sovraintendenzaroma.it
www.culturaroma.it
www.romasegreta.it
www.laboratorioroma.it
www.romasparita.eu
www.info.roma.it
www.abcroma.com
www.amicidiroma.it
www.viamichelin.it
Piero Tucci
8.10.17
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
[1] Fermignano. Negli anni di Bramante si chiamava Monte Asdrualdo, ma secondo il Vasari era nato a Casteldurante oggi Urbania.
[2] Santa Maria delle Grazie a Milano. Nel refettorio del convento si trova l’Ultima cena di Leonardo (1495-98).
[3] Piazza Scossacavalli. Al centro della piccola piazza era la fontana che ora si trova davanti alla chiesa di Sant’Andrea della Valle. Opera di Carlo Maderno.
[4] Periptero. E’ un tipo di tempio circondato da un portico a colonne.
[5] Triglifo. E’ una formella in pietra decorata con tre scanalature verticali.
[6] Metopa. Formella di pietra scolpita a rilievo, posta in alternanza con i triglifi.
[7] Acqua Alsietina. Voluta da Augusto nel 2 a.C., proveniva dal lago di Martignano (presso Bracciano).
[8] Giovanni Fontana , fratello maggiore di Domenico (colui che rialzò l'obelisco Vaticano), suo è il progetto per l'acquedotto Felice voluto da Sisto V, la fontana dell'Acqua Paola sul Gianicolo, il fontanone di ponte Sisto in piazza Trilussa e la fontana dell'Acqua Felice in piazza San Bernardo o del Mosè presso la stazione Termini.
[9] Carlo Fontana. (Rancate 1638 - Roma 1714) architetto e scultore italo svizzero è vissuto tra Seicento e Settecento, sua la facciata di San Marcello al Corso, la cappella Albani in San Sebastiano, santa Rita in Campitelli, fontana di sinistra in piazza san Pietro e la fontana in Santa Maria in Trastevere. Sua la cappella Cybo in santa Maria del Popolo.
[10] Sisto IV (Papa dal 1471 al 1484) Francesco Della Rovere, di Pecorile oggi Celle Ligure (Savona). Fece costruire la Cappella Sistina e il ponte Sisto sul Tevere a Roma. Francescano, docente di varie università italiane. Il suo monumento funebre simile ad un cofanetto di arte orafa si trova in San Pietro.
[11] Baccio Pontelli (1450-1495) architetto, soprattutto militare ed ebanista nativo di Firenze. Rocca di Ostia e chiesa di Sant'Aurea, rocca di Senigallia, mura di Jesi, progetto della Cappella Sistina realizzata da Giovannino De Dolci. Chiesa di San Pietro in Montorio. Sue le tarsie nello studiolo di Federico da Montefeltro ad Urbino.
[12] Bramante Donato di Angelo Pascuccio (Fermignano PU 1444 – Roma 1514) pittore e architetto. A Milano: Santa Maria presso San Satiro, Sant’Ambrogio (chiostri e canonica), Santa Maria delle Grazie (tribuna). A Roma: chiesa di Santa Maria della Pace con il chiostro, tempietto di San Pietro in Montorio, palazzo del Belvedere in Vaticano. A Urbino il mausoleo dei Duchi. Ebbe incarico da Giulio II di demolire la antica basilica di San Pietro tanto da guadagnarsi il titolo di "mastro ruinante".
[13] Pietro da Cortona Pietro Berrettini detto (Cortona 1596 - 1669) pittore e architetto, fra i protagonisti del barocco. Elaborò uno stile illusionistico come si vede negli affreschi di palazzo Pitti a Firenze o nel Trionfo della Divina Provvidenza in palazzo Barberini a Roma. In architettura usò un linguaggio scenografico basato sul classicismo cinquecentesco. A Roma eresse la chiesa dei Santi Luca e Martina ai Fori e Santa Maria della Pace. Sua la cupola di San Carlo al Corso.
[14] Carlo Maderno è l’autore della facciata di San Pietro.
LEONI SULLA SCALINATA
DELLA GNAM
Sulla scalinata della Galleria Nazionale a valle Giulia, si trovano cinque leoni (tra cui una leonessa) sono opera dell’artista Davide Rivalta che si è ispirato ai leoni della facciata del palazzo delle Belle Arti opera di Cesare Bazzani del 1911. L’opera è in relazione ai disegni collocati all’interno della galleria nel corridoio di fondo. Il titolo dell’installazione è “Hic sunt leones” come nelle carte geografiche di epoca romana classica indicavano la zona dell’Africa a Sud del deserto del Sahara. Una metafora dei territori inesplorati di tutto ciò che c’è da scoprire dentro e fuori di noi. Davide Rivalta ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Ha realizzato varie sculture di animali afro-asiatici che colloca all’esterno, ha esposto a Arezzo, Torino, Ravenna e altrove. E’ il compagno di Rula Jebrael, giornalista palestinese con passaporto israeliano e italiano, ha lavorato nello staff di Michele Santoro.
SALITA DELL’AVENTINO
Nello scorso luglio è stato riaperto al pubblico il sentiero / scalinata che sale all’Aventino dal lungotevere omonimo al Giardino degli Aranci. Uno dei luoghi più belli di Roma è stato così valorizzato. I lavori sono partiti nel 2011 nel quadro del rafforzamento della rupe. Una passeggiata indimenticabile.
PIE’ DI MARMO
Si trova in via di Santo Stefano del Cacco, è un colossale piede marmoreo proveniente dal Santuario di Iside (dea egizia della maternità e fertilità) e Serapide (dio greco-egizio), venne ritrovato nel XVI secolo, apparteneva a una statua di culto, fu collocato nella via del Pie’ di Marmo dove rimase fino al 1878 quando, in occasione del corteo funebre di re Vittorio Emanuele II diretto al Pantheon, fu spostato nella posizione attuale. E’ stato restaurato il 25 luglio 2011.
La via ha questo nome per il ritrovamento di una statua di macaco, in dialetto deformato in cacco, statuetta del dio Thot nelle sembianze di un babbuino o macaco. Nella strada si trova l’antica chiesa di Santo Stefano del Cacco costuita nel IX secolo da Pasquale II. Alla metà del Seicento l’architetto Paolo Maruscelli le dette l’attuale volto barocco. Della primitiva costruzione è rimasto solo il campanile romanico.
COLONNA DIPINTA IN
SANTA MARIA D’ARA COELI
Nell’antichissima e preziosa chiesa del Campidoglio, l’unica colonna dipinta di Roma, davanti ad essa un piccolo altare, sulla colonna è raffigurata la Madonna con Bambino.
La terza colonna di sinistra, in porfido, presenta un foro non diametrale, aveva probabilmente un uso astronomico. In alto presenta la scritta A CUBICULO AUGUSTORUM., ricorda la tradizione del luogo dell’apparizione della Vergine con Bambino ad Augusto nella sua camera da letto.
Nome originario Santa Maria in Capitolio, ma dal 1323 è attestato il nome attuale per la leggenda che la chiesa sarebbe sorta là dove Augusto avrebbe avuto la visione di Maria che gli diceva: “Questa è l’ara del figlio di Dio”. La chiesa è sorta sulle rovine del tempio di Giunone Moneta (cioè ammonitrice, qui vicino era la zecca, da cui il nome), sull’Arx una delle due alture del Campidoglio. La scalinata venne realizzata per volere del libero comune nel 1348, come voto alla Vergine affichè ponesse fine alla peste che imperversava in tutta Europa e realizzata con marmi provenienti dal tempio di Serapide sul Quirinale. La scalinata fu inaugurata da Cola di Rienzo.
L’interno ha tre navate con archi a tutto sesto. Il soffitto ligneo a cassettoni è del XVI secolo, il pavimento cosmatesco è del XIII secolo. Dietro le ultime colonne a destra e a sinistra sono conservati due bellissimi pergami cosmateschi risalenti al XIII secolo e attribuiti ai Cosmati Lorenzo di Cosma e al figlio Jacomo.
In controfacciata, alla sinistra, monumento funebre del cardianle Ludovico D’Albret, bella opera di Andrea Bregno del 1465. Ancora a sinistra lastra tombale dedicata a Giovanni Crivelli, arcidiacono di Aquileia, scolpita da Donatello.
La prima cappella a destra, di San Bernardino, detta Bufalini, dal nome del committente che volle celebrare la pace con i Baglioni di Perugia, è affrescata dal Pinturicchio con le Storie di San Bernardino da Siena (1485), pavimento cosmatesco ben conservato. Nel transetto di sinistra un tempietto dedicato a Sant’Elena. Il tempietto ricopre un altare medioevale dove, secondo la tradizione Augusto ricette la visione.
Navata sinistra. Terza cappella: Sant’Antonio di Benozzo Gozzoli. Quinta cappella: Storie di San Paolo del Pomarancio.
Transetto sinistro. Tomba del cardinale Matteo d’Acquasparta, ambasciatore di Bonifacio VIII e ministro generale dei Frati Minori. Monumento realizzato da Giovanni di Cosma, affresco “Madonna con Bambino e santi” di Pietro Cavallini.
Transetto destro: Monumento funebre scolpito da Arnolfo di Cambio.
Navata destra. Ultima cappella di San Pasquale Baylon: affresco della Madonna con bambino tra i santi Giovanni Evangelista e Battista (scoperta nel 2000), attribuito agli allievi di Giotto o Pietro Cavallini e Jacopo Torriti; la cappella fu voluta dalla famiglia Colonna per il Giubileo del 1300. Cappella di passaggio per la piazza del Campidoglio. In essa tomba di Cecchino Bracci disegnata da Michelangelo, tomba di Pietro Manzi, vescovo di Cesena, di Andrea Sansovino. Seconda cappella: alle pareti laterali affreschi del Pomarancio, in evidenza bel pavimento cosmatesco.
In essa una delle poche colonne dipinte al mondo, vi è raffigurata la Madonna con Bambino.
La chiesa era ed è famosa per il “Santo Bambino”, scultura in legno intagliata nel XV secolo con l’ulivo del Giardino dei Getsemani (uliveto fuori la vecchia Gerusalemme dove Gesù si sarebbe ritirato dopo l’Ultima Cena prima di essere tradito) e ricoperta di preziosi ex voto. Secondo la credenza popolare era dotata di poteri miracolosi e i fedeli gli chiedevano la grazia. La statua, trafugata a febbraio del 1994, non è stata più ritrovata. Al suo posto una copia.
Qui nel 1341 Petrarca ricevette l’alloro di poeta, qui nel 1571 il trionfo di Marcantonio Colonna dopo la battaglia di Lepanto (per l’occasione venne fatto il soffitto). Nel 2005 matrimonio fra Totti e Ilary Blasi. Nel 2013 matrimonio fra Valeria Marini e Giovanni Cottone, imprenditore; si sono separati un anno dopo. La Sacra Rota ha annullato il matrimonio perché Cottone era già sposato in chiesa.
UN QUARTIERE OPERAIO DIVENUTO VILLAGGIO CULTURALE
DELIMITAZIONE
Il rione si trova nella parte Sud del centro storico di Roma a ridosso delle mura Aureliane e del Tevere. Fa parte del I municipio del Comune di Roma. E’ delimitato da via Marmorata a Nord dal Tevere a porta San Paolo, dalle Mura Aureliane fino al fiume Tevere a Sud, dal fiume stesso sul lato Ovest. Ha la forma di un quadrilatero. E’ caratterizzato da un terreno pianeggiante (a parte l’altura artificiale del monte dei Cocci), ha una maglia stradale nel quale le strade si tagliano ad angolo retto Al suo interno si trova la vasta area dell’ex Mattatoio e da un’altra area artigianale tra via Galvani e le mura.
TOPONOMASTICA
I nomi delle strade sono riferiti a artigiani (Ginori, Bodoni, Manuzio, Mastro Giorgio), sono considerati tali anche gli artisti (Della Robbia, Ghiberti) o esploratori (Vespucci, Gessi, Antinori) sono accumunati a loro gli armatori Rubattino, Florio, oppure scienziati come Giovanni Branca, Galileo Ferraris, Beniamino Franklin, Galvani, Volta, Nicola Zabaglia. Oltre ovviamente ai toponimi: lungotevere Testaccio, via Marmorata, piazza dell’Emporio.
STORIA
Dal II secolo a.C. l’area dell’attuale rione fu utilizzata per accogliere la zona portuale della città. Questa venne costruita dai censori Lucio Emilio Lepido e Lucio Emilio Paolo, vista l’impossibilità di espansione del porto al Foro Boario (dove oggi è la Bocca della Verità).
Fu così costruito l’Emporio (193 a.C.), una lunga banchina paviemntata di 500 m di lunghezza della quale era agevole scendere al fiume. Alle sue spalle la porticus Aemilia, un portico che si estendeva dall’attuale via Marmorata a via Franklin, rappresentato nella Forma Urbis. L’imperatore Traiano provvide poi a far costruire altre strutture per lo più con la stessa funzione. Alle spalle di queste costruzioni portuali vi erano le sepolture, la più illustre è la piramide Cestia, poi inclusa nelle mura Aureliane.
Fra il II sec. a.C. e il III sec. d.C. può essere datato il monte Testaccio, formatosi con gli scarichi delle anfore frammentarie, esso rappresenta un ampio spaccato della vita economica di Roma.
Nel Medioevo la zona e la via Ostiense venne percorsa dai pellegrini che da San Pietro volevano raggiungere la basilica di San Paolo, restò disabitata, percorsa da processioni religiose e luogo di feste del Carnevale.
Nel Seicento tutta la zona era occupata da orti e vigneti, allora si cominciarono ad utilizzare le pendici del monte Testaccio come cantine per il deposito del vino. A partire dal Settecento, vicino alla Piramide Cestia venne creato un cimitero per accogliere chi non era Cattolico o apparteneva ad altre religioni. Solo nel 1821 tale area venne recintata.
La costruzione del gazometro nel vicino Circo Massimo nel 1852, fu il segno di una politica urbanistica, che voleva questa parte della città dedicata alla fabbriche e alle residenze degli operai. Tale politica venne confermata dal Regno d’Italia, con il 1870 Roma diventa capitale d’Italia. Nel 1890 sorse il nuovo Mattatoio, in sostituzione del precedente su via Flaminia, fuori porta del Popolo, la vicinanza con la linea ferroviaria Roma – Civitavecchia confermò questa destinazione industriale.
Nel 1879 vennero iniziate le costruzioni di otto isolati sul lungotevere, lungo via Marmorata, via Galvani e via Vanvitelli. Si trattava di edifici a due piani, oltre a piano terra, con cortile centrale molto ridotto, appartamenti di due / tre stanze comunicanti tra loro tramite ballatoio. Nel 1888-90 venne costruito il Mattatoio, nel 1905 venne sistemata a piazza un’area libera tra i palazzi che accolse subito il mercato rionale. Nel 1907 venne costruita la scuola IV Novembre in via Volta. Sorsero allora blocchi di edifici per l’Istituto Case Popolari, gli architetti furono Giulio Magni[1] (isolato tra le vie Volta, Zabaglia, Manuzio, Ghiberti), e Quadrio Pirani[2] (Lungotevere e Florio). Negli anni 1929-30 altri blocchi edilizi si devono a Innocenzo Sabbatini[3] (Marmorata / Vanvitelli) e Camillo Palmerini[4] (via Vespucci, ultimo intervento Icp).
Nel rione furono molto attivi i partiti antifascisti sia nel Ventennio, molto di più nei nove mesi di occupazione tedesca di Roma. A testimonianza di questa azione restano le lapidi e i monumenti presenti a porta San Paolo per la difesa di Roma l’8 settembre 1943. In via Marmorata 169, all’interno del palazzo abitato, una lapide ricorda i deportati del rione. All’interno dell’ex Mattatoio una lapide ricorda Italo Grimaldi (macellario, iscritto al Pci, arrestato il 23 dicembre 1943, abitante a Monte Sacro, fucilato a Forte Bravetta il 30 dello stesso mese), Antonio Righi (partigiano combattente di Bandiera Rossa, fu vittima del rastrellamento di Monte Mario del 26 ottobre 1943, con gli altri rastrellati fu portato in aperta campagna, costretto a scavarsi la fossa e mitragliato) e Francesco Celluprica (proprietario di una macelleria a piazza Re di Roma 4, abitava in via Cerveteri). Dagli anni Settanta/Ottanta il quartiere ha progressivamente cambiato volto, senza snaturarsi per la presenza delle case popolari, da quartiere popolare è diventato un villaggio culturale, uno dei centri della movida romana, anche per la presenza di molti locali notturni: osterie, ristoranti, pizzerie, birrerie, in genere tutti a buon mercato e di alcuni teatri (Vittoria, il più famoso tra i tanti). L’apertura della Scuola Popolare di Musica (1975) e del Macro Testaccio (2002) dentro una parte dei locali del Mattatoio ha contribuito a confermare questa tendenza.
ITINERARIO
PIAZZA SANTA MARIA LIBERATRICE
La piazza (già piazza dell’Industria) rappresenta il vero cuore del quartiere, sempre animata a qualunque ora del giorno, anche per la presenza dei giardini ora intitolati alla famiglia Di Consiglio[5] abitante del rione e sterminata nei campi di concentramento nazisti. Monumento ai caduti della prima guerra mondiale.
Ha forma triangolare, nel vertice si trova la chiesa parrocchiale, sul lato destro le case popolari di inizio secolo assegnate a carrettieri e operai del vicino mattatoio, lapide di circolo socialista risalente probabilmente agli anni dell’immediato dopoguerra (la sezione del PCI era in via Nicola Zabaglia), mentre ad angolo con via Romolo Gessi si trova la storica pizzeria “da Remo”.
Sul lato sinistro il teatro Vittoria, uno dei più famosi della città. Il teatro sorse ai primi del Novecento in una palazzina di due piani, si faceva il varietà, spettacoli senza troppe pretese, sul palco salirono attori del calibro di Aldo Fabrizi, Totò, Anna Magnani. Dopo la guerra l’edificio venne abbattuto, al posto del teatro sorse un cinema con platea e balconata. A costruirlo fu l’imprenditore Amati, proprietario di numerose sale a Roma. Sopravvisse fino alla fine degli anni Settanta. A maggio del 1986 iniziarono i lavori per trasformare il vecchio cinema in teatro di prosa. Attilio Nespegna, della cooperativa Attori & tecnici, incaricò l’architetto Enrico Nespegna dei lavori di adattamento. A dicembre aprì al pubblico con 560 poltroncine di velluto rosso, da allora non ha mai smesso di funzionare con compagnie prestigiose, grandi mattatori e produzioni della cooperativa stessa.
Sempre sul lato sinistro (civico 16) una lapide ricorda la casa in cui nacque e visse la cantante romana Gabriella Ferri[6]. Su quel lato si trova (civico 23) la libreria Testaccio, nella quale è stato girato il film “E’ arrivata la felicità” (2015) con Claudia Pandolfi (Angelica, titolare libreria, che abita in via Giovanni da Castel Bolognese) e Claudio Santamaria (Orlando, che abita al Flaminio in via Sacconi). Poco più avanti, ad angolo con via Mastro Giorgio, famosa gelateria artigianale. In via Giovanni Branca 88, sul lato della chiesa, ma di fronte ad essa, si trova Trapizzino, molto frequentata pizzeria a taglio che offre dei cartocci di pizza con una infinita varietà di riempimenti. Il locale è stato ideato da Stefano Callegari, proveniente da una famiglia di ristoratori romani, nel 2008. Nella vicina via Nicola Zabaglia si trova il bar pasticceria Linari, molto famoso e apprezzato nel rione e oltre.
CHIESA DI SANTA MARIA LIBERATRICE
E’ l’unica parrocchia di Testaccio. In stile romanico bizantino, eretta su progetto di M. Ceradini nel 1908 per i salesiani e le oblate di Tor de Specchi in sostituzione della chiesa barocca esistente fino al 1899 al Foro Romano demolita per mettere in luce i resti di Santa Maria Antiqua (primo santuario della Madre di Dio nel mondo).
Sulla facciata il mosaico, ricostruito nel 1925 dopo un rovinoso distacco, riproduce fedelmente un affresco in Santa Maria Antiqua. E’ una chiesa a tre navate con transetto e tiburio sull’incrocio delle navi. Completamente bianca. All’interno prevale uno stile floreale curato in ogni dettaglio, dalle balaustre ai pilastri, alle arcate. L’affresco del sec. XVI esistente sull’altare maggiore proviene dalla trecentesca chiesa di Santa Maria libera nos citata prima. Sul pavimento si trova un mosaico bianco e nero con riquadri alternati di motivi geometrici e segni zodiacali. La parrocchia è affidata ai salesiani.
Hai foto d’epoca di Santa Maria Liberatrice.
TEATRO VITTORIA
Il teatro risale ai primi del Novecento quando c'era solo la chiesa e le case popolari da poco costruite soprattutto per i dipendenti del vicino mattatoio. Gli spettacoli erano di varietà, poi di cinema e avanspettacolo. Aldo Fabrizi, Totò, Anna Magnani si esibirono in questo teatro. Nel secondo dopoguerra il teatro fu abbattuto e al suo posto sorse un condominio che al piano terra ospitava un cinema dell'imprenditore Amati che a Roma aveva molti cinema. Alla fine degli anni Settanta il cinema chiuse, nel maggio 1986 iniziarono i lavori per un nuovo teatro progettato dall'architetto Enrico Nespega. A dicembre 1986 il teatro aprì le porte al pubblico offrendo 560 posti a sedere.
Direttore artistico: Viviana Toniolo. Il teatro si qualifica per una programmazione molto differenziata: teatro classico, teatro di impegno sociale, spettacoli di artisti da circo, comici.
PIAZZA DI TESTACCIO
Si chiamava originariamente piazza Mastro Giorgio, come la via che la collega a piazza Santa Maria Liberatrice. E’ sempre stata occupata dal mercato rionale, uno dei più caratteristici di Roma, la sera veniva chiuso. Nell’angolo con via Mastro Giogio / Bodoni, ma nel perimetro del mercato, si trovava una grande edicola di giornali, il suo gestore Enrico Ferruggio, detto Righetto, era un personaggio molto popolare e simpatico nel rione, Rutelli lo definì il “Sindaco di Testaccio”, il sindaco Veltroni partecipò ai suoi funerali. Ad angolo con via Manuzio e via Luca della Robbia si trova la pescheria “Acquasalata” che la sera diventa un ristorante di pesce.
Al centro si trova la fontana di Testaccio, che fa riferimento alla caratteristica del rione, cioè il monte dei Cocci, è opera di Pietro Lombardi[7], venne inaugurata nel 1926, spostata in piazza dell’Emporio nel 1935 per dare spazio al mercato. L’inaugurazione del nuovo mercato di Testaccio il 2 luglio 2012, in sede coperta ha permesso la riqualificazione della piazza e il ritorno della fontana nel luogo originario domenica 25 gennaio del 2015. Il successo di questa fontana fece si che che l’artista ebbe incarico di progettare dieci fontanelle rionali.
L’idea è incentrata sul motivo dell’anfora che è il simbolo del rione in quanto fin dal II secolo a.C. in quest’area lungo il Tevere si trovavano magazzini di deposito e le anfore di terracotta per l’olio o il vino non potevano essere riutilizzati, dovevano essere distrutte, ecco sorgere il monte dei Cocci. Nel medioevo i cocci (in latino testae) diedero nome alla zona: Testaccio.
La fontana venne realizzata in travertino, presenta vari punti dove attingere l’acqua. Al centro di una piattaforma circolare posta in cima a sette gradini, sitrova un elemento vagamente conico composto da un ammasso di anfore addossate le une alle altre. Alla base della struttura l’acqua si riversa in quattro vasche rettangolari poste a croce rispetto al nucleo centrale, contro il quale appoggiano uno dei lati corti che si unisce all’elemento di centro con una voluta ornata da una testa di montone e dallo stemma cittadino. Lo spazio della piattafroma tra i bracci della croce è lasciato libero, tranne che agli angoli tra i bracci stessi occupati da quattro piccole vaschette.
IL BUCATINO
Si trova in via Luca della Robbia 84. La trattoria “Il bucatino – Via Luca della Robbia” è conosciuta, come dice il nome, per il piatto di bucatini alla Amatriciana, servito assieme ad un accessorio indispensabile: un bavaglino da indossare, per proteggersi dagli schizzi! Chi riesce a non sporcarsi, ha il diritto di portarsi a casa il bavaglino come ricordo!
Ma la trattoria è anche luogo di ritrovo degli artisti che lavorano nei numerosi teatri presenti nel quartiere (teatro Vittoria, La cometa, Antigone, Petrolini, etc.). Alla fine dello spettacolo serale, infatti, gli artisti si ritrovano a cena nella trattoria e, negli anni, hanno lasciato alle pareti le loro foto e autografi con dedica…alle buone pietanze mangiate quella sera.
MONTE TESTACCIO O DEI COCCI
E’ l’antico colle di Cocci, perché si è formato accumulando i rottami di anfore che venivano scaricati dai magazzini e dagli impianti adiacenti al porto fluviale dell’Emporium. Le anfore, non essendo smaltate all’interno, non potevano essere riutilizzate. Una discarica specializzata alta circa 36 metri (m 54 slm), con la circonferenza di base di un chilometro circa, si calcola che vi siano i resti di 53 milioni di anfore per la maggior parte olearie. Testae in latino vuol dire cocci, ecco perché il nome di Testaccio poi attribuito al rione. Esso rappresenta una sorta di “archivio” della storia commerciale ed economica della Roma tardo repubblicana e di buona parte dell’impero, appena esplorato nella parte superficiale (a parte i saccheggi di scavatori clandestini). Recenti studi hanno appurato che i materiali per ora noti sono quasi tutti appartenenti ad anfore olearie provenienti dalla penisola iberica (Andalusia), e dal Nord Africa, con marchi di fabbrica impressi su una delle anse e il nome dell’esportatore, la data consolare e altre notazioni dipinte sul corpo e databili per lo più tra il periodo augusteo e la metà del III secolo d.C.
Sul monte sale una strada che probabilmente ripete quella antica percorsa dai carri che scaricavano i rottami. E’ purtroppo chiusa al pubblico. Nel medioevo qui si svolgeva il carnevale con giochi crudeli come tauromachie e la ruzzica de li porci, dal Quattrocento il carnevale fu trasferito al Corso. Il colle divenne il punto di arriva della Via Crucis del Venerdì Santo, ancora oggi una croce ricorda tale tradizione. Tutto intorno le vecchie grotte, adibite a cantine o stalle, con una temperatura costante di 10° circa (la pianta di Roma del Nolli 1748 mostra come la situazione fosse analoga a quella attuale), sono state trasformate in locali dove prende corpo la vita serale dei giovani romani. Tra i tanti spicca un teatro.
Durante la seconda guerra mondiale una batteria antiaerea fu installata sulla cima del colle, resta la base in cemento di tale postazione.
MERCATO DI TESTACCIO
Lo storico mercato di Testaccio si trovava in piazza di Testaccio dove era stato parzialmente coperto e chiuso la sera. Ad angolo con via Mastro Giorgio – via Bodoni si trovava una grande edicola di giornali, il gestore era un personaggio assai popolare nel quartiere, ai suoi funerali partecipò anche l’allora sindaco di Roma Walter Veltroni. Al centro della piazza si trovava una fontana detta delle Anfore o di Testaccio, ma venne spostata al termine di via Marmorata, lungotevere a causa del gran numero di banchi del mercato. Un referendum nel quartiere ha scelto il progetto di riqualificazione della piazza stessa. Il 10 giugno 2012 è stato l’ultimo giorno di mercato in questo luogo.
Si trova tra via Luigi Galvani, via Beneamino Franklin, via Aldo Manuzio e via Lorenzo Ghiberti, occupa per intero il quadrilatero compreso tra queste strade. Si sviluppa su una superficie di 5.000 mq, con 103 banchi, un parcheggio sotterraneo, il progetto è dell'arch. Marco Rietti. Il nuovo mercato apre il 2 luglio 2012, è un museo mercato perchè al centro sono visibili gli scavi archeologici per 1.000 mq.
In quest’area archeologica non è una semplice esposizione ma, in essa è possibile seguire dei percorsi guidati al di sotto del mercato con magazzini di età romana, resti di un casale rinascimentale e i "villinetti" dello Iacp degli inizi del Novecento.
Il nuovo mercato è una struttura dove trionfano vetri aperti, ferro bianco e mattoncini in terracotta, ogni box per la vendita è di 20 mq mentre prima gli operatori avevano a disposizione banchi di 12 mq. L'idea è quella di una piazza aperta, non c'è un ingresso principale ma ben 22 entrate. L'uso della terracotta vuole indicare il radicamento nel territorio, Testaccio è la terra delle anfore, da cui il nome. Oltre ai pannelli solari vi sono ben 5.000 mq di vetri (da la Repubblica del 22 aprile 2012).
Interessanti i banchi di calzature con scarpe di qualità a prezzi interessanti e un banco che vende oggetti di design.
La provincia vi ha già aperto un Centro di Avviamento e Formazione al Lavoro che si chiama "Porta futuro". Al di sopra vi saranno residenze per studenti (da Paese Sera del 15 giugno 2011). Adesso è gestito dalla Città Metropolitana.
E' costato 18 milioni di euro, quattro anni di lavori (da la Repubblica del 2 luglio 2012).
Presso il mercato di Testaccio è stato realizzato il Giardino Domenico Pertica al di sopra di un parcheggio realizzato dal Comune nel 2008-2017. E’ stato realizzato in base ad un progetto di progettazione partecipata con i residenti, inaugurato nel giugno 2017.
Il giardino è dedicato allo scrittore e giornalista Domenico Pertica che ha dedicato tutta la sua vita a studi sulla storia di Roma (è autore di una Storia dei Rioni di Roma). Era un testaccino vero, in questo rione ha sempre abitato, anche se è nato a Palombara Sabina nel 1921. E’ stato ideatore del premio Simpatia, manifestazione ultra quarantennale che si tiene in Campidoglio. Era anche pittore e poeta, è stato amico di Fellini (ha recitato in “E la nave va” e “Amarcord”), De Sica, Argan, Antonello Trombadori, Livio Jannattoni e Moravia. E’ morto nell’anno 2000.
MATTATOIO. MACRO
Si trova in piazza Orazio Giustiniani che ricorda il poeta romanesco che qui abitava (1911-1919), dove venne ucciso. Fino al 1965 la piazza si chiamava “del Mattatoio”. Costruito nel 1888-90 dall’architetto Gioacchino Ersoch[8] sulla base delle nuove norme igieniche imposte dallo Stato. Si sviluppa su un’area di 25.000 mq compresa tra via Beniamino Franklin, dov’è l’ingresso principale e il lungotevere dove era il dazio per il controllo e il peso del bestiame.
Il Mattatoio è stato dismesso nel 1975 e sostituito da uno nuovo a Tor Sapienza (v.le Palmiro Togliatti). Dopo anni di abbandono, oggi una parte è adibita a facoltà di Architettura dell’Università di Roma Tre (dal 2000), un’altra parte ospita il MACRO (dal 2002 e 2006), museo di arte contemporanea di Roma, un’altra parte ancora è occupata dalla Città dell’Altra Economia (dal 2007). Nel complesso si è insediato il centro sociale Villaggio Globale. A partire dal 2002 qui si sono tenute le prime tre edizioni del Gay Village.
RISTORANTE CHECCHINO DAL 1887
Si trova difronte all’ingresso del Mattatoio in via di Monte Testaccio 30. Ha festeggiato i 130 anni di vita. Nato come rivendita di vini ricavata nelle grotte di Testaccio, il locale fu poi trasformato in un’osteria con cucina nell’anno in cui aprì il mattatoio, nel 1890. Gli operai ricevevano parte della paga in frattaglie e quinto quarto, ovvero gli scarti degli animali. Ingredienti che nelle cucine venivano lavorati e preparati in modo da diventare piatti saporiti. E’ ancora gestito dalla stessa famiglia delle origini. Il presidente Einaudi e l’attore Aldo Fabrizi erano frequentatori abituali. Qui sono stati inventati i rigatoni alla pagliata, la coda alla vaccinare e gli antipasti di zampetti e cervella oppure il famoso padellotto.
CIMITERO ACATTOLICO
Per l’Angelo del dolore vedi “Angeli su Roma”.
VIA NICOLA ZABAGLIA
La strada ricorda un maestro muratore, ingegnere e inventore del Settecento. A lui si deve l’erezione della colonna di Antonino Pio in piazza Colonna, ottenne uno spazio nella soffitta della navata centrale della basilica vaticana dove sistemò le sue macchine. Si può considerare il fondatore del corpo dei sampietrini. La sua figura è ricordata in alcune pasquinate.
Sullo lato opposto del cimitero inglese si trova una fontanina, detta Fontana del Boccale, realizzata da un gotto ornato anteriormente da quattro pilastrini in travertino. Realizzata da Raffaele De Vico nel 1931. Riproduce il boccale in uso sulle tavole popolari. La fontana ha un sedile in pietra disposto con andamento a semicerchio.
CIMITERO MILITARE DEL COMMONWALTH
Le tombe dei soldati inglesi o del Commonwalth sono tutte uguali con lapidi bianche, nell’area cimiteriale anche un piccolo mausoleo, in laterizio e protiro con due colonne sulla fronte.
CAMPO TESTACCIO
Questo è il campo storico nel quale la Roma giocò dal 3 novembre 1929 al 30 giugno 1940. Si trova lungo via Nicola Zabaglia presso la biblioteca Enzo Tortora del Comune di Roma (al civico 27). Venne costruito nel 1929 e prende il nome dal rione nel quale sorge, qui la Roma giocò 161 partite con 103 vittorie, 32 pareggi e 26 sconfitte.
L’impianto fu progettato dall’ingegner Silvio Sensi, padre di Franco (presidente del terzo scudetto della Roma), aveva quattro tribune in legno verniciate con i colori della squadra, aveva una capienza di 20.000 spettatori. L’impianto comprendeva l’abitazione dell’allenatore sul muro era dipinto un gigantesco stemma della squadra. Per vedere una partita si pagava dalle 30 alle 35 lire in tribuna coperta e via via a scalare fino ai popolari dove si pagava 5 o 6 lire, 50% di sconto alle donne. Era frequente vedere gruppi di spettatori sul Monte dei Cocci per vedere la partita dall’esterno senza pagare il biglietto. Lo stadio è rimasto nella memoria dei tifosi romanisti per la partita contro la Juventus del 15 marzo 1931 nella quale i romani vinsero 5-0, da qui è stato tratto anche un film “Cinque a zero”. Dopo la stagione 1939-40 lo stadio venne abbandonato perché la tribuna dei distinti cominciava a dare segni di cedimento, venne sostituita da una in cemento (i cui lavori durarono quasi un anno), ma nonostante ciò fu abbattuto il 21 ottobre 1940.
Il 27 novembre del 2000, alla presenza del sindaco Rutelli, del presidente Franco Sensi e di molti campioni del passato lo stadio è stato riedificato, di dimensioni ridotte ma dotato di un centro sportivo multifunzionale. I lavori di un parcheggio sotterraneo hanno comportato un decadimento della struttura, il problema a tutt’oggi non è risolto.
In via Lorenzo Ghiberti 55 si trova il Roma club Testaccio, è stato fondato nel 1969 in via Vespucci, poi si è trasferito in via Branca, quindi nella sede attuale.
PIRAMIDE
Fu costruita tra il 18 e il 12 a.C. come tomba di Gaio Cestio Epulone, è in calcestruzzo con cortina di mattoni e copertura di lastre di marmo di Carrara. E’ alta m 36,40 con base quadrata di circa m 30 di lato, ha una piattaforma cementizia di base.
Fu costruita in soli 330 giorni, forse meno, su volere testamentario di Gaio Cestio, altrimenti gli eredi avrebbe perso l’eredità. All’interno vi è un’unica camera sepolcrale di m 5,95 x 4,10 e alta m 4,80, solo 1% della cubatura, volta a botte, originariamente era murata, è dipinta di bianco con sottili cornici e figure decorative in stile pompeiano. Sulla parete di fondo doveva esserci il ritratto del defunto, ora c’è un buco praticato da scavatori abusivi in cerca di tesori.
Sui lati orientale e occidentale del monumento si trova l’iscrizione con il nome e i titoli di Cestio. Il monumento, ovviamente lungo l’Ostiense, aveva una recinzione in blocchi di tufo e quattro colonne agli angoli, rialzate nel cimitero inglese e due statue del defunto.
Sempre conosciuta e ammirata, anche Petrarca ne parla e la scambia per la tomba di Remo, sulla cima venne porto il prima parafulmine di Roma che ancora esiste.
Restaurata nel 2014 grazie al mecenate giapponese Yuzo Yagi con due milioni di euro, è stata reinaugurata il 21 aprile 2015 alla presenza del sindaco Ignazio Marino e del mecenate. Il restauro ha richiesto 327 giorni, ha rivelato sfumature rosate sui marmi che si estendono su una superficie di 2.264 mq, sono state necessarie 3.701 metri lineari di stuccature.
UFFICIO POSTALE DI ROMA OSTIENSE
Lo citiamo anche se non ricade nel nostro rione (ma nel rione Ripa) per l’importanza dell’edificio in sé e per completezza di informazione. E’ stato costruito nel 1933-35 su progetto di Adalberto Libera[9] e Mario De Renzi, è nel tipico stile razionalista. Presenta una soluzione interessante nella pensilina e nel salone per il pubblico, illuminato dall’alto da un tamburo in vetrocemento. “Anche dai dettagli risulta la straordinaria incisività geometrica dell’edificio”, Irene de Guttry, Guida di Roma moderna, De Luca editore, 1978, pag. 47.
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO
Si trova tra via Marmorata e via Luigi Galvani. Costruita tra il 1928 e il 1930 su progetto di Vincenzo Fasolo. Sull’angolo stondato si trovano sette grandi porte per il garage con piattabanda affiancate da semicolonne realizzate, come tutta la struttura in blocchetti di bugnato rustico. I capitelli sopra le colonne sono oranti al centro dalla raffigurazione di un elmo di pompiere. Tutto l’edificio e la torre oranta di beccatelli, rievoca una fortezza. Qui è conservato materiale dei vigili del Fuoco fra cui un’auto pompa a cavalli, scale, pompe a mano.
SCUOLA ELEMENTARE IV NOVEMBRE
Si trova in via Alessandro Volta. In stile eclettico, del 1907. L’ingresso ha un doppio porticato sostenuto da pilastri oltre il quale è il cortile. Notare l’ingresso maschile e quello femminile. E’ la scuola che compare nel film-tv “Provaci ancora prof” con Veronica Pivetti, nella finzione cinematografica è una scuola superiore.
PORTICUS AEMILIA
I resti maggiori si trovano in via Rubattino. “All’inizio del II secolo a.C. dovendo impiantare una nuova area portuale e commerciale, si impiantarono imponenti opere pubbliche cui si legano i omi di importanti gentes patrizie, tra questa la gens Aemilia. Nel 193 a.C. gli edili curli Marco Emilio Lepido e Lucio Emilio Paolo iniziarono la costruzione di un nuovo porto (Emporium) e di un retrostante edificio, tradizionalmente considerato un magazzino per lo stoccaggio delle merci, la Porticus Aemilia. La sua costruzione venne ultimata nel 174 dai censori Quinto Fulvio Flacco e Aulo Postumio Albino.
L’edificio misurava 487x60 metri ed era compreso tra leattuali vie Francklin, Marmorata, Branca e Vespucci. Lo spazio era diviso in 50 navate larghe 8,30 metri ciascuna, coperte da volte a botte e digrandanti verso il Tevere. Il pavimento era di terra battuta e l’alzato in opera incerta di tufo. Si tratta di uno dei più antichi casi di impiego di questa tecnica costruttiva. Dalla metà del I d.C. (in particolare in età traianea 98-117), furono realizzati interventi di restauro in opera mista di laterizi e blocchetti di tufo, connessi probabilmente alla necessità di rendere funzionali le grandi navate, suddividendole in vani più piccoli.
Una recente ipotesi, basata su considerazioni di natura epigrafica, topografica e costruttiva e su alcuni confronti greci di età ellenistica, identifica l’edificio con le antiche darsene militari sul Tevere (navalia), successivamente rifunzionalizzate e adibite allo stoccaggio delle merci.
Questi resti monumentali hanno caratterizzato nei secoli insieme il paesaggio del luogo e sono in buona parte riconoscibili lungo le vie Florio, Branca, Rubattino e Vespucci”. Tutto questo paragrafo è stato preso da cartello posizionato su via Rubattino a firma di A. Contino.
CASA DI ELSA MORANTE
Si trova in via Amerigo Vespucci 41, qui la scrittrice visse i primi dieci anni di vita (era nata in via Anicia a Trastevere). La lapide sulla parete esterna recita: “In questa casa ha abitato una straordinaria scrittrice italiana Elsa Morante. Una mente visionaria / un profondo sentimento del dolore / una viva complicità con gli umili / capace di trasfromarare la storia in mito / la vita in favola crudele e misteriosa. Anno 2004”. Lapide posta dal Comune di Roma, sindaco Veltroni, assessore alla cultura Gianni Borgna.
Elsa Morante era nata a Roma nel 1912 da una maestra elementare ebrea e un padre anagrafico istitutore in un riformatorio per minorenni (la madre era sposata con un impiegato delle poste). Alla fine del liceo va a vivere per conto proprio ma la mancanza di soldi la costringe ad abbandonare l’università. Dà lezioni private, collabora a riviste e giornali, scive per altri tesi di laurea. Nel 1941 sposa Alberto Moravia (presentatogli dal pittore Giuseppe Capogrossi) al quale rimane legata fino al 1962 abitando in via dell’Oca, è morta nel 1985, è considerata una delle più importanti autrici di romanzi del dopoguerra, prima donna a vincere il premio Strega. Le opere più celebri sono: “Menzogna e sortilegio” 1948, “L’isola di Arturo” 1957, “Il mondo salvato dai ragazzini” 1968, “La storia” 1974, “Aracoeli” 1982. Dopo questo libro scoprì di essere ammalata e tentò il suicidio, fu salvata dalla governante, morì di infarto nel 1985. Tutti i suoi manoscritti sono conservati nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Nel cortile interno del palazzo una seconda targa recita: “Solo chi ama conosce”.
Proprio a pochi metri da qui vagabodavano i protagonisti del romanzo “La storia”: Useppe e la sua compagna inseparabile, la cagna Bella, in libera uscita nel quartiere, nella primavera estate del 1947.
IL CREMLINO
E’ chiamato così il grande edificio che si trova in piazza dell’Emporio, tra il lungotevere e via Marmorata, ha questo nome “Cremlino”, il palazzo sede della storica sezione del Pci, che possedeva tutto il primo piano. Compare anche nel film di Moretti, la Cosa (1990). E’ anche chiamato palazzo dell’INA, è in stile neo-barocco, sulla piazza si aprono una successione di terrazze.
Vi abitano Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Enrico Letta (capo del governo dall’aprile 2013 a febbraio 2014) e Giuliano Ferrara (giornalista e ministro nel primo governo Berlusconi).
Nel 1923, scavando le fondamenta del palazzo, venne trovata una grande statua femminile che è stata definita, per la presenza dell’egida sul petto, Minerva. Ora si trova a palazzo Altemps. In quest’area si rinvennero anche due iscrizioni con dediche a Mercurio e ad Apollo, nel 1886 venne recuperata una base frammentata dedicata ad Apollo di età augustea, è ora conservata nei musei Capitolini.
Al centro di piazza dell’Emporio si trovava la fontana di Testaccio, ora sostituita da un’aiuola con giovani cipressi. Sporgendosi dal lungotevere, o meglio dal ponte, guardando a valle, verso la sponda sinistra si vedono i resti del porto romano imperiale.
PONTE SUBLICIO
Venne costruito nel 1918 su progetto di Marcello Piacentini[10] (tra le sue prime opere), unisce il rione di Testaccio al rione Trastevere (Porta Portese). E’ un ponte a tre arcate a sesto ribassato, in laterizio, le ghiere delle arcate e le spallette sono in travertino. Il nome ricorda l’antico ponte che si trovava poco a valle dell’isola Tiberina che la leggenda vuole costruito da Anco Marzio (Tito Livio e Dionigi di Alicarnasso). Il nome deriva dalla lingua dei Volsci, vuol dire ponte di tavole in legno. Al ponte è collegata la leggenda di Orazio Coclite. Di tale ponte rimasero delle tracce fino al 1890, quando furono demolite nelle opere di sistemazione del fiume e come misura di prevenzione delle piene.
VIA MARMORATA
Il nome gli deriva dai grandi depositi di marmi e pietre che giungevano a Roma via Tevere. La strada ripercorre il percorso dell’antica via Ostiensis (che usciva dalla porta Trimigemina delle mura Serviane, tra Aventino e Tevere), fino al 1920 il toponimo si riferiva anche a lungotevere Aventino. Secondo la leggenda (Eneide VIII libro) in questo luogo avvenne lo sbarco di Enea e l’incontro con Evandro.
Arco di San Lazzaro. Era un arco di accesso all’Emporium. Il popolo lo denominò Arco di Orazio Coclite, perché creduto vicino a ponte Sublicio e alle vicende dell’eroe romano. Verso il Quattrocento l’arco è l’unico passaggio di un vicolo di campagna percoso dai pellegrini diretti alla basilica di San Paolo fuori le mura. A questo arco era appoggiata una cappella dedicata a San Lazzaro, protettore dei lebbrosi dove si raccoglievano elemosine per il lebbrosario che era fuori porta Angelica, sulla via Trionfale, alle pendici di Monte Mario. Non era un ospedale per lebbrosi, questi erano ben lontani dai centri abitati. Nel rinascimento l’arco viene chiamato delle “Sette Vespe” o Vespilloni, di tale nome non sappiamo dare spiegazione, forse era riferito ad una decorazione araldica.
I primi palazzi che vediamo sulla destra sono di Innocenzo Sabbatini.
Palazzo in via Marmorata 169. Nel cortile interno si trova un asilo nido comunale (Casa dei Bambini) e al centro del giardino una lapide ricorda: “Per ridare all’Italia libertà e giustizia / Adolfo Caviglia / Cesare Tedesco / caddero alle Fosse Ardeatine / vittime della ferocia nazifascista / Guglielmo Caviglia, Lazzaro di Porto, Davide Moresco, Mario Milano, Mario Natili / morirono in campo di concentramento in Germania / il loro sacrifcio sia di ammonimento / i condomini memori / 20-21 settembre 1947”. Uno dei segni più chiari della presenza antifascista nel rione.
Prima di arrivare all’incrocio con via Galvani, al civico 39, ecco il noto ristorante Perilli, aperto nel 1911, che offre piatti tipici della cucina romana. Nell’interno vedute di Roma del 1960 di Fernando Corsi di Genzano.
In fondo a via Marmorata, angolo via Caio Cestio, si trova una palazzina, nel cortile interno si conserva la facciata della polveriera, dove si esercitavano i militari addetti ai cannoni di Castel Sant’Angelo.
PONTE TESTACCIO
Venne costruito nel 1948 (ma i lavori erano iniziati dieci anni prima) su progetto di Cesare Pascoletti, unisce il nostro rione al quartier Portuense (lungotevere Portuense). E’ il primo ponte sul Tevere ad essere costruito dopo la II guerra mondiale. E’ lungo 121,91 metri e largo 31,3 m, ad una sola arcata. Su tale ponte è stata girata la scena finale del film “Accattone” (1961) prima opera di Pierpaolo Pasolini, in tale scena il protagonista muore cadendo dalla moto sulla qule fugge inseguito dalla Polizia (Franco Citti).
LUNGOTEVERE TESTACCIO
All’altezza di via Florio si trova una fontana (detta di Pio IX) che è stata qui sistemata durante il pontificato di Pio IX. E’ formata da una quinta in laterizio con i lati evidenziati da travertino a bugnato raccordati alle spallette del lungotevere e sormontati da due sfere sempre in travertino. L’acqua che esce da una protome leonina finisce in una vasca costituita da un sarcofago strigilato e con tabula al centro. Questa fontana, sormontata dallo stemma pontificio, ha murata una lapide che ricorda i ritrovamenti archeologichi voluti dal pontefice. E’ stata restaurata nel 1993 e nuovamente nel 2000 a seguito di un intervento vandalico che aveva danneggiato il sarcofago.
LOCALI DI TESTACCIO
Intorno al Monte dei Cocci: Checchino dal 1887, Trentatre Ristorante, Pecorino, L’Alibi, Coyote bar, Conte Staccio, Radio Londra, Ristorante Charro, Caffè Latino, Flavio al Velavevodetto, Osteria degli amici.
In piazza Testaccio: Acqua salata, pescheria di giorno, ristorante di pesce la sera; L’oasi della Birra, Il cantinone (trattoria pizzeria di specialità romane, aperta nel 1955, ambienti retrò, atmosfera conviviale), Felice (in via Mastro Giorgio 29, trattoria moderna dalle pareti di mattoni e legno, con una specialità romana per ogni giorno della settimana) e Silvana.
In via Luca della Robbia: Dal Bucatino.
In piazza Santa Maria Liberatrice: Da Remo, popolare e affollato dagli arredi spartani con pizza romana cotta la forno e fritture.
In via Americo Vespucci: Nuovo Mondo, la pizzeria frequentata da Enrico Letta e famiglia.
IL QUARTIERE NEL CINEMA
Il rione è stato spesso protagonista al cinema. Ricordiamo il film “I soliti ignoti” del 1958 di Mario Monicelli, candidato al premio Oscar come miglior film straniero. Uno dei protagonisti Cosimo, interpretato da Memmo Carotenuto, tenta uno scippo ai danni di una vecchietta (via Franklin – Manuzio), ma va male, viene inseguito, scappa e finisce sotto un tram che proviene da via Galvani e lo investe all’incrocio con via Franklin. La zona non è facilmente riconoscibile perché ci sono i cosiddetti “villinetti”, caseggiati abbattuti poco dopo. Tuttavia l’indizio ce lo fornisce la scritta “Da Checchino”. In via Franklin si svolge la scena iniziale del film “Così parlò Bellavista” (1984) di Luciano De Crescenzo, ma con i villinetti ormai scomparsi. Un film che esalta la napoletanità è stato girato a Testaccio. L’ufficio postale Ostiense di via Marmorata è protagonista nel film “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” (1970, premio Oscar l’anno successivo) di Elio Petri con Gian Maria Volontè. Sempre l’ufficio postale è presente nel film “Brutti, sporchi e cattivi” (1976, vincitore del festival di Cannes) di Ettore Scola nel quale avviene la scena esilarante del ritiro della pensione della nonna. Sul retro dell’ufficio postale, nel parco, i due protagonisti de: “Le fate ignoranti” (2001) di Ferzan Ozpetek, cioè Margherita Buy e Stefano Accorsi, mangiano con gioia un cono gelato. La fontana delle Anfore, quando era in piazza dell’Emporio è protagonista del film “La finestra di fronte” sempre di Ozpetek di due anni dopo con Raoul Bova e Giovanna Mezzogiorno. Il romanzo La Storia di Elsa Morante ha avuto una sua trasporizione cinematografica nel 1986 ad opera di Luigi Comencini (film della TV). Nel romanzo la famiglia protagonista proviene da San Lorenzo (distrutta dal bombardamento) e va a vivere in una camera ammobiliata in via Mastrogiorgio, poi si trasferisce in via Bodoni. Il primo film della serie “Fantozzi” (1975) con Paolo Villaggio, l’abitazione del protagonista è in via Giovanni Battista Bodoni 79. Ma anche “Fantozzi contro tutti” (1980), terzo film della serie. Ancora nel film “Fracchia la belva umana” (1981) la casa del ragionier Giandomenico Fraccia è in lungotevere Testaccio 11. La serie televisiva “E’ arrivata la felicità” del 2015 con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria vede la libreria della protagonista, Angelica, in piazza Santa Maria Liberatrice, libreria che esiste realmente.
Un utilizzo anomalo dell’ex Mattatoio è stato operato nel film “La leggenda del pianista sull’oceano” (1998) di Giuseppe Tornatore. E’ la storia di un pianista, nato su una nave e che decide di rimanervi tutta la vita. La nave, la Virgin, si trovava nel porto di Odessa e lì hanno girato per cinque settimane, quindi venne ricostruita , alta 35 metri insieme al porto di new York, la sagoma della nave si poteva vedere da vari punti della città. La sala da ballo del piroscafo era negli studi di Cinecittà.
AGGIORNAMENTI
29.11.13 # Testaccio. Il I municipio ricorre al TAR per far rivivere il cuore giallorosso della città dal 1929 al 1940 il mitico campo Testaccio in via Nicola Zabaglia. Oggi è in abbandono, le tribune ricoperte di rovi e erbacce, il centro del campo coperto da materiale da cantiere. Doveva sorgere qui un parcheggio (PUP 2006, approvato 2009), non se ne è fatto nulla. Lo si vuole riqualificare in centro sportivo aperto al quartiere, intitolarlo a Amedeo Amadei.
10.10.13Testaccio. Monumenti. Restaurato la Porticus Aemilia. Diventerà un giardino nel cuore del quartiere dall’estate tra via Vespucci e via Rubattino. Un gigantesco edificio in 50 navate di età repubblicana con funzione di magazzino del porto. Anche il reale istituto neerlandese ha collaborato alle indagini archeologiche.
17 ottobre 2014. Sul Venerdì di Repubblica articolo dal titolo “Le sette vite di Testaccio” a firma di Giuliano Malatesta con foto di Guido Fuà. Sottotitolo: “Da quartiere malfamato a nuovo Village della capitale. Tra gastronomia, consumi, cultura, viaggio, in un rione che si è imborghesito senza snaturarsi e dove l’unica cosa indiscutile resta la Maggica Roma”. Il Roma club di Testaccio si trova in via Ghiberti.
Si parla dell’edicola ultracentenario di piazza testaccio abbandonata, gestita da Enrico Ferruggio detto Righetto che stendeva i giornali come lenzuoli, Rutelli lo chiamò “il sindaco di Testaccio”. Si fa riferimento al libro di Irene Ranaldi Gentrification in parallelo per le ed Aracne dove sono messi a confronto Testaccio con Astoria quartiere greco di New York. La presenza delle case popolari ha preservato il quartiere da cambiamenti bruschi. Sul finire degli anni Settanta nascono la Scuola Popolare di Musica, il teatro Spazio Zero e Nicolini inserisce il campo boario nell’estate romana. In via Vespucci c’è il bar Giolitti. La Roma giocava al campo Testaccio. Soprattutto il cibo come oggetto del desiderio, vedi Perilli e Felice. La moda del cibo di strada, anche nel nuovo mercato coperto. Da Linari si passa per un caffè. Il Cremlino, il palazzo sede della storica sezione del Pci anche nel film di Moretti, la Cosa.
Vi abitano Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Enrico Letta e Giuliano Ferrara. Una biblioteca intitolata a Enzo Tortora, teatri e il macro.
22.05.16 Testaccio.Presto lavori straordinari in via Galvani, la via della movida di Testaccio, 700.000€ per rifare asfalto, bordature in selce intorno agli alberi, le caditoie e la segnaletica. Lavori del municipio.
25.5.16 Testaccio.Città dell’Altra Economia a rischio sfratto perché alcune licenze sono state subaffittate. La convenzione risale al 2012. Gli abusi riscontrati in una ispezione a sorpresa del 25 aprile.
24.12.16 Testaccio. Impegno del I municipio per la riqualificazione del Campo Testaccio, lo storico impianto nel quale ha giocato la Roma per tanti anni.
22.1.17 Testaccio. Scuola popolare di Musica compie 40 anni. All’ex Mattatoio inaugura oggi “Musica &Musica” jam session e concertini fino al 26 febbraio. La scuola nacque nel 1975 quando un grupppo di musicisti occupò un locale abbandonato in via Galvani. E’ la prima di una serie di scuole di musica popolare che diffondono il jazz e il blues. Hanno seguito: la Scuola Popolare di Musica di Donna Olimpia (anche folk, dal 1975), la Scuola del Saint Luois poi diventata College of Music (importante per la didattica musicale, molto seguito il corso di musica elettronica, regia e tecnologie del suono), la Mississippi Music School che ha sede a Borgo Vittorio attiva con corsi di Rock, blues e fazz per bambini, ragazzi e adulti, e molte altre. Pioniera è stata Giovanna Marini. Sono emersi musicisti che ora dominano la scena jazz italiana
11.2.17 # Testaccio.Il ristorante Checchino dal 1887 festeggia oggi i 130 anni. Nato come rivendita di vini ricavata nelle grotte di Testaccio, il locale fu poi trasformato in un’osteria con cucina nell’anno in cui aprì il mattatoio, nel 1890. Gli operai ricevevano parte della paga in frattaglie e quinto quarto, ovvero gli scarti degli animali. Ingredienti che nele cucine venivano lavorati e preparati in modo da diventare piatti saporiti. E’ ancora gestito dalla stessa famiglia delle origini. Il presidente Einaudi e l’attore Aldo Fabrizi erano frequentatori abituali. Qui sono stati inventati i rigatoni alla pagliata, la coda alla vaccinare e gli antipasti di zampetti e cervella oppure il famoso padellotto.
2.4.17 Campo Testaccio. L’ass. allo sport Frongia ha dichiarato, al margine di una iniziativa sportiva a Ostia, che non si trovano le chiavi dell’area del campo Testaccio per procedere alla bonifica dello stesso.
7.5.17 Testaccio. Teatro Vittoria in vendita.Tre milioni di euro per 1160 mq suddivisi tra platea e galleria, 560 poltroncine rosse, per la cooperativa “Attori e tecnici” potrebbe essere constretta ad andare via, è lì dal 1984. I proprietari sono Vittoria Amati, storica dinastia romana di proprietari di cinema.
13.5.17 Cronaca. Esplosione vicino all’ufficio postale di via Marmorata. Si pensa ad un atto dimostrativo degli anarchici. Un ordigno rudimentale posizionato nel parcheggio, sotto un’auto di servizio partita cinque minuti prima. Da lì passa la corrispondenza destinata al Parlamento, nell’ufficio c’è sempre un artificiere. Nessun ferito, danneggiata una auto.
23.5.17 Testaccio. Nell’area del campo Testaccionon si farà il parcheggio sotterraneo, lo ha detto l’ass. ai trsporti Linda Meleo. Ora con la delibera di giunta sarà la società Consorzio Romano Parcheggi, a restituire l’area come era.
31.5.17 Dopo l’ultima partita giocata all’Olimpico, i tifosi dedicano piazza Santa Maria Liberatrice a Francesco Totti con una lapide finta. La foto di Totti sotto la lapide stradale è sulla pagina facebook del capitano.
4.7.17 Testaccio. La casa di Fantozzi è in via Bodoni 79. Notizia per la scomparsa di Paolo Villaggio.
[1] Giulio Magni (Velletri 1859 - Roma1930) Figlio di un noto storico dell'arte, ha operato in Romania. Case popolari a lungotevere Testaccio nel 1905-06, Facoltà teologica Valdese a via Cossa nel 1907-09, Case popolari a santa Croce in Gerusalemme nel 1907-15, Villa Marignoli a via Po nel 1910, Ministero della Marina Militare al lungotevere nel 1919-28, Chiesa Regina Pacis a Ostia nel 1924-28. La biblioteca di Velletri conserva il suo archivio. Partecipò al concorso per la GNAM.
[2] Quadrio Pirani (Jesi 1878 – Roma 1970) L'architetto che ha progettato il rione San Saba nel 1911-13, a collaborato alla Città Giardino Aniene (oggi Monte Sacro) e le case Incis di via Chiana - via Tagliamento - via Chiana a partire dal 1925.
[3]Innocenzo Sabbatini (Osimo 1891-Roma1984) Case alla Garbatella in piazza Brin nel 1920, il Cinema Garbatella oggi teatro Palladium nel 1927, La casa dei bambini in via di Lauria nel 1924, quartiere ICP via Andrea Doria, casa ICP in via della Lega Lombarda, gli alberghi suburbani alla Garbatella, le case ICP in via Oslavia e in via Marmorata tra il 1927 e il 1930. E' stato presidente dell'Icp dal 1925 al 1931. Ha progettato il Palazzo Pubblico sulla piazza di Montesacro. Palazzo in piazza dell’Alberone.
Da De Guttry. Per "Archivio Storico Iacp" l'architetto è morto a Osimo nel 1983. E' autore delle case che affacciano su via Marmorata a Testaccio ang. via Vanvitelli. TrionfaleII, lotto I, prospetto sulla via R. Di Lauria.Trionfale III, cinematografo su via Andrea Doria. Trionfale III, lotto VII. Progetto Piazza d'Armi I via Monte Santo, Sabotino, Plava, Montenero, viale Angelico.Progetto per la piazza della città giardino Aniene. Progetto Tiburtino II Portonaccio in piazza Pontida via Adalberto.Progetto Tiburtino II Sant'Ippolito in via della Lega Lombarda (citato sopra).Palazzina sul Gianicolo in via Dandolo. Progetto Pamphili I, via di Donna Olimpia, anno 1930.
[4] Camillo Palmerini (Roma 1893 - 1967) Case Icp a Ostia in corso Duca di Genova nel 1929, di fronte alla scuola Fratelli Garrone di Ignazio Guidi. Da: De Guttry.
Per il testo "Archivio storico iconografico dell'IACP" ha progettato le case popolari a Testaccio con fronte su via Vespucci tra gli anni 10 e 20; la Borgata Giardino Garbatella, lotto XII, fabbricato 5 in via F. Passino; lotto XIII tipo T, fabbricato 4 di via F. Vettor; Progetto Appio I in piazza Tuscolo, via Soana, via Astura; Progetto Appio II in via La Spezia; Progetto Ponte Lungo II, lotto I B fabbricato 1 in piazza dell’Alberone
[5] Di Consiglio. Una famiglia ebrea romana trucidata dai nazisti nel 1944. Romani da molte generazioni erano venditori ambulanti e macellai. Il padre Mosè e la moglie Orabona avevano dieci figli. Sei di loro furono fucilati alla Fosse Ardeatine, altri portati ad Auschwitz. Della famiglia Di Consiglio ben 26 persone sono state uccise dai nazisti, tra questi 11 bambini. Il delatore è stato individuato e ha subito un processo dopo la guerra. Giulia Spizzichino è stata tra i più attivi tra i familieri al processo Priebke.
[6] Gabriella Ferri. Roma 1942 – Corchiano VT 2004 cantante di musica leggera, nota per le interpetazioni di canzoni popolari romane e napoletane, oltre che attrice teatrale.
[7] Pietro Lombardi. (Roma 1894-1984) Da guida rossa del Tci, pag. 889. Collaboratore di Armando Brasini e Marcello Piacentini. Coautore con Vittorio Cafiero della caserma di viale Romania, ha costruito diverse palazzine ai Parioli e cappelle al Verano. Da: Claudio Rendina (a cura di) Enciclopedia di Roma, Newton, 2005, vol. II, pag. 648. Diplomato architetto all’Accademia di Belle Arti di Roma, fu architetto capo dell’isola di Rodi quindi professore all’Accademia di Belle Arti di Roma per 11 anni. Ottenne premi e riconoscimenti in numerosi concorsi ai quali partecipò. Realizzò scenografie per i film come Quo Vadis?
[8] Gioacchino Ersoch (Roma 1815- 1902) architetto dell’ufficio edilizio del Comune di Roma, diresse i lavori di consolidamento di palazzo Fiano al Corso nei quali vennero ritrovate le sculture dell’Ara Pacis, si dedicò a progetti per mercati rionali coperti, l’unico realizzato quello in piazza Monte d’Oro, progettò il mercato del Pesce in via San Teodoro (1876-79), poi autorimessa comunale, poi mercato a Km 0. Autore anche dell’idrocronometro del Pincio e del serbatoio idrico del Pincio mascherato da padiglione svizzero. Realizzò apparati provvisori per le girandole di Castel Sant’Angelo e altri spettacoli pirotecnici. Progettò la tomba di Vittorio Emanuele II al Pantheon, di Michelangelo Caetani in Santa Maria degli Angeli, partecipò al concorso per il Vittoriano. Intervenne nel teatro Argentina, interventi sostituiti da Piacentini.
[9]Adalberto Libera. (Villa Lagarina TN 1903 – Roma 1963) Villini in piazzale Magellano a Ostia nel 1932, palazzo Postale in via Marmorata nel 1933, palazzo dei Congressi all'Eur nel 1942, quartiere INA Casa Tuscolano Unità di abitazione orizzontale nel 1951, cinema Airone in via Lidia con Calini e Montuori, il Villaggio Olimpico con altri nel 1960, il quartiere di Casal Palocco con altri nel 1965, il quartiere INCIS di Decima con altri.
La cattedrale di Cristo Re dei Secoli a La Spezia nel 1968 e la villa Malaparte a Capri nel1938.
[10] Marcello Piacentini. (Roma 1881-1960) Figura controversa nella storia dell’architettura a causa del forte legame con il regime fascista, la sua opera è oggetto di rivalutazione critica solo da pochi anni. Alcune sue opere: ponte Aventino nel 1917, cinema Corso in piazza San Lorenzo in Lucina nel 1915, palazzo per la Banca d'Italia in piazza del Parlamento, nel 1920 pianificazione della Garbatella con Giovannoni, teatro Quirinetta in via Minghetti, hotel Ambasciatori a via Veneto con Vaccaro, Casa Madre dei Mutilati in piazza Adriana, cinema Barberini nella piazza omonima, nel 1932-35 pianificazione della Città Universitaria con il palazzo del Rettorato e della biblioteca Alessandrina, chiesa di Cristo Re in viale Mazzini nel 1924-34, il palazzo della Banca Nazionale del Lavoro a via Veneto, sventramento della spina dei Borghi, piano regolatore dell'E42 con Auditorium in via della Conciliazione, cinema Fiamma, chiesa della città universitaria, teatro Sistina, nuova facciata del teatro dell'Opera, palazzo dello Sport all'Eur con Pier Luigi Nervi
Porti Di Roma
Di seguito i link ad alcuni siti per vedere foto e informazioni sui porti di Roma.
Per quanti, invece, volessero “navigare” nell’ampio tema delle inondazioni del Tevere (ultima delle quali nel 1870) suggerirei una visita al seguente sito Web che, con foto d’epoca e planimetrie di Roma, fa luce sul problema delle inondazioni, o per meglio dire esondazioni, che aveva come soluzione anche quella di realizzare a Nord dei Monti Vaticani uno scolmatore che circumnavigasse Roma fino a confluire nel Tevere alla Magliana:
Le Inondazioni del Tevere
Pagina 1 di 2